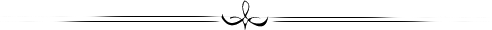Suite Masquè di Codivilla
(/viewuser.php?uid=143660)
Disclaimer: Questo testo proprietà del suo autore e degli aventi diritto. La stampa o il salvataggio del testo dà diritto ad un usufrutto personale a scopo di lettura ed esclude ogni forma di sfruttamento commerciale o altri usi improri.
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** I - Prélude ***
Capitolo 2: *** II - Minuet à deux ***
Capitolo 3: *** III - Moresque ***
Capitolo 4: *** IV - Habanera ***
Capitolo 5: *** V - Ouverture ***
Capitolo 6: *** VI - Fugue I ***
Capitolo 7: *** VII - Entr'acte ***
Capitolo 8: *** VIII - Requiem ***
Capitolo 1
*** I - Prélude ***
|

I - Prèlude
Un Preludio è generalmente un brano piuttosto breve,
collocato all'inizio di una composizione,
o di una sua parte.
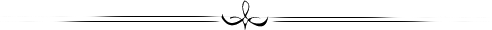
Respiri. Ansiti affannosi nella penombra di quella stanzetta umida. A far luce sullo squallore del posto, solo un’acciaccata luce al neon che ronzava, sommessamente, accendendosi e spegnendosi in continuazione, rendendo ancor più spettrale l'ambiente spoglio e malandato.
Mya non percepiva altro che quel ronzio unito al ritmico sibilare dell’aria che oltrepassava le sue narici, fin dentro i polmoni, per poi trovare un varco d’uscita fra le sue labbra. Fredda, tanto da graffiarle la gola già provata dalle inutili grida d’aiuto che aveva emesso fra le lacrime. Respiri sincroni con i battiti frenetici del suo cuore, che rimbombavano cupi nel petto. Le pareva che potesse esplodere da un momento all’altro.
Dette uno strattone nell’ennesimo tentativo di sciogliere i lacci che le imprigionavano i polsi. Sapeva già che sarebbe stato vano, testimoni ne erano le escoriazioni dolenti che marchiavano la pelle diafana, al di sopra delle mani, nel punto in cui il cuoio era più stretto.
«Inutile agitarsi tanto, piccola Mya».
Nuovi respiri, alle sue spalle, più lenti e rilassati. Quella voce era melodiosa e pacata, allegra come se lui si divertisse un mondo. Passi pesanti accompagnavano l’incedere del suo rapitore verso di lei. Si accasciò impotente, rilassando le spalle e le braccia intrappolate dietro lo schienale della sedia alla quale era legata ormai da ore.
Sentì le sue mani sfiorarle la pelle del collo e scendere poi sulle spalle, lentamente, sopra la stoffa della camicia di seta bianca, fino ai fianchi. Come un amante che abbracciasse la sua donna. Una donna legata e incapace di reagire. Avrebbe desiderato voltarsi, per guardarlo in faccia, per vomitargli addosso tutto l’odio che provava nei suoi confronti; ma non poteva far altro che starsene lì, tesa come una corda di violino, un giocattolo nelle sue grinfie. Ma nonostante lui fosse alle sue spalle, lei si immaginava con esattezza l’espressione che lui aveva sul volto, in quel momento. Un ghigno di vittoria, come quello che aveva sfoggiato quando, ore prima, lei si era risvegliata già intrappolata, trovandoselo di fronte.
Lui si mise a giocherellare con le corde che le stringevano la vita, bloccandola tenacemente alla sedia, e avvicinò le labbra al suo orecchio.
«Potrei anche liberarti. Ma non sarebbe più un bel gioco, poi» sibilò, suadente.
Mya deglutì, serrando le palpebre. Si costrinse a non pensare a quello che sarebbe successo, e alle mani di lui che adesso accarezzavano il suo ventre, sfacciate ed arroganti.
«Bastardo. Mi fai schifo» disse soltanto, in un filo di voce roca.
Lui ridacchiò mordendole l’orecchio. Lei si ritrasse istintivamente, scostando il capo.
«Una ragazza di classe come te non dovrebbe esprimersi in questa maniera, piccola Mercer».
Un rapido sibilo metallico fendette l’aria. Sul collo, all’altezza della carotide, Mya percepì improvvisamente il freddo della lama di un coltello che premeva sulla sua pelle. I battiti del suo cuore accelerarono, finché divenne impossibile distinguerli l’uno dall’altro. Trattenne il fiato. Le labbra tumide e rosse, socchiuse, tremavano adesso senza che potesse far nulla per fermarle.
«All’inglesino dispiacerà sapere che ti ho dato una bella ripassata, prima di farti fuori».
Quella voce era adesso soltanto un lieve mormorare, basso, pacato, ma intriso di una sorta di perversa eccitazione. La pressione della lama si fece leggermente più forte e minacciosa.
«E credimi, farò di tutto perché lui lo sappia».
Un brivido percorse l’intera lunghezza della sua schiena quando lui le morse nuovamente l’orecchio, respirando sul suo collo e sfiorandone la pelle con la lingua.
Mya singhiozzò sommessamente.
Un’ultima lacrima le rigò la guancia, spegnendosi sulle sue labbra.
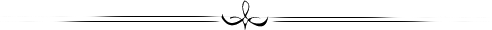
ANGOLO AUTRICE:
Una nuova storia che ho iniziato a scrivere di getto.
Un prologo che immagino nessuno si aspettasse data la trama della storia.
Spero di riuscire a creare qualcosa che possa interessare
ma soprattutto di riuscire a mettere insieme tutte le idee che ho in testa!
Il racconto è romantico ma... chissà.
Chi vivrà, vedrà.
Vi lascio recapiti vari per contatti/insulti/complimenti (?)/rotture di scatole:
Pagina Facebook: Codivilla Vicariosessantanove Efp
Gruppo Facebook: La Canonica del Vicario
Ask: Chiedi e (forse) ti sarà detto
Alla prossima e grazie a chiunque passi di qui.

|
|
Ritorna all'indice
Capitolo 2
*** II - Minuet à deux ***
|

II - Minuet à deux
Il Minuetto di corte veniva danzato, solitamente, da una sola coppia.
Cominciava con una riverenza e proseguiva con una serie
di figure, composte da piccoli passi.
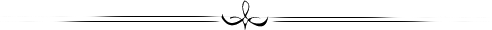
Molti mesi prima
Lo scrosciare cristallino dell’acqua corrente di rubinetto era il modo migliore per svegliarsi definitivamente. Fresca e chiara, passata più volte sul viso, nel tentativo di attenuare i segni marcati di una notte decisamente priva di sonno. William si fregò il volto con l’asciugamano, tamponando le gocce che scorrevano lente, intorpidite come lui stesso si sentiva. L’enorme specchio, che troneggiava sul lavabo nero del bagno in stile moderno, gli restituì un’immagine che oramai conosceva fin troppo bene. Un’occhiata più attenta a quel limpido riflesso fece sì che si bloccasse improvvisamente, come preso in contropiede, quando si accorse che dietro le sue spalle, sulla quella superficie liscia, si disegnava la figura di Mya. Appoggiata allo stipite della porta. Completamente nuda, a parte che per un paio di mutandine di pizzo nero semitrasparente. Quasi si stupì che avesse potuto indossarle di nuovo. Ricordava nettamente di avergliele praticamente strappate di dosso, appena poche ore prima. Le sorrise guardandola negli occhi attraverso il riflesso dello specchio.
«Posso considerarmi… perdonato?»
La ragazza sospirò incrociando le braccia davanti al seno nudo. Rimase in silenzio per un lungo attimo durante il quale squadrò l’immagine del suo uomo. Alla soglia dei quarant’anni, l’aspetto fisico di William Spencer gli rendeva finanche troppa giustizia, facendolo apparire più giovane di quanto in realtà non fosse. Alto e slanciato, imperioso nei suoi quasi due metri di altezza, manteneva il fisico asciutto di quando era ragazzo. Niente muscoli più di quelli che fossero strettamente necessari. Quasi miracolosamente, non mostrava il minimo segno di cedimento, nemmeno quel filo di pancia che a un uomo della sua età nessuno avrebbe mai negato.
«Oh, Will. Finirà come sempre. Ti perdonerò adesso e fra due giorni litigheremo di nuovo».
Mosse qualche passo in avanti. Gli occhi verde scuro di William, attraverso lo specchio, guizzarono di un lampo malizioso sotto le folte sopracciglia che gli conferivano un’aria fin troppo seria e composta, insieme ai tratti decisi e squadrati del volto.
«Litigherei altre mille volte solo per poter fare pace come ieri sera, Mimì».
Un ampio sorriso si distese sulle labbra rosse di Mya, a quelle parole. Appariva raffinato, forse senza neanche sforzarsi, perfino quando azzardava qualche eccitante provocazione, velata o meno che fosse. Un grosso contributo veniva, probabilmente, dal suo accento marcatamente britannico, mai contaminato in maniera alcuna, nonostante i tanti anni passati dall’altra parte dell’Atlantico. La ragazza azzerò la distanza che li separava, circondandogli il torace con le braccia, premendo i seni sulla sua schiena e posando il capo sulle sue spalle, quasi cercando rifugio dietro quella imponente figura. Sotto i suoi polpastrelli percepiva il freddo del suo corpo. Aveva la carnagione chiara tipica di un nord-europeo, talmente delicata da costringerlo, quando andavano al mare, a cospargersi di crema solare per non ustionarsi. Eppure, ogni volta che facevano l’amore, quel candore marmoreo pareva ardere come fuoco sopito per troppo tempo sotto la cenere. Ogni volta, questo cambiamento la stupiva e la eccitava. Solo in quei momenti lui pareva perdere, almeno in parte, quella compostezza tipicamente britannica che lo contraddistingueva.
«A dirla tutta, non credo di essere già pronta a firmare il trattato di pace, stavolta» mormorò la ragazza, in un soffio sul suo collo. Una ben nota sensazione d’irrequietezza si fece spazio nell’animo di William. Si voltò, traendola a sé con fare possessivo. I parecchi centimetri di differenza fra le loro altezze lo costrinsero a chinare il capo sul suo collo per poterlo sfiorare con un bacio.
«Farò tardi».
«Per una volta, non morirà nessuno».
Mya aveva ancora addosso il sapore della notte, sulla pelle leggermente salata. Profumava di passione e voluttà. Si dava a lui ogni volta anima e corpo e sembrava non stancarsi mai del suo amore. Quindici anni li separavano nelle date di nascita all’anagrafe, ma lui pareva non accusarli affatto, né sentirsi a disagio per questo. Fresca e giovane, senza veli appositamente per provocarlo, era il sogno di ogni uomo. E la tensione che percepiva all’altezza dell’inguine, sotto la stoffa leggera dei pantaloni del pigiama, unico indumento che aveva indosso, era per William come un vero campanello d’allarme. Quando lei catturò le sue labbra, chiedendo un bacio che non aveva nulla di casto, fece una enorme fatica nel riuscire a contenersi e a porvi fine.
«Devo andare. Questa sera, promesso».
Le sorrise, accarezzandole una guancia, per poi dirigersi velocemente fuori dal bagno. La ragazza lo osservò allontanarsi. Sbuffò increspando le labbra. Strinse il bordo del lavabo fra le mani, puntando con forza sulle braccia e incassando la testa dentro le spalle. Respirò profondamente. Quando rialzò lo sguardo, un paio di occhi chiari, azzurri come il mare la osservarono di rimando.
«Questa sera. Certo».
Distese lentamente i tratti del volto, rilassandosi e tornando in camera. William armeggiava nello spogliatoio adiacente, preparandosi per la giornata. Mya sapeva già che il suo aspetto sarebbe stato impeccabile. Come sempre.
Gettò un’occhiata al letto disfatto, spostando poi lo sguardo al comodino, sul quale era posato un CD accanto ad un’unica, singola rosa bianca. Prese il CD e lo fece scivolare nel lettore dell’impianto stereo. I Guns N’ Roses ruppero il silenzio della stanza da letto. Sulle note di “Paradise City”, appena poche ore prima, era stata lei a raggiungere il paradiso.
Si lasciò cadere sul letto ed accostò la rosa alle narici, aspirandone il dolce profumo.
Sì. William sapeva decisamente come farsi perdonare.
***
«Mi chiedo come diamine fai ogni volta ad evitare che ti prenda a calci in culo. Io lo farei, e mi divertirei pure!»
William sorrise, armeggiando col volante della sua Porsche con estrema disinvoltura. Manovrava con una sola mano mentre con l’altra teneva accostato all’orecchio il cellulare.
«Ho i miei assi nella manica, e non li rivelerò certo a te. Piuttosto, non dimenticarti di domani».
«Tranquillo. Ti ho mai dato modo di dubitare di me?»
«A dire il vero no».
Parcheggiò agevolmente nel suo posto macchina riservato, proprio davanti all’ingresso del palazzo degli uffici della Mercer Pharma Incorporated, fra una Mercedes e una Lamborghini.
«Esatto. Sei il tipico esempio di ossessivo-compulsivo, quando si tratta di lavoro, Will. Dammi tregua, ogni tanto».
«Fai le cose per bene, Mike, solo questo».
Nel tono rilassato dell’Inglese spiccava una punta di estrema serietà.
«Ti ripeto. Non devi preoccuparti».
In realtà William sapeva bene di poter dormire tra due guanciali, quando si trattava di Mike. Tuttavia voleva sentirselo dire, ogni volta. E come per tutte le volte, quando ebbe chiuso la telefonata, seppe di potersi concentrare sulla propria giornata in tranquillità. Scese dalla macchina, avviandosi verso l’interno della costruzione.
Il palazzo in cui erano siti gli uffici della Mercer Pharma Inc. si trovava nel cuore dell’Upper East Side. Imponente alla vista, la costruzione in stile moderno lasciava poco spazio all’immaginazione in merito alla sua destinazione d’uso. Fin dall’androne principale, lastricato di marmo, troneggiava infatti il nome della società, una delle più note nell’ambito della ricerca, della produzione e del commercio di farmaci destinati alla grande distribuzione. Il presidente, Anthony Mercer, l’aveva fondata trent’anni prima, e da allora era fiorita fino a diventare il colosso commerciale che nella Grande Mela era ben noto a tutti. Parte di quel successo era stato anche merito di William, per dirla tutta; il suo fiuto per gli affari si era rivelato estremamente azzeccato, quando si era deciso ad investire a favore della società gran parte del proprio capitale. Gli introiti che adesso gli tornavano indietro superavano largamente la quantità di denaro investita inizialmente.
Per di più, col vecchio Mercer era nata una sorta di immediata simpatia. In pochi anni, non solo era diventato direttore dell’amministrazione della società, ma era riuscito perfino a far breccia nel cuore dell’unica figlia del noto magnate. Anche se qualche mala lingua insinuava, velatamente, che fosse stato lo stesso Mercer a spingere Mya fra le braccia di quell’uomo integerrimo e dannatamente bravo nel trovare sempre nuovi finanziatori che acquisivano le azioni della società. William Spencer era una garanzia, in quel campo. Il suo brillante curriculum, culminante in una laurea in Economia ad Oxford correlata da una serie di dottorati e master, ne era una validissima testimonianza.
«Buongiorno, signor Spencer».
La voce della sua segretaria personale l’accolse cortese ed allegra come sempre.
«Novità, Sandy?»
Sandra, questo era il nome della minuta ragazza dai corti capelli biondi a caschetto, in piedi accanto alla porta del suo ufficio, in un perfetto tailleur blu scuro e con un tablet sotto il braccio. Lavorava per lui ormai da tempo e non faceva neanche più caso al fatto che il suo principale non le augurasse il buongiorno di rimando. Era fatto così. Lei aveva imparato come la cosa che più gli premeva fosse l’essere sempre puntuale, preciso ed impeccabile nel suo lavoro. Anche quella mattina aveva spaccato il secondo, entrando in ufficio nell’attimo immediatamente successivo a quello in cui lei aveva posato una tazza di tè caldo sulla scrivania di pesante legno scuro.
«Gli investitori cinesi confermano l’acquisto delle azioni. Il signor Smith si scusa, ma non potrà essere presente alla riunione del personale amministrativo, questo pomeriggio. Ha avuto un lutto in famiglia».
William inarcò un sopracciglio, prendendo posto alla scrivania ed accostando alle labbra la tazza di tè.
«Ho saputo. Brutto affare», si limitò a commentare. «Cos’altro?»
«Dal Modern confermano la prenotazione per il mese prossimo. Jennifer si sta occupando di tutto come al solito».
L’Inglese annuì, apparentemente molto soddisfatto, sorseggiando discretamente il liquido dal colore aranciato, ma lievemente opaco. Da buon britannico, William beveva il tè esclusivamente addizionato di latte.
«Bene. I miei appuntamenti di oggi?»
Sandra picchiettò velocemente i polpastrelli sullo schermo piatto del tablet.
«Sono quindici, in totale», sollevò lo sguardo dallo schermo fissando l’uomo dietro la scrivania. «Il primo è il signor…» diede una nuova, rapidissima occhiata allo schermo. «…Sandbourne. Lo faccio entrare?»
William annuì, posando la tazza sul tavolo, ancora piena a metà. Sandra si limitò a portarla via, senza dire altro. Sapeva per esperienza che lui non finiva mai il suo tè della mattina. E che, probabilmente, anche per quel giorno quella mezza tazza di tè gli sarebbe dovuta durare come sostentamento fino alla sera.
***
Mya poggiò i gomiti sul tavolo, in un atteggiamento che dall’esterno risultava estremamente poco raffinato e poco consono allo sfarzo e alla raffinatezza del salone dove stava attendendo ormai da tre ore. Si prese il viso fra le mani e sbuffò spazientita. L’orologio appeso alla parete segnava le dieci di sera. Il display del suo cellulare era ancora illuminato dopo la chiamata che aveva ricevuto.
“Mi dispiace immensamente, signorina Mya. Il signor Spencer manda le sue scuse”.
“Non preoccuparti, Sandra. Cerca di non strapazzarti troppo. Buonanotte”.
Chiuse gli occhi e si massaggiò le tempie. Doveva aspettarselo. Le candele che aveva sistemato sul tavolo erano ormai consumate per più di metà e la cena, fredda, era buona da dare in pasto agli alani da guardia di suo padre.
«Porta pazienza, Mya. Se lavora fino a tardi, lo fa anche per te».
La ragazza si sentì toccare dolcemente la spalla e si voltò, trovandosi di fronte il viso anziano e provato dagli anni di una donna dai tratti estremamente gentili, bassa e un po’ curva in avanti, con i capelli argentei raccolti in una crocchia severa sulla nuca. Era vestita completamente di nero, a parte per il pizzo bianco della camicetta.
«Oh, tata Betty! Lo so bene, ma…» sospirò tristemente. «È sempre così, ogni volta. E ogni volta mi illudo che possa essere diverso».
Gli occhi neri della vecchina assunsero una piega malinconica, mentre osservavano il volto della ragazza. Mya era il ritratto di sua madre, in ogni lineamento, specie nelle labbra piene e morbide e nella forma ovale del viso. Anche i capelli neri erano un regalo materno. Solo quegli occhi grandi, azzurro mare, adesso offuscati dalla tristezza, testimoniavano la sua appartenenza ai Mercer. Elizabeth, o tata Betty come la chiamavano tutti in casa, l’aveva vista crescere e diventare la splendida donna che era. Quella sera, in quell’abitino bianco scollato sulla schiena, semplice e grazioso, lei pensava che fosse più bella che mai.
«Neanche tuo padre è rientrato. Sai come sono queste riunioni, piccina. Vanno sempre per le lunghe, non dare tutta la colpa a lui. Sono certa che non lo fa apposta».
Mya sorrise mestamente. Tata Betty cercava sempre di risollevarle il morale, in qualche modo. Ma quella sera lei non sembrava affatto disposta a farsi consolare.
«Verrò sempre dopo quei maledetti soldi» scandì, arrabbiata, scattando in piedi e rivolgendo gli occhi alla tavola, ancora allestita con la tovaglia di lino bianco e le porcellane decorate a mano. Storse la bocca, disgustata. Avrebbe preferito mangiare un hamburger con patatine insieme a William, piuttosto che "filets de poisson poché au vin" sola come un cane. «Me ne vado a letto, Tata. Buonanotte».
Elizabeth annuì, osservandola lasciare il salone. Quella casa era tanto grande quanto vuota. Lo sapeva bene, lei, che da venticinque anni silenziosamente la abitava, una donnina discreta e benevola che sapeva esattamente quando far sentire la propria presenza. Di solito, ciò avveniva proprio quando Mya ne aveva maggior bisogno. Ma stavolta, le sembrava che qualsiasi cosa potesse dire non avrebbe fatto altro che peggiorare la situazione.
«Riposati, bambina. Domani andrà meglio» mormorò fra sé e sé, scuotendo il capo, addolorata nel vedere la sua pupilla così affranta. Mya aveva tutto quello che una donna potesse desiderare: bellezza, talento, e l'amore incondizionato di un uomo che la chiamava 'Mimì' con la raffinatezza degna di un principe delle fiabe.
Un uomo che però, puntualmente, veniva meno alle sue promesse.
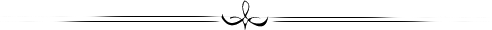
|
|
Ritorna all'indice
Capitolo 3
*** III - Moresque ***
|

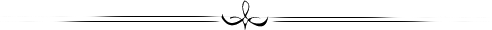
«Le prove a carico del signor Jefferson sono schiaccianti, Vostro Onore. Come vede, l’imputato è provatamente fedifrago, colpevole di tradimento nei confronti di sua moglie. Pertanto, chiediamo un assegno di mantenimento mensile di diecimila dollari e la proprietà dell’appartamento sulla Fifth Avenue».
L’anziano giudice Thompson fece ondeggiare dubbiosamente i baffoni grigi ben curati. Si rigirò più volte fra le mani ossute le foto inequivocabili dell’uomo che sedeva al banco degli imputati. Era ritratto insieme ad una donna bionda, molto appariscente, con la quale sembrava essere parecchio ‘intimo’. Sopra la testa del giudice, lucida come un uovo, troneggiava una grande targa di ottone, sulla quale era incisa indelebilmente la frase: “La Legge è uguale per tutti”. Alzò gli occhi chiari e liquidi sull’imputato, grugnendo qualcosa di incomprensibile.
Il signor Jefferson era un noto medico sulla cinquantina, con qualche accenno di calvizie e piuttosto corpulento, stimato chirurgo estetico molto conosciuto nella New York ‘bene’. Quando si sentì addosso gli occhi del giudice, si passò il pollice tra la pelle del collo tarchiato e il colletto della camicia, deglutendo imbarazzato col sudore che gli imperlava la fronte. Sua moglie, una finta rossa dagli occhi piccoli e cupi, magra come un manico di scopa, lo osservava con lo sdegno dipinto sul volto. O meglio, più che indignato, il suo sguardo pareva quello di un avvoltoio affamato che s’apprestasse a smembrare le carni di una carcassa per banchettare.
All’interno di quell’aula del Tribunale di New York una nutrita folla di curiosi attendeva, in silenzio, il verdetto del giudice e della giuria popolare. La storia del tradimento del noto medico aveva fatto il giro di Manhattan, fornendo l’ambìto pane quotidiano di innumerevoli pettegole che si erano impegnate anima e corpo a diffondere il più possibile la malevola notizia: Corinne Jefferson aveva in testa un palco di corna da fare invidia a un cervo capobranco. E facevano un grazioso accostamento con la puzza sotto il naso che si portava dietro ovunque. Alle parole imperiose dell’avvocato Lawson, scagliate contro l’imputato, un mormorio di approvazione si sollevò nella stanza.
Oltre gli occhiali tondi di spesso vetro, il giudice continuò imperterrito a guardare verso il banco degli imputati. Tirò su leggermente col naso e poi sbuffò, picchiettando le dita sulla scrivania.
«Avvocato Traven, prego. La sua ultima arringa».
A quelle parole un giovane uomo, seduto accanto al dottor Jefferson, si alzò abbottonandosi la giacca dell’impeccabile completo nero gessato. Il volto, sbarbato di fresco e privo di ogni ruga, non dimostrava più di una trentina d’anni. Pareva il ritratto della serenità e non perse quella maschera neanche nel momento in cui trasse un profondo respiro, prima di parlare.
«Vostro Onore, chiedo un’interruzione».
La bocca del dottor Jefferson si spalancò tanto da farlo sembrare un merluzzo imbalsamato, oltre che un completo idiota. Era palese che non si aspettasse quelle parole da parte del suo difensore. Il mormorio nella sala si fece più alto e insistente, ma il giovane non mosse un muscolo, limitandosi a stare in piedi, in attesa delle parole del giudice. Questi battè con il martelletto sulla scrivania, richiamando all’ordine i presenti.
«Silenzio, per favore! Interruzione accordata, avvocato Traven. La seduta è rimandata di quindici minuti».
L’avvocato chinò leggermente il capo, come a ringraziare, dirigendosi poi verso l’uscita dell’aula. Il dottor Jefferson l’avrebbe immediatamente seguito a ruota, se non fosse stato per l’essere richiamato dalla voce stridula di sua moglie, stizzita ed inalberata per la situazione, evidentemente anche lei presa alla sprovvista da quello strano evento.
«John, giuro che se questo è un altro dei tuoi giochetti…»
«Oh, stai zitta, Corinne, una buona volta!»
La liquidò alla svelta, correndo dietro il giovane avvocato. O meglio, camminando alla velocità che la sua generosa mole gli consentiva.
«Traven. Traven! Che cazzo ti prende, eh?! Sei il mio avvocato, è tuo dovere difendermi, Cristo!»
Gli sbarrò letteralmente la via di ingresso alla toilette. Il legale inarcò un sopracciglio, squadrandolo silenziosamente. Gli occhi castano scuro erano vispi e guizzavano su ogni particolare della pingue figura davanti a lui. Portò l’indice sulle labbra, sfiorandole appena, e fece segno al suo assistito di entrare nella toilette insieme a lui. Si avvicinò al lavabo, aprendone l’acqua e lasciandola scrosciare. Jefferson ne osservò i movimenti contenendo un moto di irrequietezza che lo smuoveva tutto.
Forse era stato un errore, affidarsi ad un avvocato così giovane. Non avrebbe dovuto lasciarsi convincere dalle voci che giravano riguardo il fatto che nonostante l’età, fosse uno dei più scaltri dell’intera New York. Un ‘fottutissimo figlio di puttana’, l’avevano definito al Country Club. Si raccontava come una leggenda della magistrale arringa con la quale aveva scagionato uno dei più noti imprenditori di Wall Street dall’accusa schiacciante di truffa nel bilancio aziendale. Correva anche voce che, a scadenze mensili, Traven ricevesse dal suddetto imprenditore a mo’ di ringraziamento per quell’affare - che non era mai stato del tutto chiarito - una serie di modesti regalini, dai Rolex alle penne stilografiche placcate in oro. Ma adesso che lo guardava, quei racconti gli parevano nebbiosi come il fumo dei sigari di marca che impregnava l’aria quando li aveva ascoltati, e gonfiati come puntate troppo alte ad una mano di poker. Un ragazzino, ecco cos’era. Uno sbarbatello belloccio dai tratti affilati, vestito come un damerino e bravo a rigirarsi i clienti a parole per poi tirarsi indietro quando bisognava dimostrare di possedere gli attributi.
Traven si lavò le mani, tranquillamente, come se niente fosse, come se neanche sentisse su di sé quegli occhi preoccupati e inquisitori.
«Ti pago fior di dollari per questo processo. Devi tirarmene fuori. Non ho intenzione di pagare gli alimenti a quella troia!» sbraitò ancora Jefferson.
Lo scrosciare dell’acqua si interruppe. L’avvocato sollevò impassibile lo sguardo sul medico, mentre si asciugava le mani.
«Sarebbe stato più facile se avessi tenuto il pisello a bada. Ma per tua fortuna, so come venirne fuori. Devi solo smetterla di urlare come una bagascia di basso borgo» mormorò pacato, scandendo le parole con una forte cadenza newyorkese.
«Che vorresti dire?»
«Limitati ad assecondarmi in aula in ogni cosa che dirò. Fidati. So quel che faccio».
Gli fece un occhiolino complice, gettando con precisione la carta umidiccia nel cestino. Jefferson grugnì, ancora dubbioso.
«Lo farò. Ma se qualcosa va male, ti appendo per le palle».
Le sopracciglia di Traven si inarcarono fortemente. Sollevò le spalle, come se il pensiero di restare appeso per gli attributi non lo preoccupasse affatto. Se ne uscì dalla toilette, chiudendosi la porta dietro la schiena, senza dire una parola di più, mentre Jefferson restava a guardarlo pensieroso.
***
Michael Traven era in piedi di fronte alla giuria popolare. Nonostante fosse solo mediamente alto, i suoi modi di fare e il suo portamento gli conferivano un qualcosa di molto rispettoso e altisonante, tanto che chi lo conosceva faceva fatica a credere che avesse appena trentatré anni. Teneva le mani intrecciate fra loro, dietro la schiena, mentre compostamente camminava avanti e indietro nell’aula, pronunciando la sua arringa.
«Non ho imparato a mentire, durante gli anni dell’università, né durante il mio tirocinio», stava dicendo, quieto, ma con un tocco di pathos teatrale accuratamente dosato. «Cosa risponderei a questo punto, se mi chiedeste cosa penso del dottor Jefferson? Che egli è indiscutibilmente colpevole, e meriterebbe senz’altro la pena proposta dall’avvocato Lawson per conto di sua moglie!»
Fece una pausa ad effetto, puntando l’indice contro l’imputato, per godersi appieno la reazione della gente presente in aula e dando maggiore enfasi a quelle parole che suonavano paradossali. Jefferson deglutì e trattenne uno scatto d’ira, memore dell’unica raccomandazione che gli era stata rivolta poco prima.
Limitati ad assecondarmi in aula in ogni cosa che dirò. Fidati. So quel che faccio.
Era ormai passato il momento di decidere se fidarsi o meno. Erano in ballo migliaia di dollari e la sua intera reputazione. Tutto nelle mani di quel giovane che adesso lo guardava di traverso, come se invece di essere il suo difensore, fosse uno dei membri dell’accusa.
L’indice di Traven si portò in alto, richiamando la gente al silenzio.
«Tuttavia, non sempre la visione delle cose, come ci viene proposta, rispecchia poi quel che accade realmente. A tal proposito, Vostro Onore, avrei un interessante reperto da farvi ascoltare. Un concerto, oserei dire, magistralmente orchestrato. Una sinfonia».
Il giudice Thompson se ne stava fermo come una statua di sale. Il giovane avvocato lo osservò, infilandosi una mano nella tasca della giacca.
«Col Vostro permesso, Vostro Onore».
Solo a quell’aggiunta il giudice, finalmente, annuì una sola volta, acconsentendo.
«Proceda pure, avvocato Traven».
La mano che era nella tasca ne trasse un piccolo aggeggio grigio scuro. Il dottor Jefferson socchiuse le palpebre nel tentativo di capire cosa fosse; sua moglie, invece, parve non aver alcun dubbio sulla natura dell’oggetto che adesso l’avvocato mostrava all’intera corte. Corinne Jefferson trasalì, diventando bianca come un fantasma. Ruotò lentamente il capo verso l’avvocato Lawson, seduto accanto a lei, e in quegli occhi maligni si leggeva chiaramente la paura della sconfitta.
Traven posò l’oggetto davanti al microfono del giudice Thompson, che poté così apprezzarlo meglio per quel che era. Un piccolo registratore a nastro. Il sommesso click del tasto play, amplificato dal potente microfono, risuonò nel silenzio di tomba che adesso permeava l’aula. Dopo di esso, crepitii indistinti e fruscii, per qualche secondo appena.
Il giovane avvocato ruotò il viso verso la signora Jefferson, che si stava torcendo le mani. E nell’esatto momento in cui i suoi occhi scuri incontrarono quelli di lei, una serie di gemiti ed ansiti inequivocabili giunsero alle orecchie di tutti i presenti. Nell’assordante silenzio, rimbombava quello che poteva essere il perfetto sonoro di un film erotico. Un uomo ed una donna che, a giudicare dalle urla di lei ad un certo punto, si stavano dando allegramente da fare. Gli occhi dell’avvocato continuavano ad esser fissi su quelli della signora, il cui viso, da pallido com’era diventato alla vista del registratore, era adesso imporporato da un evidente rossore. Un misto di imbarazzo e di rabbia che faceva a pugni col colore dei suoi capelli.
L’unico che pareva restare impassibile a quella scena era il giudice Thompson, a differenza dei presenti in aula che avevano cominciato a ridacchiare e a prendersi a gomitate, indicando la moglie del medico. Jefferson, dal canto suo, non aveva idea di quel che stesse accadendo; si limitava a starsene zitto, osservando gli effetti sortiti da quella trovata del suo avvocato.
«E non è tutto, Vostro Onore».
Traven schiacciò il pulsante che mandava in avanti la registrazione. Un sonoro scricchiolio fu testimone del fatto che il nastro stesse scorrendo. Fu in quel momento che l’avvocato Lawson scattò in piedi, dritto come un fuso, improvvisamente congesto in viso.
«Obiezione, Vostro Onore! C’è stato tempo più che sufficiente per l’esibizione di eventuali prove!» sbraitò, inviperito.
Per tutta risposta, Traven nemmeno si voltò a guardarlo. Restò davanti al giudice, in quieta attesa.
«Obiezione respinta. Questa gliela ammetterò, avvocato Traven, ma nel caso lei abbia altre prove, le consiglio di presentarle tempestivamente. Altrimenti, la prego di astenersi». Il giudice gli fece quindi segno di andare avanti.
Nuovamente il registratore prese ad emettere suoni. Stavolta, era uno stralcio di una conversazione. Ad alternarsi, come poco prima, una voce femminile ed una maschile.
«È una fortuna per te che sappia perfettamente come incastrare tuo marito. È un bene conoscere tutti i trucchi, nel mio lavoro».
«Già. La sua passione per le bionde gli costerà cara. Farlo cadere nella trappola è stato uno scherzo. Povero idiota. E pensare che lo tradisco con te da prima che mi sposasse».
«Farò in modo che ti venga assegnato anche questo appartamento. È vicino al mio studio, potrei trasferirmi da te in via definitiva».
«Vorresti trasferirti solo per questo motivo?»
«Mi pare ovvio che non sia così».
La conversazione era perfettamente udibile, così come furono udibili le risatine complici successive a quelle battute e tutta una serie di nuovi rumori che, ancora, lasciavano poco all’immaginazione. Ma l’avvocato Traven decise che poteva bastare. Interruppe la riproduzione, lasciando poi il registratore alle mani del giudice.
«Vorrei fosse messo agli atti che le voci appena udite sono quelle della signora Corinna Parker in Jefferson e dell’avvocato Lionel Lawson. Ovviamente, metto a disposizione il nastro per qualsiasi prova di riconoscimento vocale. Io e il mio assistito ne abbiamo diverse copie, e le custodiamo gelosamente».
Lawson sbatté i palmi delle mani sul banco dell’accusa.
«Obiezione! Queste registrazioni violano le regole della proprietà privata!». Parlò con così tanta veemenza da sputar fuori parecchia saliva, mentre la signora Jefferson si nascondeva il viso fra le mani.
«Fino a prova contraria, l’appartamento è ancora di proprietà del mio assistito, che non ha abbandonato il tetto coniugale di sua sponte ma è stato gentilmente messo alla porta da sua moglie. Per cui, egli dispone della sua proprietà come gli pare e piace, anche inserendo un sistema d’allarme con registrazione incorporata».
Traven si voltò verso Jefferson, sul cui viso troneggiava adesso un’aria vittoriosa. Era vero. Quell’avvocato era un grosso figlio di puttana. Come avesse saputo della tresca di sua moglie e come gli fosse venuto in mente di far installare dei registratori in casa, non lo sapeva e non gli interessava saperlo. Mal comune, mezzo gaudio. Adesso che sua moglie veniva fuori come la perfida orchestratrice di un complotto ai suoi danni, le sue scappatelle passavano in secondo piano, e tutte le richieste di risarcimento crollavano automaticamente come castelli di carte.
«Non ho altro da aggiungere. Vostro Onore, signori della giuria. Il mio assistito avrà anche violato ogni vincolo del legame matrimoniale, da quelli più sacri a quelli profani, ma scagli la prima pietra, adesso, chi non è colpevole» Traven si fermò, con una pausa ad effetto, guardando direttamente la moglie del medico. «Sua moglie, magari, alla fine dei giochi».
I bei tratti affilati del giovane volto si distesero in un ampio sorriso vittorioso, corredato di due file di perfetti denti candidi. Quando sorrideva, fin da bambino e nonostante fosse piuttosto magro, sulle sue guance si scavavano un paio di fossette che lo facevano sembrare l'essere più tenero sulla faccia della terra.
Ma quando si parlava di lavoro, Michael Traven diventava una iena pronta a fare a pezzi chiunque gli sbarrasse il cammino. A qualunque costo, e con qualunque mezzo.
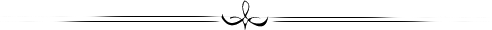
ANGOLO AUTRICE:

Lui si descrive da solo, perché se lo facesse chiunque altro
troverebbe qualcosa per non essere d'accordo.
Si fa preannunciare dalla sua fama di avvocato e non teme nulla e nessuno,
pur di spuntarla in Tribunale.
E questo lo rende tremendamente sexy,
oltre l'avere il sorriso più bello del mondo.
Fa il suo ingresso trionfale Michael Traven, proprio come in una danza Moresca,
in un susseguirsi di pantomime scenografiche volte a rigirare gli eventi a proprio favore.
Vi lascio recapiti vari per contatti/insulti/complimenti (?)/rotture di scatole:
Pagina Facebook: Codivilla Vicariosessantanove Efp
Gruppo Facebook: La Canonica del Vicario
Ask: Chiedi e (forse) ti sarà detto
Alla prossima e grazie a chiunque passi di qui.

|
|
Ritorna all'indice
Capitolo 4
*** IV - Habanera ***
|

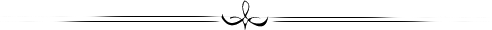
Note limpide ed incalzanti si libravano leggere nell’aria, dalla coda di uno splendido pianoforte nero, al centro del salone. Mya, in piedi accanto allo strumento, teneva le mani raccolte all’altezza del grembo e gli occhi bassi verso il pavimento. Un passaggio più energico del pianista, un trillo di note acute e squillanti. Solo in quel momento rialzò il capo. Gli occhi colore del mare brillarono, quasi stesse commuovendosi. Guardò in alto, fiera e bella come un’apparizione, e poi sommessamente chiuse gli occhi, schiuse le labbra, ed iniziò a cantare.
«L’amour est enfant de Bohème, il n’a jamais jamais connu de loi. Si tu ne m’aimes pas je t’aime, si je t’aime prends gard à toi!» [1]
La voce della ragazza, cristallina e potente, si spense dopo l’ultimo acuto; qualche attimo di silenzio e infine uno scrosciar di applausi, talmente forti da far spellare le mani.
Mya sorrise. Portò la destra al petto, all’altezza del cuore, e accennò ad un composto inchino. Si ritrovò fra le mani un grosso mazzo di rose bianche, portate da una bambina. Guardò oltre, tra la folla, fino a scorgere il sorriso di William che alzava un flute di champagne in sua direzione. Gli soffiò delicatamente un bacio, mentre alle sue orecchie giungeva ancora il rumore degli applausi.
***
I galà per attirare gli investitori che il vecchio Anthony Mercer organizzava a scadenza annuale erano ben noti, nel mondo azionario di New York, per la loro magnificenza. Cibi raffinati e vini invecchiati di ogni genere e nazione abbondavano, tanto da sembrare potessero non finire mai e tanto che a fine serata i vassoi risultavano ancora pieni, riforniti costantemente dai camerieri. Tutti gli anni veniva scelto un diverso locale in cui allestire il rinfresco. Per quell’anno, l’enorme sala ricevimenti del noto ristorante newyorkese “The Modern” era stata liberata dei consueti tavoli in stile contemporaneo che la occupavano. Al loro posto, ai due lati della sala, correvano due lunghe tavolate apparecchiate con un sontuosissimo buffet. Al centro della sala, troneggiava il pianoforte accanto al quale Mya aveva cantato poco prima, e già gli avventori stavano facendo lavorare debitamente le mandibole accanendosi sulle tartine al caviale e gamberi e sui vol-au-vént di pasta sfoglia ripieni di vellutata di salmone norvegese. Nonostante il ristorante fosse famoso per l’essere proprio accanto al noto museo omonimo, un’ala del quale era visibile addirittura attraverso un’ampia vetrata in quella stessa sala, pochi sembravano essere interessati all’arte offerta dal museo stesso. I più sembravano avere a cuore l’arte del cuoco che aveva preparato tutti i manicaretti che facevano bella mostra su quei tavoli.
William e Mya passeggiavano nella sala, dispensando sorrisi e carinerie ai magnati della finanza che erano intervenuti all’evento. Per volere di suo padre, Mya era il pezzo forte dell’intrattenimento di quelle serate, grazie alla bella voce di soprano che aveva scoperto e coltivato fin dall’età di quindici anni. Frequentava i corsi di canto e di musica alla Juilliard School con ottimi risultati. Spesse volte era stata scelta come protagonista per diverse opere liriche messe in scena nella scuola stessa. A suo grande vantaggio, oltre il talento innato, giocava il suo aspetto fisico. Quella sera era splendida in un abito nero, lungo fino ai piedi, legato al collo. Lasciava la schiena completamente nuda, complici in questo erano anche i capelli castani raccolti in una raffinata acconciatura. Nonostante gli alti tacchi delle scarpe nere che indossava, risultava sempre consistentemente più bassa del suo fidanzato, anche lui perfetto in un completo nero corredato di camicia bianca, papillon e gemelli d’oro bianco ai polsi.
William le stava dicendo che suo padre li avrebbe raggiunti a breve per il consueto discorso ai finanziatori, sussurrandole discretamente all’orecchio, quando furono raggiunti dalla figura smilza ed esile del banchiere Philips. Questi era un omino occhialuto di bassa statura, dal naso adunco. Tutto in lui aveva le sembianze di un piccolo scarafaggio, specie per la sua predilezione di vestire completamente in tono scuri e di tingersi i capelli di nero: le braccia magre ed ossute, come le gambe, e le dita adunche e nodose contribuivano a dargli l’aspetto di un insetto. Tuttavia, era uno dei più importanti agganci finanziari della regione, per la Mercer Pharma, in quanto le casse della sua banca traboccavano di soldi e titoli pronti ad essere investiti nei momenti più opportuni.
«Signor Spencer, signorina Mercer. Che piacere vedervi, stasera».
Mya trattenne un brivido. Non le era mai piaciuto quell’uomo. Il suo modo di parlare era una palese maschera di falsa cortesia, dietro la quale si celavano invidia, malvagità ed avidità. Tuttavia, allungò la mano destra verso quella sinistra dell’uomo, permettendogli di accennare a un baciamano con estrema compostezza. William l’osservò di sottecchi. «Signor Philips, il piacere è nostro», disse la ragazza cortesemente, ritirando poi la mano. «Spero che il ricevimento sia di suo gusto», aggiunse, stringendosi a William.
«Perfetto, come sempre. Ma non vedo suo padre, in questa Babele di persone».
«Ci raggiungerà a breve».
La risposta di Mya fu cortese, ma inappellabile. Sottintendeva che non avrebbe aggiunto altro sul perché della momentanea assenza di Anthony Mercer. Il banchiere increspò le labbra sottili, contrito.
«Capisco. Peccato. Avevo intenzione di parlare… d’affari», sibilò, sollevando le spalle.
«Può parlare con me, intanto che aspettiamo l’arrivo di Anthony». La voce pacata e ovattata di William si intromise nella conversazione con decisione, seppur con gentilezza.
L’omino squadrò l’Inglese a lungo. Una punta di maligna invidia si fece strada negli occhi piccoli e neri, ma fu un attimo il dissimularla con abilità.
«Mi sembra giusto. Non c’è angolo di New York in cui non si parli di lei e di come Mercer la consideri il suo naturale erede».
Mya serrò le labbra con disappunto, stringendo con più forza il braccio di William. Lui posò la propria mano su quella della ragazza, come per tranquillizzarla. Ma lei aveva già capito dove l’untuoso banchiere volesse andare a parare.
«Mi occupo da molto tempo di una parte dei suoi affari, è naturale che lui abbia fiducia in me».
«Lo spero bene, Spencer. Spero bene che la sua acutezza negli affari sia realmente fondata. Poiché molti insinuano che siano altri i motivi della simpatia di Mercer nei suoi confronti».
Gli occhi maligni puntavano su Mya, che per tutta risposta strattonò violentemente il braccio del suo fidanzato. Scattò, come per dire qualcosa, ma William la bloccò con una semplice occhiata.
«Mimì, tesoro, vuoi lasciarmi solo col signor Philips per qualche minuto?»
Le narici di Mya si dilatarono, fremendo di rabbia. Deglutì silenziosamente, mandando giù l’insulto che avrebbe voluto rivolgere all’odioso banchiere. Le sue dita erano ancora strette sul braccio di William, che sentì poi lentamente quella presa diventare meno forte.
«Ma certo, Will. D’altronde, è mio dovere intrattenere anche gli altri ospiti», modulò, con tono perfettamente controllato. «Vi lascio ai vostri affari».
Chinò il capo e lasciò andare il braccio del suo fidanzato. In quel mondo di squali ed approfittatori, William sapeva sempre esattamente come comportarsi. Lei ci provava, con tutte le sue forze. Ma quando incontrava persone come il banchiere Philips, il suo unico istinto era quello di appioppargli un cazzotto sul naso e godersi l’effetto che avrebbe fatto.
***
Lo sguardo di Mya vagava attraverso la sala gremita. Un coro di frivolezza e ostentazione che la infastidiva alquanto, specie per il fatto che William stava discutendo da un’ora buona con Philips e pareva averne ancora a lungo. Lei aveva cercato il più possibile di chiacchierare, sorridere e rendersi amabile davanti a tutti; ma dal troppo ciarlare a voce alta aveva adesso la delicata gola infiammata; le facevano male i muscoli del viso dal troppo sorridere e i piedi chiedevano pietà per i tacchi troppo alti; infine, non aveva più voglia di sentire complimenti di circostanza riguardo la sua performance canora. Sapeva benissimo che la maggior parte degli astanti non aveva neanche idea di quale fosse l’opera da cui aveva estrapolato i brani che aveva cantato, così come sapeva che gli applausi erano sempre più forti del dovuto per il cognome che portava. Aveva ragione il banchiere Philips. Era William il degno erede di Anthony Mercer, pur non condividendone legami di sangue. Lei non era portata per quel mondo costruito sulla speculazione e sul denaro. Era un’anima sensibile, che si commuoveva pensando al destino di Mimì ne La Bohéme e quando voleva tagliare i ponti col mondo si rifugiava nella musica. Non era un’affarista, né lo sarebbe mai stata. Nessuno stupore che l’impero costruito da suo padre fosse destinato ad essere affidato alle mani di William.
Guardava, ma non osservava. Lo champagne nel suo calice si era ormai riscaldato, tanto da diventare imbevibile, ma a lei non sembrava interessare. In piedi accanto alla vetrata che dava sul museo, era isolata dal chiacchiericcio della sala e completamente immersa nei suoi pensieri.
«Signorina Mercer?»
Mya sbattè le palpebre un paio di volte, prima di rendersi conto che c’era qualcuno che la stava chiamando. Ruotò lentamente il volto in direzione della voce che aveva udito, fino alla figura di un giovane uomo piuttosto alto – certo, meno di William, ma era davvero difficile trovar qualcuno più alto di lui – che era lì, accanto a lei, e stava cercando di attirare la sua attenzione da chissà quanto tempo. Tuttavia, lei non aveva la minima idea di chi fosse.
«Mi permetta di presentarmi», disse lui, come se avesse potuto leggere i suoi pensieri. «Mi chiamo Sandbourne. Christopher Sandbourne. Spero di non averla infastidita».
La ragazza fissò gli occhi chiari in quelli di lui. Si ritrovò a chiedersi per quale strano incrocio di razze fossero di quella particolare forma. Leggermente a mandorla, un delicato tocco orientale, oltre che scuri, tanto da apparire quasi neri alla luce dei lampadari squadrati bianchi che illuminavano la sala.
«Nessun fastidio, signor Sandbourne». Mya sorrise, come aveva fatto con tutti per l’intera serata. «Mi dica, è qui anche lei per affari con mio padre?» chiese, retoricamente. Tutti, in quella sala, erano lì esclusivamente per affari.
«Troverebbe strano il contrario?»
«Lo troverei sbalorditivo, più che altro».
«Lieto dunque di essere riuscito a sbalordirla».
A quelle parole, Christopher sorrise, inclinando il capo. Mya lo osservò meglio. Pareva troppo giovane per la sobrietà e l’eleganza con cui era vestito. Un completo nero con camicia bianca e cravatta anch’essa nera, perfetto per l’occasione, certo. Ma il primo bottone della camicia slacciato, proprio sotto il nodo della cravatta, faceva intendere che non fosse il suo abbigliamento di ogni giorno e che sentisse la stoffa di raso avvolta intorno al suo collo come una costrizione. E considerando il taglio dei suoi capelli, leggermente lunghi sulla fronte e sulle tempie, neri come la pece e scompigliati, si capiva come non fosse propriamente un tipo da serate di gala frequenti. Bastava un confronto diretto con William, che non aveva mai un capello fuori posto – nonostante fossero ricci e folti – e li teneva sempre corti, perfettamente acconciati, perfino quando si svegliava al mattino. Al contrario di lei, che aveva passato tre estenuanti ore dal parrucchiere per raccogliere i folti capelli in quella acconciatura alta sul capo e che appena sveglia al mattino aveva nidi di gabbiano che impiegava una buona mezz’ora a districare.
«Non mi dica che è qui solo per il buffet, allora», scherzò, dopo quell’attimo di silenzio.
«Anche per quello, a dirla tutta, ma… non solo».
«Sono curiosa. Mi dica, quindi, cosa l’ha portata a farci l’onore di essere nostro ospite stasera?»
Christopher serrò leggermente le palpebre, osservando attentamente la ragazza. Era riuscita ad essere indiscreta e beneducata nella stessa frase e questo l’aveva evidentemente colpito. Guardò oltre, più all’interno nella sala, fino a soffermare lo sguardo sul pianoforte.
«Ero curioso di sapere se fosse vero che la bella e ricca Mya Mercer ha talenti che vanno ben oltre quello di essere nata con tale cognome».
Mya parve interdetta da quella risposta. Tacque per qualche attimo, guardando a sua volta il pianoforte.
«… e la curiosità del signor Sandbourne è stata degnamente placata?», chiese, tornando ad osservare il suo interlocutore. La verità? Adesso era lei ad essere estremamente incuriosita. Christopher buttò giù un lungo sorso di champagne dal calice che stringeva in mano.
«Qualcuno la definisce la nuova Callas, Mya. Io penso che debba ancora studiare sodo, per arrivare a un livello tale di perfezione», disse sorridendo, con tono tranquillo e pacato, guardandola negli occhi. «Tuttavia, lei ha una voce davvero notevole. Ma quel che più mi ha colpito è stata la sua capacità di rendere perfettamente, nel cantare, l’amore inafferrabile e la libertà di vivere della sensuale Carmen. Questo non è da tutti».
Mya inclinò il capo, aggrottando le sopracciglia.
«Lei conosce la Carmen?»
«Ogni singolo brano, a memoria. Comprendo il suo stupore, non si preoccupi».
Entrambi, nello stesso momento, volsero attenzione alla gente che s’affannava a chiacchierare frivolamente fra champagne e stuzzichini, parlando tanto senza dirsi niente di concreto.
«Non mi stupisco più di nulla», mormorò, posando il calice che aveva ancora fra le mani sul tavolo.
«Questo non lo credo. Io l’ho stupita».
La ragazza osservò il giovane mentre lui terminava di bere e si sporgeva, poi, per posare il calice accanto al suo sul tavolo.
«Come fa ad esserne così sicuro?»
«Diciamo che possiedo anch’io un certo talento. Sono bravo nell’interpretare le reazioni delle persone».
Christopher si infilò le mani nelle tasche dei pantaloni con noncuranza. Mya stava per ribattere qualcosa, quando si sentì chiamare dalla voce di William che doveva aver finalmente terminato la lunga chiacchierata col banchiere Philips.
«Mimì, tesoro. Ti ho cercata per l’intera sala».
«Will, è successo qualcosa?»
Il volto dell’uomo non nascondeva un velo di evidente preoccupazione, che venne poi sostituita da un accenno di meraviglia quando si accorse della presenza di Christopher.
«Signor Sandbourne. Mi fa piacere che sia riuscito a venire, in fin dei conti».
«Non mi sarei perso la serata per nulla al mondo».
Gli occhi scuri del giovane uomo indugiarono per qualche attimo su Mya, dopo quelle parole. La ragazza alternò rapidamente lo sguardo fra i due, ma senza stupirsi troppo. William conosceva mezza New York di persona e l’altra metà tramite telefono. Col lavoro che faceva, era inevitabile.
«Vuole scusarmi se porto via Mya per qualche minuto?»
«Prego, faccia pure, anzi. Mi sarei ritirato a breve, nonostante la conversazione fosse estremamente piacevole. Buona continuazione, signor Spencer. Signorina Mercer, ancora complimenti».
Mya non fece in tempo a rendersene conto, che Christopher si era già defilato con discrezione. William si avvicinò per riuscire a sussurrarle all’orecchio.
«Tuo padre non ci raggiungerà. Mi ha telefonato il dottor Kleine. Gli ha proibito di lasciare il letto per via dell’affanno e minaccia di fargli prendere i farmaci con la forza».
«Quella testa dura», Mya scosse il capo. «Dovrai occuparti tu del discorso agli investitori. Tornerò a casa immediatamente: sai che riesco a convincerlo meglio di chiunque altro».
William annuì, dandole un bacio sulla guancia e accarezzandola poi gentilmente con l’indice e il medio della destra.
«Vai. Qui penso a tutto io».
«Grazie».
Si guardarono per qualche attimo, prima di prendere vie differenti nella sala. William verso il piccolo pulpito che era stato approntato per il discorso di Anthony Mercer e Mya, con discrezione, verso l’uscita della sala, preparandosi ad affrontare la ben nota testardaggine di suo padre.
[1] da “L’amour est un oiseau rebelle”, Atto primo della Carmen di Bizet.
Traduzione: “L’amore è figlio di Zingari, non ha mai conosciuto legge. Se tu non mi ami, io ti amo; se io ti amo, fai attenzione!”
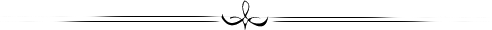
|
|
Ritorna all'indice
Capitolo 5
*** V - Ouverture ***
|

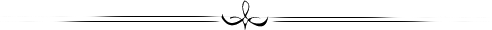
Le labbra di Michael si strinsero attorno al filtro di una sigaretta. L’accese, facendo poi velocemente sparire l’accendino nella tasca della giacca e tirando una lunga boccata.
«Quante volte devo dirtelo che non sopporto la puzza di fumo?»
Il giovane avvocato socchiuse gli occhi gustandosi quel giro di fumo denso nei polmoni. Quando lo soffiò via con noncuranza, si sentì piombare addosso lo sguardo severo di William, seduto alla propria scrivania.
«Non rompere le palle, Will. Sembri mio padre», disse, accomodandosi sulla poltroncina in pelle davanti alla scrivania stessa, «anche lui non faceva che ripetermi che dovevo smettere di fumare».
«Con scarsi risultati, vedo».
«Diceva anche che non avevo la stoffa per fare l’avvocato. Ed eccomi qua. Il più richiesto e pagato dell’intera New York!»
Una nuova nuvola grigia e consistente impregnò l’aria intorno a Michael, mentre allargava le braccia in una tronfia esibizione della propria persona. Il sorriso che gli solcava il viso era quello tipico di chi conosce i propri mezzi e sa esattamente come sfruttarli al meglio. William scosse il capo, abbozzando a sua volta, gli angoli delle labbra che si sollevarono appena. Michael aveva un ego talmente vasto che sarebbe bastato da solo a riempire l’intero palazzo degli uffici della Mercer Pharma. Ogni tanto si domandava come sarebbe stato essere un vero menefreghista come lo era lui, non curarsi affatto di tutto il resto intorno, in maniera così naturale da sembrare che ogni singola cosa nella vita gli fosse dovuta.
«Sì, ho sentito di come hai salvato capra e cavoli all’ultimo processo».
«Quando si tratta di corna mi diverto anche di più, sai?»
William lo guardò dritto negli occhi per un lungo attimo. Puntò i gomiti sul legno scuro e lucido della scrivania, offrendo le proprie dita intrecciate fra loro come appoggio al mento. Le sopracciglia castane, folte e severe, si aggrottarono dubbiosamente.
«Già. Tuttavia, mi chiedo…»
Dalle labbra dell’avvocato fuoriuscì un perfetto anello di fumo. William tacque, e per un attimo nella stanza non vi fu altro suono che il ticchettio sommesso dell’orologio appeso al muro.
«… come facevi a saperlo?»
«Cosa?»
L’espressione innocente mostrata dal giovane legale avrebbe ben esplicato il termine ‘faccia da schiaffi’ sul dizionario. William non si scompose di un millimetro. Si conoscevano fin troppo bene per riuscire a nascondersi qualcosa a vicenda. I loro sguardi cozzarono, quasi sfidandosi.
«La cameriera filippina», Michael soffiò via una nuova spirale grigia nell’aria, scuotendo poi la sigaretta nel posacenere. «Mi ci è voluto poco per scoprire che fosse assunta in nero. Sotto la minaccia di perdere il lavoro, non ha esitato a spifferare che nei momenti in cui Jefferson non era in casa, sua moglie si dava alla pazza gioia».
«E hai indagato in prima persona?»
A Michael non sfuggì affatto l'accenno di timore sottinteso in quella domanda.
«Ovviamente no. Ci ha pensato Jones».
L’Inglese annuì, reclinando lentamente il busto indietro ed accomodandosi sulla propria poltrona. Meditò silenziosamente su quelle parole, con un sospiro eloquente.
«Mi chiedo se in giro sia rimasto qualche poliziotto ancora onesto».
«Non credo», Michael scrollò le spalle, come se non gliene importasse nulla, «si fanno tutti i cazzi loro».
William storse le labbra con disappunto a quelle parole. Non sopportava il turpiloquio gratuito, e Michael aveva decisamente la bocca facile in quel senso. Si stupiva di come cambiasse completamente quando si trovavano a quattr’occhi, rispetto a quel che di sé mostrava agli altri. Chiunque avrebbe pensato che fosse il ritratto di un perfetto gentiluomo. William sapeva bene quanto fasulla fosse quella maschera.
«Meglio così. Comunque, non sei stato altrettanto scaltro con Philips».
Gli occhi castani dell’avvocato avvamparono di rabbia. Spense in uno scatto d’ira il mozzicone di sigaretta nel posacenere. Sul pavimento, il tacchettare nervoso di un tallone, dalle scarpe nere lucide firmate nuove di pacca, a segno di un forte, incontenibile ed improvviso nervosismo.
«Quell’infame voleva il trentacinque per cento dei profitti, Will. Un cazzo. Possiamo fare a meno dei suoi soldi».
«Devi fare sempre di testa tua, eh?»
William sbatté i palmi sulla scrivania, in un gesto che strideva con la sua compostezza.
«Mi pare che sia andata sempre di gran lusso, finora».
«Finora. Ma adesso le carte in tavola sono cambiate, Mike».
«Possiamo trovare mille finanziatori migliori di lui. Con meno pretese».
Il giovane avvocato sbuffò, infastidito. William si alzò in piedi, scuotendo il capo.
«Posso trovare, vorrai dire. Perché adesso tocca a me rimediare al tuo casino. E fortunatamente per te, i miei piedi sono ancora piantati in terra abbastanza da capire quando è il momento di mollare un po’ la corda».
«Stai montando su una tragedia per nulla, Cristo».
William aggirò la scrivania, stringendo i pugni con rabbia. Le palpebre si ridussero a due fessure sulle iridi verde scuro, mentre fissava il viso più giovane e spavaldo dell’avvocato. Quest’ultimo sostenne con strafottenza lo sguardo dell’altro, continuando a starsene seduto sulla poltrona senza accennare a cedere.
«Centomila dollari sono dunque nulla, Mike? Ed è solo l’inizio. Dormire sonni tranquilli costa, lo sai».
Le narici dell’Inglese fremettero in un profondo respiro. Le pupille dilatate e le rughe sulla fronte rivelavano quanto fosse arrabbiato più di quanto non lo facesse il suo intero corpo. Mike odiava quella integerrima compostezza. Avrebbe di gran lunga preferito che William gli sbraitasse contro, vomitandogli addosso tutta la propria rabbia. Quantomeno, ciò gli avrebbe permesso di reagire a sua volta con una sfilza di imprecazioni che l’avrebbero zittito senza ‘se’ e senza ‘ma’.
«Sei il nostro legale, le rifiniture degli accordi le devi concordare tu stesso, e questo te lo concedo», aggiunse, abbassando il tono di voce. «Ma per favore, parla con me prima di prendere decisioni come quella di estromettere i finanziamenti di uno come Philips. Quello maneggia i soldi di mezza New York».
I lineamenti squadrati di William presero una piega più morbida, quasi condiscendente.
«D’accordo?»
Michael serrò le labbra. Non aveva mai imparato ad abbassare la cresta, fin da ragazzo. Mandare giù un rimprovero gli era stato sempre maledettamente difficile, e più che mai questa sua caratteristica si era accresciuta negli anni quando aveva iniziato a farsi la barba e gli erano cresciuti i peli sul petto.
«Va bene. Il signor Spencer sarà avvisato a tempo debito».
William decise di ignorare il tono ironico di quella frase, preferendo non scontrarsi con la testa dura del giovane. Sapeva che ci avrebbe pensato due volte, dopo quella paternale, a far di testa sua, anche se non l’avrebbe mai ammesso apertamente.
«Bene. Comunque, poco male», modulò, in un tono più rilassato e più confacente alla sua persona. «Sono riuscito a trovare qualcun altro interessato, alla fine».
Tornò a sedersi, rilassandosi sulla poltrona e dondolandola leggermente a destra e a sinistra, quasi cullandosi, scevro in viso dell’ira mostrata poco prima.
«Di chi si tratta?»
«Un giovane californiano. Wall Street sembra aver pagato bene alcune sue manovre… azzardate».
Michael si alzò scuotendo il capo, dirigendosi verso il mobiletto degli alcolici e servendosi due dita di scotch invecchiato. Un paio di movimenti delicati, circolari, che fecero muovere il liquido bronzeo, prima di mandarne giù due sorsi facendo poi schioccare la lingua al palato.
«Vedo che hai già fatto le tue indagini in merito».
«Ovvio. Non voglio sorprese».
«Già. E dove sarebbe, adesso, questo fantomatico pozzo di denaro?»
La risata di William lo colse completamente di sorpresa. Quell’uomo era strano, alle volte. Lo conosceva da anni e ancora si stupiva di certe sue reazioni.
«Muori dalla voglia di rigirartelo come un calzino, o sbaglio?»
Michael alzò il bicchiere in aria alle parole dell’Inglese, chinando poi il capo in una buffa pantomima che doveva rassomigliare ad una riverenza.
«Touchè, amico mio. Touchè».
***
Mya tuffò il naso in una delle rigogliose orchidee bianche che ornavano le siepi del giardino di casa Mercer. Tutti i ricordi della sua infanzia erano segnati dal profumo dolce di quei fiori delicati. Suo padre se ne era sempre preso cura personalmente, con tutto l’amore di cui era capace. Come se l’inebriarsi di quelle note lievi, giorno dopo giorno, potesse lenire il dolore di una perdita che non era mai riuscito del tutto a superare.
«Tua madre odiava qualsiasi tipo di pianta e di fiore, tranne le orchidee bianche».
Chiuse gli occhi lasciandosi cullare dalla voce dietro le sue spalle. Annuì, voltandosi ed osservando l’anziano uomo che le faceva compagnia nel passeggiare. Ad entrambi parve, per un attimo, di riflettersi in uno specchio, quando si guardarono vicendevolmente negli occhi.
«Lo so, papà. Me lo dici sempre».
Anthony Mercer sorrise alle parole della figlia. Quando la guardava, gli sembrava di avere vent’anni di meno. Era uguale a sua madre, in ogni lineamento. Certo, a parte quegli occhi azzurro mare. L’unico regalo che aveva voluto accettare da lui. Accostò una sigaretta quasi terminata alle labbra, aspirando una boccata; ma nel momento in cui soffiò via il fumo, fu preso da un accesso di tosse che gli scosse il petto, graffiandogli la gola. Mya scosse il capo contrariata.
«Ti prego, papà. Non potresti smettere? Ti fa male, lo sai. E il tuo cuore è già debole».
«Mya, non ricominciare. Abbiamo fatto un patto, no? Io mi comporto assennatamente prendendo ogni medicina che vorrai darmi, e tu mi lasci fumare in santa pace per gli anni che mi restano».
«Il dottor Kleine se ne accorgerà. E non sarà contento».
«Al diavolo lui. Non mi interessa. È l’unico vizio che mi sono concesso in una vita intera, lo sai».
La mano rugosa dell’uomo colse una delle orchidee, sistemandola poi sull’orecchio della figlia, dietro un ciuffo dei capelli castani che quel giorno portava sciolti e mossi sulle spalle. Lei era la sua unica vera ricchezza e lui l’amava sopra ogni altra cosa al mondo. Rimpiangeva adesso, nella vecchiaia, il tempo che aveva sottratto a lei per dedicarlo alla sua società, e più sentiva farsi pressante il peso negli anni, più si ripeteva che avrebbe cercato di rimediare. Ma non sempre ci riusciva. La Mercer Pharma aveva ancora bisogno di lui. Per quanto William potesse essere in gamba, per quanto si fidasse di lui come di un figlio, non si sentiva ancora pronto a lasciargli completamente il campo. Forse perché, in cuor suo, si sentiva morire già solo al pensiero che dopo tanti anni la società non sarebbe più stata diretta da un Mercer.
«Come mai sei a casa, oggi pomeriggio? Di giovedì sei sempre al Country Club».
La domanda di Mya lo ridestò dai propri pensieri, cogliendolo in contropiede. L’orchidea era ferma a contornarle il viso, come l’aveva sistemata, e lei lo stava osservando con un bel sorriso dipinto sul volto. Si schiarì la voce, sentendosi improvvisamente in trappola. Gettò il mozzicone della sigaretta ormai consumata a terra, sulla ghiaia, spegnandola sotto una scarpa.
«Oh, è che… ho un appuntamento», biascicò sbrigativamente, evitando il contatto visivo con sua figlia.
«Papà!», disse Mya, in tono di rimprovero, aggrottando le sopracciglia.
«Lo so, lo so, il dottor Kleine ha raccomandato che mi riposassi… e lo sto facendo. È solo per una chiacchierata, niente di più».
«Non mi incanti. Con te non sono mai solo chiacchiere. È lavoro anche questo, anche se non sei andato nel tuo ufficio. Dio, sembri un adolescente ribelle!»
«Il che mi rincuora. Ti ringrazio per il complimento».
Mya sbuffò. Stava per ribattere qualcosa, ma l’arrivo di James, il maggiordomo, la bloccò sul nascere.
«Signore, ci sono visite».
«Oh, bene! Vieni anche tu, Mya, sempre se non hai di meglio da fare».
La ragazza annuì e, con un profondo sospiro, intrecciò il suo braccio con quello che suo padre le porse con galanteria. Quantomeno avrebbe potuto sincerarsi che lui non si sarebbe affaticato troppo.
***
Gli occhi di Christopher erano fissi sul più grande dei molti quadri che ornavano le pareti del salotto di casa Mercer, appeso proprio sopra il caminetto. La stanza trasudava eleganza all’antica, in ognuno dei bei mobili di legno scuro intarsiato che la arredavano, eppure quel quadro era la quintessenza della semplicità. Un acquerello dai tratti morbidi e pieni, incorniciato da quattro liste squadrate di quello che sembrava legno di mogano lavorato a mano, e che a tratti iniziava a mostrare i segni del tempo nei fori prodotti dalle tarme. Sulla tela, il ritratto di una donna che un occhio attento avrebbe criticato per qualche proporzione poco rispettata e per più di qualche tratto incerto. Tuttavia, in ogni pennellata, al giovane sembrava di percepire quello che rendeva quel quadro assolutamente affascinante: amore, passione, e forse anche rabbia. Chi l’aveva dipinto aveva miscelato i propri sentimenti nei colori ed essi risplendevano più vividi che mai negli occhi neri di quella donna. Unica caratteristica che ne discostava le fattezze da quelle della giovane Mya, potè notare.
«Se è interessato all’arte, dovrebbe guardare gli altri quadri. Quello è un maldestro tentativo di un giovane pittore da quattro soldi».
Un sorriso spontaneo comparve sul volto di Christopher. Ruotò il capo lentamente, dietro di sé, scorgendo la figura di Anthony Mercer che avanzava verso di lui a braccetto con sua figlia.
«Io non definirei maldestro chi riesce a mettere su tela i propri sentimenti», ribattè, pacatamente, voltandosi col corpo intero e tendendo la mano verso l’uomo. «Grazie per aver accettato di incontrarmi. Sono Christopher Sandbourne».
Anthony gli strinse calorosamente la mano.
«Anthony Mercer. È un piacere conoscere giovani e promettenti uomini d’affari. Posso presentarle mia figlia?»
Mya non aveva smesso di squadrare Christopher dal momento in cui, entrando nel salone, lo aveva riconosciuto. Troneggiava sul suo viso una sorta di espressione vittoriosa, che si faceva più evidente ogni attimo che passava. La prima impressione che aveva avuto di lui al ricevimento veniva confermata appieno in quel preciso istante. Un paio di jeans e una camicia nera avevano sostituito l’abito elegante, ed erano molto più confacenti all’aria un po’ scarmigliata che nel complesso quell’uomo ispirava.
Dal canto suo, Christopher sembrava attratto da un solo ed unico particolare, nella figura di Mya: il fiore di orchidea che ancora le abbelliva il viso, placidamente posato sull’orecchio.
«Ho già avuto il piacere di conoscere Mya, signor Mercer».
«Il signor Sandbourne era al ricevimento, papà», aggiunse Mya, cogliendo lo sguardo sospettoso dell’anziano genitore. «Quindi mi ha mentito, quando le ho chiesto perché era venuto?»
«Assolutamente no, signorina Mercer. Di affari avevo già parlato in precedenza col signor Spencer. Quella sera ero lì unicamente per sentirla cantare».
Christopher sembrava essere assolutamente sincero. Il viso di Anthony si illuminò a quelle parole, ma Mya continuava a dimostrare una punta di sospetto.
«E perché è qui oggi?» chiese ulteriormente, incalzando il giovane e fissandolo dritto negli occhi.
«Mya, non mi pare di averti insegnato ad essere così sgarbata con gli ospiti».
Lo sguardo di Christopher si alternò fra la ragazza e suo padre, che in quel momento stavano guardandosi in cagnesco. Sollevò le mani in segno di tregua, estremamente divertito.
«Per favore, signor Mercer, lasci pure che Mya chieda quel che desidera sul mio conto», esordì, tranquillo, fissando gli occhi scuri in quelli azzurri di Mya. «Sono qui per conoscere suo padre, signorina Mercer, è una richiesta che ho fatto espressamente al suo fidanzato. In fondo, se devo investire in una società, mi pare giusto presentarmi come si deve al responsabile unico», fece una piccola pausa, constatando come i tratti della ragazza andassero distendendosi pian piano. «Avrei preferito non recarvi disturbo qui in casa, ma ultimamente suo padre è introvabile».
Fece cadere morbidamente le mani lungo i fianchi, nel terminare il suo discorso. Se fosse riuscito o meno a far crollare le riserve della ragazza nei suoi confronti, non lo seppe mai. Tuttavia, ottenne da lei un bel sorriso sincero.
«Ha ragione, signor Sandbourne. È che tendo a diventare gelosa, quando si tratta di mio padre».
Mya lo disse con tanta naturalezza che Christopher si sentì sciogliere il cuore. Somigliava molto poco al genitore, nell’aspetto fisico; eppure era palpabile nell’aria il legame profondo che li univa, come un filo d’acciaio invisibile teso fra i due.
«È comprensibile, signorina Mercer».
Ci fu un momento di silenzio assoluto, durante il quale Christopher si soffermò più lungamente con lo sguardo sull’intera figura di Mya. Coi capelli sciolti, in un vestitino rosso di stoffa leggera, appariva fresca come una rosa e spontanea come una margherita di campo. Anthony strinse più strettamente il braccio di sua figlia, schiarendosi la gola e mettendo fine a quel silenzio.
«Bene! Dunque, vogliamo prendere qualcosa? Un tè, magari?»
Christopher storse leggermente il naso a quella proposta, accennando a un cortese gesto di diniego con la mano destra.
«Se non è di troppo disturbo, signor Mercer, io preferirei una birra».
«Scura, magari?»
«Sarebbe l’ideale».
«Figliolo, tu sì che sai come rendere felice un vecchio! Ho in cantina una riserva di birra scura artigianale, viene direttamente dall’Irlanda, ma Mya mi impedisce continuamente di affogarci i miei molti dolori articolari e il mio futuro genero continua ad propinarmi quel dannatissimo Earl Grey!»
Il giovane rise a quell’affermazione. Anthony lasciò andare il braccio di sua figlia per cingergli le spalle, avviandosi con lui oltre la porta del salone. Mya alzò gli occhi al cielo, rassegnata.
Suo padre era decisamente incorreggibile.
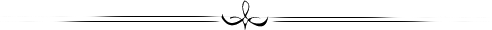
|
|
Ritorna all'indice
Capitolo 6
*** VI - Fugue I ***
|

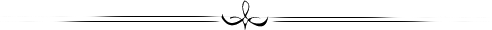
Il sole stava lentamente morendo dietro le colline. Villa Mercer ne era quasi completamente circondata. Immerso nel cuore degli Hamptons, l’edificio non nascondeva nulla delle ricchezze dei suoi proprietari. Si trattava, infatti, di una enorme villa in stile coloniale, dipinta in bianco, con dettagli di mattoncini rossi a vista. All’ingresso si accedeva tramite due scaloni speculari, che al centro si riunivano in una grossa arcata, fiancheggiata da due arcate più piccole. Il profumo di rose ed orchidee rampicanti accoglieva chiunque percorresse i viali cosparsi di ghiaia dell’enorme giardino, e di notte lampioncini dalle sfumature blu rischiaravano il buio conferendo al luogo un senso di pace e di tranquillità. Il valore aggiunto di quell’abitazione stava, però, nei due meravigliosi paesaggi di cui era possibile godere affacciandosi alternativamente verso nord-ovest o sud-est: da una parte, appunto, le basse colline ricoperte di alberi e di verde, oltre le quali il sole tramontava tingendo di rosso le foglie delle querce; dall’altra la distesa del mare, su cui il sole faceva capolino al mattino dalla foschia. Sembrava sterminato, quel mare, a guardarlo da quella distanza. Anche se, in realtà, era possibile raggiungere le coste di Rhode Island senza troppi problemi. Ma nel complesso chiunque sostava, anche per poche ore, presso la residenza dei Mercer, se ne tornava a casa con la stessa sensazione di beatitudine, lasciandoci un pezzo del proprio cuore.
Christopher stava proprio riflettendo sulla bellezza di quel posto, con lo sguardo fisso al disco incandescente del sole. I riflessi infuocati impattavano violentemente sulle sue iridi, facendole sembrare più chiare di quanto in realtà non fossero, dietro le palpebre socchiuse che in quell’atteggiamento risultavano accentuate nella loro forma un poco orientaleggiante.
«Toglie il fiato, non è vero?»
Alla domanda di Anthony, affacciato accanto a lui sulla balconata a nord-ovest della villa, si limitò ad annuire un paio di volte. Non sentiva il bisogno di esprimere alcun pensiero; nei tratti rilassati del volto, atteggiato ad un sorriso, si ravvisava una evidente sensazione di pace.
«Fa quasi temere che possa scoppiare un incendio da un momento all’altro, proprio là, sulle colline».
Il vecchio Mercer accostò alle labbra una pinta di birra scura. Sul suo volto comparve un’espressione di piena estasi. Era fatto così, lui. Una birra, qualche chiacchiera e una sigaretta gli bastavano perché si sentisse felice come un bambino a Natale. Amava le cose semplici della vita, avendo constatato amaramente, sulla propria pelle, che tutte le ricchezze del mondo non sarebbero bastate a colmare il vuoto che si portava dentro.
Un ultimo lampo rosso trafisse il cielo, come se il sole volesse salutarli definitivamente sparendo dietro i colli e lasciando il posto alla notte. Christopher sospirò, imitando poi Anthony nel bere la propria birra.
«Già. La sua casa è splendida e il paesaggio meraviglioso. Se vivessi qui, non mi allontanerei mai».
«Pensare che invece Mya vorrebbe che ci trasferissimo a Manhattan».
Le labbra di Christopher si incresparono in una curiosa smorfia. Mya era scappata via di tutta fretta, appena pochi minuti dopo il suo arrivo, e aveva intuito dall’espressione di Anthony come ciò succedesse con più frequenza di quanto lui gradisse.
«Un grande talento richiede grandi sacrifici. Sono certo che l’unico motivo per cui lo desideri è l’opportunità di essere più vicina alla Juilliard». Fece una pausa, assaporando nuovamente un sorso di birra e facendo schioccare la lingua al palato. «In effetti, è un po’ lontano dalla città».
Il volto anziano di Anthony si rattristò improvvisamente, come se il freddo della notte che lentamente stava scendendo gli fosse penetrato direttamente nelle ossa, raggelandolo.
«Non è per quello», mormorò, infine, con tono rassegnato.
Christopher lo osservò in silenzio, sentendosi improvvisamente a disagio. L’intero pomeriggio era trascorso in allegria, e gli era parso anche di aver fatto una buona impressione sul ricco magnate. Quella tristezza improvvisa lo destabilizzava alquanto. Anthony rovistò per qualche attimo nella tasca della propria giacca, estraendone poi un pacchetto di sigarette ed un accendino.
«Fumi, ragazzo?»
«No, signore».
«Fai bene. È un vizio stupido. Hai un po’ di sale in zucca, a differenza di me».
Christopher sorrise sentendosi un po’ meno a disagio, mentre l’altro si accendeva la sigaretta con un gesto meccanico, ripetuto chissà quante volte negli anni. Il grigio del fumo si stagliò contro il nero della notte, oltre la balconata. Al di sotto il giardino era già illuminato soffusamente, dando una visuale magnifica, quasi eterea.
«In questa casa è morta sua madre. Lei nemmeno la ricorda, era troppo piccola, appena una bambina. Ma tutta la grandezza e la magnificenza che la circonda ogni giorno non fa che rammentarle l’amarezza e le difficoltà dell’essere cresciuta senza di lei».
Le parole di Anthony si susseguivano monocordi nel silenzio ovattato. Christopher deglutì, sentendosi la gola riarsa e secca; mandò giù un nuovo sorso di birra, cercandovi sollievo, impacciatamente. Dal canto suo, l’altro continuava a fumare tranquillamente, con lo sguardo perso nel vuoto oltre l’orizzonte, apparentemente senza dar retta al suo ospite.
«Ho cercato di fare il possibile, come padre, ma non è per nulla facile. Ho avuto la fortuna di essere aiutato dalla sua tata, ma la mancanza di una madre è come un pozzo di cui non è possibile toccare il fondo. C’è sempre qualcosa che riporta a galla il dolore».
Se solo si fosse voltato, anche distrattamente, Anthony avrebbe potuto cogliere l’attimo esatto in cui le labbra di Christopher si serrarono con rabbia. Un gesto fugace, impercettibile, che scomparve nel momento immediatamente successivo. Come se le parole del magnate riportassero alla sua mente qualcosa che gli faceva male ricordare. Terminò la sua birra in un sorso solo.
«Perché non si è risposato?»
Si ritrovò dinanzi gli occhi incuriositi dell’altro, voltatosi a quella improvvisa ed inaspettata domanda, formulata con una rigidità quasi forzata, compassata. Anthony tirò una nuova boccata, mettendosi improvvisamente a ridere e scuotendo il capo, incredulo.
«Ragazzo, d’accordo che mi sei simpatico, ma questi sono fatti miei!»
Christopher annuì, chinando il capo in segno di scuse.
«Ha ragione. Sono stato inopportuno. Chiedo perdono».
«Non preoccuparti. Non sei il primo che me l’ha chiesto e non sarai l’ultimo», disse, squadrandolo da capo a piedi con aria divertita. «E tu? Ce l’hai una ragazza?»
Il viso del giovane assunse un’espressione buffa, ma furba, con un sopracciglio inarcato e l’accenno di un sorrisetto sghembo.
«Più o meno. Qualcosa di simile», ammise, facendo spallucce.
«Voi giovani di oggi. Non avete le idee chiare su nulla», sbuffò il vecchio. «Ai miei tempi, o eri fidanzato, oppure non lo eri, senza vie di mezzo, Dio santo. Ne vuoi un’altra, di quella?»
Indicò il boccale di birra ormai vuoto. Christopher scosse il capo.
«No, la ringrazio. Anzi, sarà meglio che vada».
«Come preferisci».
Il fumo sfuggiva denso dalle labbra di Mercer, giunto oramai agli ultimi tiri della sigaretta. Christopher posò il boccale sul tavolino della balconata.
«Mi ha fatto piacere conoscerla, signore».
«Torna, qualche volta. Mia figlia mi tiene a bada, ma parlare davanti ad una buona birra mi fa sentire ringiovanito di vent’anni!»
Le labbra di Christopher si distesero in un ampio sorriso. Annuì pacatamente, prima di allontanarsi lasciando l’altro solo coi suoi pensieri. Volgendo gli occhi azzurri lontano, nella notte, Anthony Mercer sospirò profondamente. E a quel sospiro, una fitta improvvisa gli mozzò il fiato. Portò la destra al cuore, cercando di respirare e, al contempo, di tirare le redini a quel cavallo imbizzarrito che stava diventando il suo vecchio cuore.
***
Le mani di Christopher sfiorarono con delicatezza la pelle nera del volante, quasi con riverenza. Adorava il suono che produceva un motore che salisse velocemente su di giri, fino allo stremo, a gridare con foga tutta la propria potenza. Lui se la godeva, quella musica, interrompendola solo quando l’auto ormai implorava una marcia superiore.
Gli bastò un lieve tocco delle dita sul comando al volante perché la Ferrari 458 che stava guidando si mettesse nuovamente a fare le fusa, come una gatta che si beasse delle carezze del proprio padrone. Il tachimetro era ben oltre qualsiasi limite consentito per la strada che stava percorrendo, ma lui pareva non curarsene affatto.
Lo squillare del suo telefonino, posato sul sedile del passeggero, si intromise fra le note di “Highway to hell”, sparata a palla dallo stereo ultima generazione. Christopher cercò di attenuare, in fretta, la voce di Bon Scott, armeggiando col tasto del volume ed afferrando poi il telefono. Riconobbe immediatamente il numero sul display.
«Mi stai col fiato sul collo, Jack?», esordì, rispondendo.
«Sempre».
Una voce calma, pacata e profonda, pronunciò quell’unica parola. Gli piaceva, quella voce. Gli faceva venire in mente quelle dei cantanti blues, quelli bravi, quelli che bisogna saperli trovare, nei locali più sgangherati e fatiscenti delle grandi città. Talmente nascosti che non ti verrebbe mai in mente di andarci a prendere qualcosa da bere.
«Non dovresti. So quel che faccio».
«Lo spero. Piuttosto, com’è andata?»
Christopher sorrise socchiudendo le palpebre, mentre imboccava una svolta sulla destra. Continuava a sfrecciare su quel bolide come se il parlare al telefono in contemporanea non lo disturbasse minimamente.
«Fin troppo facile».
«Non è un buon motivo per prendere il tutto sottogamba. Lo sai…»
«… lo so, lo so. Focalizzare l’obiettivo», sbuffò Christopher. «Quante volte me l’hai detto?»
«Sempre una in meno del necessario. Lavorati il vecchio Mercer. E fa attenzione alla macchina».
Per tutta risposta, schiacciò con più foga l’acceleratore. Tutto quello che gli provocava una scarica di adrenalina nelle vene lo eccitava, e correre in quella maniera sfrenata gli dava un senso di godimento pari solo alla sensazione dell’ultima spinta prima dell’orgasmo, quando faceva sesso. Chiedergli di mettere un freno allo scalpitare di quel gioiellino rosso fuoco era un insulto.
«Tranquillo. È sana e salva».
«Bene. A domani, allora».
Chiuse la telefonata e alzò di nuovo il volume della musica, fino a sentire il cuore pulsargli in gola a ritmo con il suono della batteria. Avrebbe avuto ancora per poco la possibilità di godersi quella macchina, quantomeno per quella notte. Il tempo di raggiungere la rimessa di Stan e sarebbe tornato in sella alla sua moto. Tuttavia, forse, quel pensiero lo fomentava ancora più di quei duecento chilometri orari segnati sul cruscotto.
Una volta che ebbe lasciata la macchina, senza sprecarsi in parole con un ragazzotto a cui restituì le chiavi, montò in sella ad una Norton Commando nera, senza guardarsi indietro, diretto al proprio appartamento. Di lì a un quarto d’ora, stava assaporando una birra direttamente dalla bottiglia, steso a peso morto sul proprio letto. Si era fatto una doccia, a giudicare dai capelli ancora umidi, e come sempre aveva lasciato le impronte dei piedi nudi bagnati dal bagno fino alla camera. Si era premurato solo di infilarsi poi i pantaloni di una tuta, la prima che aveva trovato buttata su una sedia accanto al letto stesso.
L’appartamento consisteva in un anonimo monolocale, come se ne trovano tanti a New York, spoglio di qualsiasi mobile superfluo. Una cucina con angolo soggiorno integrato, un buco di salotto con un divano ed una televisione, una camera da letto e un bagno. Carta da parati anonima rossa, un po’ scolorita, illuminata da luci fioche di lampadari di gusto discutibile. In un angolo, poco lontano dal divano, una panca, pesi e bilancieri di diverse misure. Le uniche ricercatezze erano, forse, l’impianto stereo gigante sistemato in camera da letto e il materasso ad una piazza e mezza che occupava per più di due terzi quella stessa stanza.
Posò la birra sul comodino e si mise a sedere, recuperando da terra una canotta nera senza maniche. L’indossò sul torso nudo, incassando poi la testa fra le spalle. Chiuse gli occhi, quasi smettendo di respirare, muto nel silenzio a rimuginare sulle parole di Anthony Mercer. Fin quando un insistente bussare alla porta non interruppe i suoi pensieri, facendogli rialzare lo sguardo con uno scatto.
Andò ad aprire controvoglia. Sull’uscio c’era una ragazza dai lunghi capelli biondi, vestita – o per meglio dire, svestita – con una minigonna di pelle nera inguinale e con un top nero aderente che accentuava le curve del suo corpo, lasciando molto poco all’immaginazione. Gli occhi verdi pesantemente truccati squadrarono la figura di Christopher da capo a piedi, brillando di una luce maliziosa che sottintendeva un evidente obiettivo. Obiettivo che fu ancora più preciso quando si soffermò lungamente a guardargli il cavallo dei pantaloni, mordendosi voluttuosamente il labbro inferiore, pieno e turgido, tinto di rosso fuoco.
«Charlie, hai idea di che ore sono?», mormorò il giovane, passandosi una mano fra i lunghi capelli scuri.
«Shh. Scopare. Ora», sentenziò lei, come fosse un ordine, posandogli l’indice della mano sulle labbra per metterlo a tacere.
A quelle parole, lui la trasse dentro l’appartamento, afferrandola per la vita con prepotenza, e chiudendo poi la porta con un tonfo secco. Non si poteva certo dire che fosse tipo da farsi pregare.
***
Si svegliò la mattina dopo, ancora intontito e completamente nudo. Accanto a lui, Charlie dormiva tranquillamente, stesa a pancia in giù, con i capelli sparsi sul cuscino. Sapeva già che avrebbe ritrovato quei fili dorati dispersi ovunque, fra le lenzuola di cui era difficile adesso trovare il bandolo, data la matassa informe di tessuto che componevano ai piedi del materasso, testimone di una nottata piuttosto turbolenta. La ragazza sembrava respirare appena, con la schiena nuda che ritmicamente si sollevava e si riabbassava, ma gli occhi di Christopher non riuscivano a staccarsi da quel panorama eccitante che era il suo sedere, sodo e morbido sotto i palmi delle mani. Aveva i fianchi larghi, la vita stretta di una vespa, chilometri di gambe e un seno florido, alto ed invitante, che esercitava su di lui una sorta di trance ipnotica ogni volta che stava sopra di lei, ondeggiando spinta dopo spinta. Era un monumento vivente al sesso, quella ragazza. Sapeva esattamente come muoversi per godere e far godere a sua volta. In un certo senso, lui la vedeva come la propria controparte femminile. Semplicemente lei faceva agli uomini che si portava a letto lo stesso effetto che lui faceva alle donne: erano fin troppe quelle che gli chiedevano di essere richiamate dopo una notte di sesso, e fin troppo poche quelle che lui effettivamente richiamava. Charlie era una di queste. Si erano incontrati per caso in un bar e alla seconda birra erano già sotto le lenzuola. Lei sapeva come appagarlo, lui sapeva come appagare lei, e tanto bastava perché fosse l’unica a cui Christopher non sapesse mai dire di no.
Si alzò trascinandosi fuori dalla camera da letto, fino alla cucina. Bevve del succo d’arancia direttamente da un cartone del frigorifero, rabbrividendo quando si rese conto che era praticamente andato a male, aspro e bruciante nella gola. Stava ancora cercando di svegliarsi completamente quando il cellulare, abbandonato sul lavandino, prese a squillare.
«Dove sei?»
Christopher si appoggiò sul bordo del lavandino con il sedere, percependo sulla pelle il freddo di quella sottile striscia di acciaio. Si fregò energicamente il volto con la mano. Decisamente era tutto meno che sveglio.
«A casa, Jack. Dove vuoi che sia a quest’ora?»
«Siamo già in ritardo. Fra dieci minuti sono da te».
Non ebbe tempo di replicare. Il telefono gli restituiva di già nelle orecchie il suono di linea occupata, segno che dall’altra parte avevano già messo giù. Si rigirò l’apparecchio fra le mani per qualche attimo, buttando fuori l’aria dai polmoni in un lungo respiro che gli fece fremere le narici. Quando rialzò lo sguardo vide sull’uscio della cucina Charlie, stretta in una camicia nera in cui sarebbe entrata almeno due volte. Christopher sorrise. Non riusciva a capacitarsi di quanto quella ragazza potesse essere pudica al mattino presto, dopo che avevano condiviso il letto. In fondo, quando gli si era presentata davanti la sera prima, indossava praticamente il nulla.
«È mia, quella camicia. E mi serve».
«Non è il tuo stile. Tu sei più un tipo da magliette dei Rolling Stones e jeans strappati. Neanche ti ci vedo, con questa roba addosso».
Charlie indugiò a lungo ad osservare la figura di Christopher, che da canto suo non sembrava aver problemi a girare per la casa senza neanche un paio di boxer addosso. Non che la cosa le dispiacesse, però. Lui l’osservò con aria seria.
«Charlie, te ne devi…»
«… andare. Lo so». Lei completò la frase con estrema naturalezza, quasi leggendogli nel pensiero, con un sorriso sulle labbra. «Nessun problema. Io sono la tua scopata e via, tu sei la mia. Coccole e simili non sono comprese nel pacchetto».
«… già».
Lei gli si avvicinò, ancheggiando con quella sensualità che in lei era innata. Una femmina nel vero senso della parola, pensava Christopher. Schiuse un poco i lembi della camicia, accostando il proprio corpo a quello di lui, fino a sentire sulla propria pelle il suo calore. Le sue labbra puntarono pericolosamente quelle dell’altro, ma le sfiorarono appena, deviando bruscamente in direzione del suo orecchio.
«Anche se ho la netta impressione che preferiresti che restassi qui», sussurrò voluttuosamente, mordendogli il lobo col preciso intento di provocarlo.
Lui la strinse a sé in un gesto possessivo, afferrando le sue natiche col palmo pieno delle mani, accentuando volontariamente il contatto con lei che potè così percepire con maggiore prepotenza quello che era un segnale inequivocabile. Le parti basse di Christopher erano decisamente ben più sveglie ed attive di quanto fosse lui stesso.
«Mi sveglio sempre così, al mattino, Charlie. Non c’entri tu, non ti esaltare», soffiò con un filo di voce, fissandola direttamente negli occhi con spavalderia.
«Fortunata chi sceglierai per svegliarsi vicino a te tutte le mattine, allora… perché prima o poi succederà, eroe». La voce di Charlie era poco più di un sussurro sulle labbra di Christopher. «Vado a rivestirmi e sparisco».
Gli stampò un forte bacio sulla guancia, facendo schioccare le labbra al contatto con la sua pelle, e si voltò correndo verso la stanza da letto coi capelli biondi che ondeggiavano dietro la schiena.
Christopher sorrise scuotendo il capo. Avrebbe quasi voluto richiamarla indietro, seguendo le voglie di quello che era un puro istinto animale, ma il suo cervello glielo impedì categoricamente. Jack odiava aspettare. E se aveva fatto bene i conti, non gli restavano che cinque miseri minuti dei dieci concessi per rendersi presentabile e pronto ad uscire di casa.
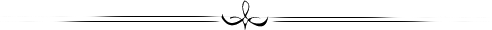
|
|
Ritorna all'indice
Capitolo 7
*** VII - Entr'acte ***
|

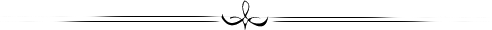
La testa di Mya tentennava placidamente a ritmo di musica. Una ciocca dei capelli castani sfuggiva ogni tanto dallo chignon tenuto fermo da una matita, ricadendole sulla fronte. Uno sbuffo per allontanarla, quasi con noncuranza, per pochi minuti appena prima che tornasse, ribelle, a fare come piaceva a lei. Ma non sembrava darle fastidio, in fondo, concentrata com’era, quasi estranea a tutto quello che le succedeva intorno. Non sarebbe stato difficile infatti, per chiunque passasse abbastanza vicino a quella panchina su cui era seduta all’indiana, percepire un fruscio distinto e sonoro dagli auricolari che indossava, cadenzato e scandito, che difficilmente avrebbe permesso a qualsiasi rumore proveniente dalla strada di giungere alle sue orecchie. Sulle gambe teneva aperta una partitura e seguiva attentamente le note stampate sulle righe pentagrammate con l’indice della mano destra. Ogni tanto, però, sollevava lo sguardo davanti a sé, soffermandosi ad osservare il formicolio di persone che facevano avanti e indietro dall’ingresso della Juilliard; poi guardava l’orologio al polso e sbuffava, un po’ scocciata, tornando a concentrandosi sulla partitura.
La Juilliard era una vera e propria opera d’arte architettonica. Non c’era turista a New York che rinunciasse all’occasione di fare un giro sulla sessantacinquesima, fra Broadway ed Amsterdam Avenue, per poterne ammirare la bellezza. All’angolo fra le due strade, nel cuore del Lincoln Center, le linee moderne e squadrate dell’edificio catturavano la vista dei passanti. Il piano superiore, quasi titanico, tagliato ad angolo acuto, aggettava senza alcuna timidezza dal basamento offrendosi alla città; la parte aperta verso Broadway assicurava tramite ampie vetrate la vista dell’interno del Conservatorio, mentre la parte opposta si mostrava ricoperta in pelle di travertino. Al centro, sopra l’ingresso, lettere dorate componevano la scritta The Juilliard School, che risplendeva nelle giornate assolate insieme ai vetri dei finestroni, restituendo alla vista centuplicata la luminosità dei raggi del sole.
Quel luogo era sinonimo di seconda casa, per la giovane Mercer. Vi aveva messo piede per la prima volta dieci anni prima. Aveva timidamente dichiarato il suo nome ai componenti della commissione, schierati per esaminare la sua audizione, e poi la sua età. Quindici anni.
Qualcuno le aveva detto che bisognava iniziare almeno a dieci, per riuscire decentemente nel canto.
Che non l’avrebbero mai presa.
Che i soldi di papino non potevano comprare l’ammissione alla Juilliard.
Ancora le sentiva, ogni tanto, nei suoi pensieri, le malignità di quelle arpie tutto intorno, le madri delle altre ragazzine che aspettavano, nella sala d’attesa, il loro turno per l’audizione. Lei non le aveva ascoltate. Aveva iniziato a cantare, semplicemente, col cuore che batteva a mille e gli occhi chiusi. Suo padre aveva avuto da ridire sul testo prescelto con cui esibirsi. A detta sua, non era una canzone adatta ad una ragazza. Ma lei, caparbia, aveva fatto di testa sua.
Quel giorno, quando la sua voce si incrinò sull’ultima strofa – proprio sulle ultime note – di Wish you were here, improvvisamente ebbe il timore di non avercela fatta. La paura di non essere abbastanza brava. Nonostante quella canzone l’avesse cantata col cuore, dedicandola nella sua mente all’unica persona che avrebbe davvero voluto accanto. Aveva chinato il capo compostamente, chiedendo scusa. Si era lasciata alle spalle il palco dell’auditorium e aveva pianto silenziosamente nei bagni, troppo orgogliosa per lasciare che qualcun altro la vedesse. Fuori, ad aspettarla, la limousine con l’autista. Aveva chiesto a suo padre di non essere presente alla sua audizione.
Non riesco a cantarla davanti a te, papà.
Non l’aveva visto, seduto nell’ombra delle luci spente, come fosse l’ultimo degli uomini qualunque. Nella fila di sedioline più distanti dal palco, acquattato come un fantasma solitario, con gli occhi lucidi mentre lei cantava, senza dire una sola parola, sparendo poi in silenzio come in silenzio era arrivato.
Qualche settimana dopo, quando ormai neanche se lo aspettava più, Mya aveva stretto fra le mani la lettera che annunciava la sua ammissione alla scuola. Non avrebbe avuto alcun dubbio, se le avessero chiesto quale fosse stato il giorno più felice della sua vita. Il ricordo dell’abbraccio che suo padre le aveva riservato quando gli aveva dato la notizia se lo conservava ben stretto, cucito a filo doppio nel suo cuore, e ne traeva forza e conforto ogni volta che il suo piccolo mondo sembrava crollarle addosso. Specie quando si accorgeva che William era troppo stremato dal lavoro. Non se la sentiva, in quei momenti, di caricarlo anche con i suoi piccoli problemi. Li chiudeva in un piccolo angolo, ricacciando dentro le lacrime, e al suo fidanzato sorrideva, lasciando che le raccontasse la sua giornata.
Stava iniziando a canticchiare sopra la musica, quando si sentì strappare via dalle orecchie una delle cuffiette.
«Secondo me tu hai una doppia personalità. Per mestiere canti lagne indescrivibili e poi ascolti i Black Sabbath!»
Mya sorrise cogliendo la frase nonostante la musica e togliendosi poi anche l’altra cuffietta dalle orecchie. Una ragazza bassina dai capelli castani cortissimi, striati da qualche ciocca bionda, si era appropriata del suo auricolare e ora agitava l’esile corpo a ritmo di musica. Parecchi ragazzi si soffermavano a guardarla, con un sorriso eloquente; colpa forse dei leggings attillati che le mettevano fin troppo in evidenza le gambe ed il fondoschiena. Un maglioncino di traverso, che lasciava una spalla scoperta, scaldamuscoli e scarpette da ginnastica. Eppure, nella sua semplicità, Mya pensava che fosse bellissima, e così sembravano pensarla gli altri alla Juilliard.
«Mi piace la musica in generale, Shaz. Non vedo perché limitarsi ad apprezzare un solo genere».
«Sarà», disse la ragazza scuotendo le spalle, «ma mi viene difficile associare il tuo bel faccino a Ozzy Osbourne!»
«Non devo mica sposarmelo!»
«Ci mancherebbe! Devi sposare quel gran bel pezzo d’uomo di Will!»
Mya richiuse la partitura, alzandosi in piedi mentre Shaz le restituiva la cuffietta.
«Andiamo a prenderci un caffè?», propose, riponendo in fretta e furia nella borsa sia la partitura che l’I-pod.
«Me lo merito proprio! Sono distrutta!»
Shaz, in realtà, era il diminutivo di Sharon Desireè Michelle Campbell. Lei odiava quell’accozzaglia di nomi scelti da sua madre, uno più svenevole dell’altro e tremendamente in contrasto con quella che era la personalità della ragazza, piuttosto determinata, a tratti mascolina. Tutti si guardavano bene dal chiamarla Sharon: era capace di fare il diavolo a quattro, quando succedeva. Studiava per diventare ballerina professionista e aveva la stessa età di Mya. Si erano conosciute proprio alla Juilliard ed immediatamente fra loro era scoccata la scintilla, quando Shaz aveva invitato gentilmente una delle allieve della scuola di canto a lasciare in pace Mya – facendo sparire quel culone enorme dalla circolazione e smettendola di sbraitare come una gallina spennacchiata – testuali parole. Da allora, facevano continuamente comunella insieme, considerandosi vicendevolmente una la migliore amica dell’altra.
Davanti a un caffè fumante, al tavolino di uno Starbucks, Shaz stava raccontando a Mya la sua giornata, parlando a raffica, logorroica come soltanto lei sapeva essere.
«… e così Lauren si stava rompendo il culo nel tentativo di fare una spaccata!», finì di dire, spanciandosi in una grassa risata e battendo le mani sul tavolo del locale, facendo voltare tutti i clienti presenti.
«Ben le sta!»
Mya si unì alla risata dall’amica. Nella confusione, il suo cellulare prese a squillare nella borsa. Lo cercò velocemente, portandolo all’orecchio dopo aver accettato la chiamata.
«Pronto?»
Shaz intanto stava adocchiando un ragazzo al bancone che sembrava mangiarsela con gli occhi. Buttò giù un sorso di caffè.
«… è uno scherzo, vero?»
La voce di Mya era poco più di un sussurro, che si interruppe bruscamente, come se la voce le si fosse spenta d’un tratto in gola. Shaz si accorse della nota di incredulità che risiedeva in quelle parole e tornò a guardarla, lasciando perdere il tipo al bancone.
Si ritrovò ad incrociare gli occhi azzurri dell’amica, improvvisamente velati di lacrime.
***
«Così è qui che devo vivere per i prossimi mesi?», disse Christopher mentre si aggirava curioso all’interno di una delle suite più costose del Plaza Hotel.
Era rimasto quasi tramortito a guardare l’albergo da lontano, arrivando dalla zona di Central Park. Quando era sceso dalla macchina, ritrovandosi in piedi sul marciapiede, aveva alzato gli occhi cercando di scorgere l’ultimo dei diciannove piani che si stagliavano in alto verso il cielo. Una fila di bandiere americane sventolavano fieramente all’ingresso, sulla facciata che mescolava antico e moderno, creando una fusione perfetta fra l’urbanistica newyorkese e uno stile di stampo Edwardiano. Non che fosse un capolavoro, anzi, a guardarlo sembrava un edificio piuttosto inquietante, specie di notte, ma era autenticamente impressionante e maestoso, come un castello posto nel centro della città. Con le sue due torrette appuntite, ai lati del tetto lineare, le bordature di bronzo e l’ampia entrata in legno con porte girevoli, quell’albergo era da sempre il simbolo della New York benestante, quella che se la spassava e che poteva spendere fino a duemila dollari per una notte in una suite.
I passi di Christopher venivano attutiti dal parquet di legno morbido del salottino della suite, ricoperto in alcuni tratti di moquette bianca. L’ambiente era perfettamente arredato con mobili di pesante legno anticato, sedie foderate di raso bianco, persino una piccola biblioteca a cui, volendo, poteva attingere liberamente. Dispenser sistemati con accortezza profumavano l’ambiente di un’essenza dolciastra, simile all’incenso, persistente ma non fastidiosa. Il giovane si fermò davanti al caminetto di marmo intarsiato, passando il palmo della mano sul ripiano liscio e perfettamente pulito.
«Un aiuto per farti sembrare ricco sfondato. E Stan ti lascia la macchina, con le dovute raccomandazioni».
Christopher inarcò un sopracciglio, voltandosi a guardare di sbieco l’uomo di colore che aveva appena parlato. Di media altezza, questi era quasi completamente calvo, ma portava attorno alla bocca e al mento un sottile pizzetto di barba. L’occhio sinistro di molto socchiuso rispetto al destro rivelava, anche ad un occhio inesperto, un pesante problema di miopia non corretto in maniera tempestiva. Si strinse nella elegante giacca nera del completo che indossava, restituendo l’occhiata al giovane.
«Non si fidava, l’altra sera?»
«Una Ferrari parcheggiata nel quartiere da schifo in cui abiti avrebbe dato un tantino nell’occhio, non ti pare? E poi non puoi mica fare la spola fra Central Park e gli Hamptons in moto».
Il giovane sorrise, dando una pacca sul piano del camino.
«Già», si limitò ad annuire, alzando lo sguardo in alto verso il lampadario intarsiato e facendolo scorrere lungo le pareti, rivestite di una bellissima carta da parati bianca e oro.
L’uomo lo squadrò da capo a piedi, scuotendo il capo con disappunto.
«Anche se conciato così sembri un tossico del cazzo, altro che ricco sfondato».
L’abbigliamento di Christopher, in effetti, stonava terribilmente con il tono lussuoso ed elegante dell’appartamento. Sulla t-shirt nero stinto si leggeva ancora, nonostante i molti lavaggi, la scritta Rock on the Road, circondata da una fiamma, sopra il disegno stilizzato di una motocicletta. Ci aveva abbinato un paio di jeans dall’aria altrettanto vissuta, che forse una volta erano stati blu scuro, o qualcosa del genere. Portava due bracciali a catena d’acciaio al polso destro, un orologio a fascia di pelle nera al sinistro, e intorno al collo si intravedeva una catenina d’argento il cui ciondolo terminava sotto la stoffa del girocollo della maglietta, protetto dagli occhi esterni.
«Non è un problema, visto la sfilza di completi e camicie con cui mi hai riempito l’armadio».
Dapprima l’uomo sorrise, annuendo. Poi il suo sguardo si soffermò lungamente sui capelli scarmigliati dell’altro, con un profondo sospiro. Christopher alzò la mano destra, facendo un cenno di diniego col capo.
«Non pensarci nemmeno, Jack. Non li taglio. Fine della storia».
«Come vuoi».
Christopher si infilò le mani nelle tasche, camminando poi verso una delle finestre, affacciata direttamente sul verde panorama offerto dal Central Park. Per qualche attimo, nel silenzio, si perse ad osservare i ragazzini che si rincorrevano spensierati nel pomeriggio di fine primavera, abbastanza caldo da far percepire sulla pelle la vicinanza dell’estate.
«Hai ben chiaro quel che devi fare?»
Il giovane annuì, voltandosi poi nuovamente verso Jack. Riempì d’aria i polmoni con una tale verve da sembrare dovesse immergersi in apnea in un oceano, ributtandola fuori con un profondo sospiro rumoroso.
«Chiarissimo».
Il suo tono di voce non dava adito ad incertezze. Jack sorrise, scoprendo i denti, soddisfatto.
«Bene. Chiamami per aggiornarmi».
«D’accordo, Jack».
Decise di guardare ancora un poco fuori dalla finestra. Sentì la porta della suite chiudersi dietro le proprie spalle e seppe di essere solo. Puntò i gomiti sul davanzale, intrecciò le dita delle mani fra di loro e posò la fronte nell’incavo formato fra i pollici. Respirò profondamente, buttando fuori l’aria. Ogni volta era così, come se si sentisse un macigno enorme sulle spalle.
Spesso si chiedeva se la sua scelta fosse stata quella giusta. Vivere una vita che non era la sua. Fingere, senza ritegno, smettendo solo nei momenti in cui la solitudine si faceva sentire, specie nelle innumerevoli notti insonni passate a rigirarsi fra le lenzuola. Ogni tanto aveva bisogno di tornare a casa, la sua vera casa, per ricordarsi di chi fosse davvero. Alle volte, quando si specchiava al mattino presto per farsi la barba, guardava lungamente la figura riflessa e si chiedeva chi fosse quell’estraneo che lo osservava di rimando, con quegli occhi malinconici che raramente mostravano vera allegria.
La risata di un bambino lo fece sorridere improvvisamente. Decise che era ora di smetterla di rimuginarci sopra. Non poteva fare altrimenti. Era la sua scelta. La sua unica preoccupazione doveva essere quella di compiere il suo dovere al meglio.
Si allontanò dalla finestra procedendo verso la camera da letto. Recuperò il telecomando ed accese la televisione, tanto per farsi compagnia. Non guardava mai la televisione a tempo perso. Il motivo era, per lo più, che di tempo da perdere non ne aveva affatto.
Si stese sul letto e chiuse gli occhi, le orecchie volte distrattamente a cogliere le voci degli speaker del notiziario del pomeriggio.
«Lutto nel mondo dell'alta finanza. Il famoso magnate dell’industria farmaceutica, Anthony Mercer, è deceduto questa mattina nella sua casa negli Hamptons».
Christopher scattò a sedere sul letto, afferrando il telecomando ed alzando al massimo il volume.
«Che cazzo…», mormorò, fregandosi il volto con una mano e passandosela poi nervosamente fra i capelli. Si coprì la bocca col palmo, quasi smettendo di respirare. Nel silenzio della stanza rimbombava solo la voce dello speaker.
«Anthony Mercer, presidente unico della Mercer Pharma Incorporated, è venuto a mancare fra le dieci e le undici di questa mattina. Il magnate, già sofferente da tempo a causa di un precedente infarto, sembra non essere sopravvissuto ad un secondo attacco di cuore, come lasciato detto dal suo medico curante, il dottor Mark Kleine, in un’agenzia di stampa autorizzata al rilascio dagli avvocati della famiglia Mercer».
Sentiva i battiti accelerati del suo cuore nelle orecchie ovattate. Deglutì pesantemente, chiudendo gli occhi e dando un pugno a vuoto sul materasso del letto.
«Cristo!»
Si cacciò le mani in tasca, cercando il proprio cellulare. Digitò velocemente sui tasti e lo accostò all’orecchio, massaggiandosi le tempie con la mano destra. Le pulsazioni del suo cuore erano aumentate ulteriormente, e ad ognuna di esse sentiva come se la testa dovesse scoppiargli da un momento all’altro.
«… Jack? Abbiamo un problema grosso come una casa».
Sibilò, fra i denti, mentre dallo schermo della televisione, ritratto in fotografia, Anthony Mercer lo guardava con lo stesso sorriso bonario che gli aveva riservato per l’intero pomeriggio quando, appena due giorni prima, lo aveva ignaramente accolto nella sua casa.
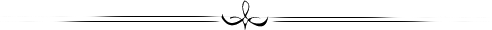
ANGOLO AUTRICE:
 
 
In quest'angolo, stasera, vorrei innanzitutto dire che la sottoscritta
- ahimè! -
non è mai stata nella città di New York.
Le strutture descritte in questo capitolo, la Juilliard e il Plaza Hotel
sono ovviamente fra i luoghi più famosi della città;
io li ho descritti basandomi su fotografie, ispirazione e tanta, tanta immaginazione.
Vi lascio quindi a tal proposito due link, per i curiosi
che volessero 'vedere' anche in fotografia i due luoghi citati.
The Juilliard School
The Plaza Hotel
In secondo luogo, volevo ringraziare tutti coloro che leggono la mia storia.
Quelli che la recensiscono, quelli che l'hanno inserita fra le seguite, le preferite o le ricordate
e anche i lettori silenziosi che seguono le avventure dei miei personaggi.
Si scrive per passione, questo è vero,
ma rende felici sapere che quel che si scrive viene apprezzato.
E infine... non vogliatemene, per quello che è appena accaduto nel capitolo.
Dovevo.
Vi lascio recapiti vari per contatti/insulti/complimenti (?)/rotture di scatole:
Pagina Facebook: Codivilla Vicariosessantanove Efp
Gruppo Facebook: La Canonica del Vicario
Ask: Chiedi e (forse) ti sarà detto
Alla prossima e grazie a chiunque passi di qui.

|
|
Ritorna all'indice
Capitolo 8
*** VIII - Requiem ***
|

VII - Requiem
Si intende per Requiem una Messa in musica
cantata e suonata in onore di un defunto.
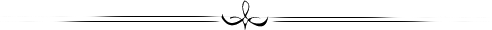
Una volta ti ho chiesto perché Dio permettesse che succedessero tante cose tristi nel mondo.
Ero solo un bambina. Mi guardasti e mi rispondesti che non era colpa sua, ma di quell’altro,
che voleva governare il mondo con la distruzione e la disperazione.
Tu non ti disperavi mai, papà. Ti rimboccavi le maniche ed andavi avanti, sempre.
Mi hai insegnato che nessun dolore sarà mai così forte da impedirmi di vivere la mia vita.
Eppure, adesso, l’intero mio mondo si è dissolto
come un castello di carte esposto ad una folata di vento.
Tu non che non amavi sprecare parole, ne avevi sempre una buona per tutti.
Le sto cercando, quelle adatte per dirti quanto mi mancherai, ma nessuna riesce ad esprimere
quello che ho dentro oggi. Per cui, papà, lascio che siano altre parole a parlare per me.
L’avresti apprezzato, e ad esse affido tutto l’amore che mi ha legata a te fin dalla mia nascita.
«Ho tante cose che ti voglio dire,
o una sola, ma grande come il mare,
come il mare profonda ed infinita...
Sei il mio amore e tutta la mia vita!» [1]
Ti voglio bene.
Mya rilesse più e più volte quelle righe, messe nero su bianco sul foglio che aveva davanti agli occhi. La grafia spigolosa e poco curata, con mille cancellature rabbiose – tanto che in alcuni punti la penna era arrivata a bucare il foglio stesso – la diceva lunga sulla confusione e l’angoscia che permeavano la sua anima quando le aveva buttate giù, nel silenzio dello studio oramai vuoto di suo padre. Avrebbe voluto leggerle ad alta voce, al funerale, quando le avevano chiesto di salire sul pulpito per pronunciare qualche parola. Ci aveva provato. Ma nell’attimo esatto in cui aveva schiuso le labbra per cominciare a leggere, aveva sentito il cuore contrarsi dolorosamente nel petto come se qualcuno glielo stesse stringendo in una morsa d’acciaio. Il respiro le era venuto meno e gli occhi le si erano riempiti di lacrime. Qualcuna era caduta sul foglio e aveva sciolto l’inchiostro, lasciandosi dietro un alone scuro come scuri e cupi erano i pensieri che le si erano affollati nella mente.
Chi era, quella folla di sconosciuti che la osservava, attendendo che parlasse? Quanti di loro conoscevano davvero suo padre, a quanti importava davvero che non ci fosse più? L’intera situazione incarnava perfettamente la fiera della decadenza e della ipocrita vanità. Era stata costretta a mettersi addosso uno dei suoi abiti più eleganti, quando avrebbe preferito non guardarsi neanche allo specchio. Il proprio volto pallido e sofferente per il poco sonno le sembrava una sconfitta nei riguardi di quello che suo padre le aveva sempre insegnato. Lui non si sarebbe permesso una tale trascuratezza. Avrebbe incanalato la sua sofferenza nelle sue passioni, come faceva da sempre, come aveva fatto anche nel momento del dolore più estremo.
Era nel ricordo di quelle raccomandazioni a non lasciarsi mai sfuggire di mano la propria vita che aveva corretto le occhiaie col trucco, legato i capelli nell’acconciatura più modesta e sobria possibile e aveva indossato i gioielli di sua madre. Se fosse dipeso unicamente da lei, avrebbe volentieri deciso per il chiudersi nella propria stanza, rifiutandosi di vedere tutti coloro che erano accorsi a porre le proprie, sentite condoglianze.
Quando però si era ritrovata davanti, dall’alto del pulpito, tutta quella oscena ostentazione di eleganza, lusso e indifferenza, l’intero suo corpo si era ribellato al rendere pubblici quei pensieri d’amore scritti su carta. Non c’era bisogno che quelle iene li conoscessero. Sarebbe stato solo un ulteriore spunto per ricamare sciatte e false parole di conforto, quando il loro unico interesse era sapere come sarebbero cambiate le carte in tavola per la Mercer Pharma, dopo la dipartita del suo presidente. Aveva ripreso fiato e ricacciato indietro le lacrime, negando alle vecchie comari imbellettate la soddisfazione di vederla, anche solo di striscio, lacerata da quel dolore che le spezzava la spina dorsale, tanto da chiedersi come riuscisse a restare in piedi. Un sommesso, ma chiaro “Scusatemi”, ed era scesa da quel pulpito che la faceva sentire esposta, osservata, come un animale allo zoo, pronta ad essere ferocemente azzannata alla carotide e giudicata criticamente per ogni singolo suo gesto, perfino per un suo respiro troppo rumoroso. Suo padre conosceva i suoi sentimenti e tanto le bastava per essere in pace con sé stessa, senza ricorrere a quella ostentata messinscena. Era tornata al suo posto, nella prima fila delle sedie approntate per il funerale nel giardino di casa Mercer, accanto a William. Si era aggrappata al suo braccio e lui l’aveva stretta a sé, mentre la funzione continuava il suo corso nel pomeriggio tiepido. Il pastore decantò in mille parole, nel suo lungo discorso, le virtù del defunto, ma lei non ne aveva ascoltata una. Aveva rifiutato di indossare gli occhiali neri per coprire il proprio volto: i suoi occhi erano quanto di più prezioso suo padre le avesse lasciato, e quei turchesi fissarono per tutto il tempo la bara sospesa sopra la buca scavata appositamente, rifiutandosi di concentrarsi su altro che non fosse il ricordo di suo padre.
Tutto quel che stava accadendo sembrava un vivido incubo da cui sapeva non si sarebbe risvegliata mai. Era fin troppo piantata coi piedi a terra per permettersi il lusso di lasciarsi andare, anche per un solo attimo, all’illusione che la morte di suo padre non fosse qualcosa di estremamente reale. Le pareva di sentire ancora la sensazione della terra secca e friabile nel palmo della mano. Aveva gettato il primo pugno della sepoltura, e mentre i giardinieri continuavano nell’opera, si era lasciata sfuggire un’unica, singola lacrima alla vista della lapide di suo padre così vicina a quella di sua madre. Anthony non aveva mai lasciato direttive in merito al luogo della sua sepoltura, ma Mya sapeva che avrebbe voluto riposare per sempre accanto all’unica donna della sua vita.
Strinse rabbiosamente il foglio accartocciandolo e scaraventandolo nel cestino sotto la scrivania. Gli incisivi affondarono nella carne morbida del labbro inferiore, e contro la muraglia parata dai suoi denti soffocò gutturalmente un grido di dolore. Chinò il capo in avanti, nascondendo il viso fra le mani e sfregandosi gli occhi gonfi e rossi dal pianto solitario che si era concessa una volta che era riuscita a scappare nella propria camera da letto.
«Non piangere, bambina mia. Lascia che il sole tramonti sul dolore e sulla rabbia, sei giovane, devi vivere la tua vita. Lui avrebbe voluto così».
Le vecchie mani rugose di Tata Betty fecero scorrere amorevolmente, per l’ennesima volta, la spazzola fra i lunghi capelli della ragazza. Mya sospirò singhiozzando sommessamente.
«Non ci riesco ora, Tata. Ho finto, davanti a tutti, perché nessuno deve captare la minima debolezza da parte mia, non con il cognome che porto. Ma adesso vorrei solo gridare fino a restare senza voce!»
L’anziana donna le carezzò pian piano la testa, mentre un nuovo accesso di pianto scuoteva le spalle di Mya. Non disse una parola di più, limitandosi a quel gesto affettuoso che la ragazza immaginava da sempre come quanto di più vicino ci fosse alle carezze di una madre.
D’un tratto, qualcuno bussò discretamente alla porta della stanza.
«Mimì, sono io».
Mya rialzò il capo, asciugandosi in fretta e furia le lacrime col dorso della mano.
«Entra pure, Will», disse, cercando di controllare la voce incrinata dal pianto.
Il viso di William fece capolino dall’uscio. Tata Betty si voltò a guardarlo e chinò leggermente il capo, uscendo silenziosamente dalla stanza. L’uomo si chiuse la porta dietro le spalle, avvicinandosi poi alla scrivania, mentre Mya si alzava lentamente voltandosi verso di lui.
«Sono andati tutti via, Will?»
L’Inglese annuì restando in silenzio. Le sopracciglia folte erano lievemente aggrottate sugli occhi castani, assorti in quella loro solita piega severa. Vi fu un lungo attimo di silenzio, durante il quale lui non smise neanche per un secondo di fissarla.
«Lo so che sei arrabbiato con me», mormorò la ragazza, facendosi più vicina a lui.
«Non sono arrabbiato, Mimì, solo che…», l’uomo scosse la testa, azzerando le distanze e accarezzando delicatamente la fronte della ragazza. «È stato scortese da parte tua sparire, dopo la funzione. Non è educato. Erano tutti qui per te».
«Erano qui perché dovevano. E quando si tratta di dovere, non c’è nessuno come te. Sono certa che hai fatto una figura molto migliore di quella che avrei fatto io».
«Ma io non sono Mya Mercer», tagliò corto lui, con un sospiro. «Avresti potuto farti vedere almeno per un attimo, al rinfresco».
Mya scosse il capo, sorridendo ironicamente a quelle parole.
«Possiamo non litigare, almeno oggi, Will? Non ce la faccio. Non ce la faccio proprio».
Posò la testa sul suo petto. Lui la strinse a sé tacendo. La cullò dolcemente cercando di acquietare gli spasmi di pianto che la facevano tremare. Guardò dritto davanti a sé, oltre la finestra sopra la scrivania, che lasciava intravedere un poco del sole che tramontava dolcemente su quella tragica giornata. In quella direzione, erano le tombe dei coniugi Mercer. Ora che anche Anthony non c’era più, Mya non aveva altri al mondo che lui. Chiuse gli occhi lasciandosi andare a quell’abbraccio.
«Ti prego, perdonami. Non è stato facile, neanche per me. Non immagini neanche quanto», sussurrò dolcemente chinando il capo verso l’orecchio della ragazza.
La sentì annuire contro il proprio petto. Quando, poi, lei rialzò il viso, si perse a guardare in quegli occhi azzurri, che trovava belli come non mai nonostante il rossore e il pianto. Cercò con dolcezza le sue labbra, sfiorandole in un bacio appena accennato.
Lei lo abbraccio più strettamente, accarezzandogli la schiena coperta dalla giacca nera.
«Lo so, Will. Adesso toccherà a te prendere ufficialmente le redini di tutto», mormorò, accoccolandosi nuovamente sul suo petto.
«Ci penseremo domani, amore mio. Ora voglio soltanto che tu stia tranquilla e che ti riposi».
«Resta con me, stanotte».
«Non vado da nessuna parte. Sono qui».
Uno spiraglio di sole, attraverso il vetro della finestra, illuminò quell’abbraccio riempiendo la stanza di un ultimo bagliore rosso fuoco, prima di lasciare il passo alla notte che avanzava. L’oscurità che scendeva pian piano avrebbe presto avuto fine con l’arrivo del nuovo mattino, e questo Mya lo sapeva bene. Quel che non sapeva era quanto ci sarebbe voluto perché sfumasse via, lentamente, l’oscurità dolorosa che le opprimeva il cuore, in quella prima notte priva dell’abbraccio solito di suo padre.
***
La lama di un tagliacarte d’argento tagliò di netto una busta sigillata, stretta nelle mani del notaio Franklin. Mya sospirò stringendo forte la mano di William, seduto accanto a lei nell’austero studio tappezzato di scaffalature in mogano, talmente ripiene di libri da sembrare che potessero esplodere da un momento all’altro. Deglutì cercando di sciogliere il nodo che aveva alla gola. Suo padre era stato seppellito appena poche ore prima, e il suo ricordo gioviale ed allegro strideva pesantemente con l’aria severa e abbottonata che regnava in quella stanza.
Il notaio dispiegò il testamento di Anthony Mercer, scorrendone le righe con attenzione, per poi osservare ad uno ad uno i presenti nella stanza. Oltre a Mya e William, c’era l’avvocato Traven, convocato ufficialmente alla lettura del testamento in veste di legale della Mercer Pharma. Si schiarì leggermente la voce.
«Il signor Mercer è stato molto chiaro, riguardo le sue ultime volontà e i suoi lasciti. Vado dunque a leggere le sue testuali parole».
Seguì un attimo di silenzio, durante il quale nessuno osò rifiatare. Il notaio, un uomo sulla mezza età dall’aria cortese e corti capelli bigi e ben tenuti, si carezzò leggermente il pizzetto riprendendo a parlare.
«Alla mia unica figlia Mya lascio in eredità il mio intero patrimonio, tutti i miei averi e possedimenti, perché ne disponga come meglio crede e come ritiene più opportuno. So per certo che ne farà il miglior uso possibile e manterrà le tradizioni portate avanti dal sottoscritto negli anni».
Mya annuì sospirando. Sapeva bene che suo padre si riferiva al mantenere le cospicue donazioni annuali in favore dei ragazzi dell’orfanotrofio sulla sessantanovesima [2]. Guardò William, che accennò a un lieve sorriso in risposta al suo sguardo mesto e ancora segnato dal lutto.
Michael si stava contorcendo sulla sedia, non trovando pace, come se fosse seduto sui carboni ardenti. Osservò il notaio socchiudendo le palpebre sugli occhi vispi e attenti, attendendo il verdetto che gli stava maggiormente a cuore e che, lo sapeva per certo, anche William stava attendendo con impazienza.
Il notaio lesse silenziosamente fra sé e sé alcune righe .
«Andiamo dunque alla questione più delicata. Devo dire che il signor Mercer ha sempre tenuto separate le sue volontà circa quel che riguardasse la Mercer Pharma da tutto il resto. Proprio ultimamente mi aveva chiesto di rifinire il testamento in merito», disse, rigirandosi le carte fra le mani e lasciando cadere il silenzio per un lungo attimo.
Michael inarcò un sopracciglio, cercando lo sguardo di William, che dal canto suo sembrava assorto nell’ascoltare il discorso del funzionario. Mya guardava distrattamente fuori dalla finestra, al cielo terso che contrastava decisamente con la tristezza del suo animo. Sospirò quieta. Una cosa era certa: nessuno al mondo sarebbe stato in gamba quanto suo padre negli affari. Neanche William, nonostante tutte le sue qualifiche e le innate capacità. Ma sarebbe stato un buon sostituto, ce l’avrebbe messa tutta per riuscire sempre al meglio.
«Molto è stato il tempo che nella mia vita ho dedicato alla mia società. Forse anche troppo, per dirla tutta. È con la speranza che egli non perda mai di vista le vere priorità che nomino il mio futuro genero, William Spencer, vice-presidente della Mercer Pharma, con tutti gli onori e gli oneri che tale titolo comporta».
La voce di Michael irruppe bruscamente e prepotentemente nel discorso.
«Vice-presidente? Che significa?!», sbottò, alzandosi in piedi.
William tacque imperterrito. Nulla nel suo aspetto sembrava tradire la minima emozione, se non quel rapido stringersi dei palmi ai braccioli della poltroncina, come se vi si afferrasse per restare più saldo. Mya ruotò lentamente la testa in direzione di Michael, stupita da quel comportamento. Aggrottò le sopracciglia, alternando lo sguardo sui tre.
Il notaio sospirò, invitando Michael a sedersi.
«Significa che c’è ancora dell’altro che devo esporvi, signori. Il signor Mercer è stato ben chiaro, avvocato Traven, non resta che attendere qualche momento, sempre se non le è di troppo disturbo».
Michael si sedette nuovamente, come un cane bastonato, limitandosi ad un cenno della mano a voler confermare all'uomo che poteva continuare.
«So che era ben altro quello che ti aspettavi, William. Ma perdonerai la malinconica sentimentalità di un povero vecchio. Non sono pronto all’idea che il nome dei Mercer venga sostituito a capo della società, probabilmente non lo sarei mai stato. È per questo che delego la carica di presidente a Mya. Lei sarà la firmataria unica e unica responsabile. Confido che l’appoggerai e la guiderai nel suo operato, e che le starai vicino come hai sempre fatto».
Mya schiuse le labbra come per dire qualcosa che morì sul nascere. Volse gli occhi azzurri sul viso teso di William, che dal canto suo continuava a guardare il notaio come se neanche si stesse rendendo conto davvero di quello che stava accadendo.
«È assurdo», articolò l’Inglese, scuotendo il capo. «Mya non ha la minima idea di come gestire un simile colosso».
«Il signor Mercer lo sapeva bene, signor Spencer. È proprio per questo che lascia ancora qualche parola, rivolta ad entrambi».
Michael sbottò in una sorta di risata isterica, scuotendo il capo. Continuava a ripetere qualcosa a mezza bocca - È inaudito. Inconcepibile! - tormentandosi le dita affusolate delle mani. Il notaio lo fulminò con un’occhiata, prima di continuare a parlare.
«Mya, durante questi anni ti ho sempre tenuta fuori dagli affari della società. Non volevo buttarti in quella mischia frenetica di squali assetati di soldi, così gentile e buona come sei. Sei in tutto e per tutto la fotocopia di tua madre, lo vedo ogni giorno, l’ho percepito guardandoti crescere. Ed è per questo che so che troverai il modo di far funzionare la cosa. Sono certo che William saprà starti vicina. Ogni mattone della società, figlia mia, io l’ho guadagnato col mio sudore e la mia fatica. Tocca a te, adesso, tenere alto il nome dei Mercer, come ho fatto io per tutti questi anni. Ad entrambi auguro tutta la felicità di questo mondo: sappiate tenervi ben strette le cose importanti della vita».
Le ultime parole del notaio rimbombarono nella testa di Mya. Fissò lungamente William. Si ritrovò a stringergli convulsamente la stoffa della giacca, sopra l’avambraccio, fra le dita serrate e tese.
«Mimì, calmati. Va tutto bene. Per favore», mormorò, aggrottando le sopracciglia alla vista del viso improvvisamente ancora più pallido della ragazza e dei suoi occhi fissi sul foglio del testamento ancora fra le mani del notaio.
Lei annuì debolmente, riprendendo finalmente fiato dopo un’apnea che le era sembrata eterna. Andava tutto bene, certo. Suo padre aveva scelto solo il modo più imprevedibile per farsi ricordare, ovvio. William avrebbe saputo come gestire tutto. Non doveva preoccuparsi.
E allora perché aveva l’impressione che il mondo le fosse appena crollato addosso?
[1] Da “Sono andati? Fingevo di dormire”, assolo di Mimì, Atto Quarto de La Bohème di Puccini.
[2] Ho fatto ricerche in merito ad eventuali orfanotrofi presenti a NY, e l'unico che ho trovato è uno che era situato proprio sulla sessantanovesima. Se così non fosse più, perdonatemi l'errore.
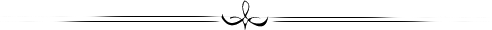
|
|
Ritorna all'indice
Questa storia è archiviata su: EFP
/viewstory.php?sid=2208383
|