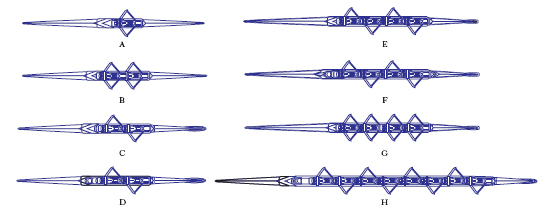Zaffiri multicolor di Elsira
(/viewuser.php?uid=830850)
Disclaimer: Questo testo proprietà del suo autore e degli aventi diritto. La stampa o il salvataggio del testo dà diritto ad un usufrutto personale a scopo di lettura ed esclude ogni forma di sfruttamento commerciale o altri usi improri.
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Premessa ***
Capitolo 2: *** Pagina 1 ***
Capitolo 3: *** Pagina 2 ***
Capitolo 4: *** Pagina 3 ***
Capitolo 5: *** Pagina 4 ***
Capitolo 6: *** Pagina 5 ***
Capitolo 7: *** Pagina 6 ***
Capitolo 8: *** Pagina 7 ***
Capitolo 9: *** Pagina 8 ***
Capitolo 10: *** Pagina 9 ***
Capitolo 11: *** Pagina 10 ***
Capitolo 12: *** Pagina 11 ***
Capitolo 13: *** Pagina 12 ***
Capitolo 14: *** Pagina 13 ***
Capitolo 15: *** Pagina 14 ***
Capitolo 16: *** Pagina 15 ***
Capitolo 17: *** Pagina 16 ***
Capitolo 18: *** Pagina 17 ***
Capitolo 19: *** Non Scritto ***
Capitolo 1
*** Premessa ***
Premessa
“I suoi occhi, erano soliti brillare così intensamente.”
- Sconosciuto
So che di solito non si iniziano così i racconti, ma… Per poter cominciare questa storia, è necessaria una breve introduzione in cui vi spiego come ha avuto inizio tutto quanto. Anzitutto, salve: io sono Camilla e la storia che state per leggere è quella mia e di Arkin.
Sì, lo so che è un nome strano: lui è norvegese. O meglio, mezzo norvegese. Si chiama così perché sua madre è di Arendal e prima che il mio amico venisse al mondo, i suoi genitori decisero che se fosse nato un maschio il nome lo avrebbe scelto la madre, mentre fosse stata femmina lo avrebbe scelto il padre. Nacque un maschietto, perciò la madre ebbe campo libero, dando ad Arkin un nome di cui è sempre andato orgoglioso e che ha sempre sfoggiato al massimo della sua bellezza, sin da bambino.
Se mi chiedeste come ci siamo conosciuti, non saprei rispondervi. Non per male, ma perché il nostro primo effettivo incontro accadde talmente tanto tempo fa che non riesco davvero a ricordarlo. Rammento solo la prima volta che mi dette un bacio, sulla guancia, innocente e gentile, come l’età che avevamo. Rammento il primo regalo che mi fece, subito dopo: un piccolo biglietto ritagliato a forma di cuore al cui interno aveva disegnato noi due, mentre mi dava suddetto biglietto. Era un disegno davvero orribile, anche per la nostra tenera età, ma d’altronde lui non è mai stato bravo a disegnare.
Non so dopo quanto tempo che ci conoscevamo sia successa questa cosa, so solo che da quel giorno, quella mattina indefinita del primo anno di scuola materna, ci mettemmo insieme e, tutt’oggi, non ci siamo ancora burocraticamente lasciati. La realtà è che fummo “fidanzati” per la durata della materna, anche se a me piaceva un altro bambino, il terzo membro del nostro gruppetto: Paolo.
Eravamo indivisibili, noi tre. Tutti i giorni giocavamo insieme, passavamo l’ora del pisolino uno accanto all’altro, eravamo seduti vicini alla mensa, in classe e sul pulmino; spesso passavamo il tempo assieme anche dopo scuola, a casa di uno dei tre, fino all’ora di cena. Abbiamo anche dormito assieme di notte, qualche volta. Nemmeno le vacanze estive ci potevano tenere lontani.
Loro due erano i migliori amici che avessi mai potuto desiderare di avere e che io abbia mai avuto.
Con l’iniziare delle elementari però, tutto cambiò: i miei divorziarono durante il primo anno di scuola e io andai ad abitare con mia madre in un’altra città. Anche se poco distante, l’unica occasione in cui il nostro trio si riuniva era durante l’ora del catechismo il sabato pomeriggio.
Ricordo che non mi piaceva affatto, il catechismo, ma c’erano loro due e questo mi bastava per andare a svegliare mia madre dal riposo pomeridiano e trascinarla a forza fuori di casa per evitare di far tardi. Non volevo perdere nemmeno un minuto da poter passare con Paolo e Arkin.
Tale situazione durò per un paio di anni scarsi, perché in vista della prima comunione dovetti iniziare a frequentare il catechismo della Chiesa della mia nuova città.
Ricordo ancora il momento in cui lo dissi loro. Eravamo sull’altalena che ci dondolavamo, quando a un certo punto mi fermai e dissi che non mi avrebbero più vista lì. Si arrestarono entrambi di colpo, guardandomi con gli occhioni lucidi. Mi chiesero se stessi scherzando, io risposi di no.
Rimanemmo tutti e tre in silenzio, fino a che la voce di mia madre ci raggiunse. Scesi dall’altalena e mi diressi alla macchina, voltandomi a metà strada e facendo un timido cenno di saluto con la mano. Paolo tirò un piccolo sorriso in risposta e alzò la mano, Arkin non mi guardò neppure, preferendo tenere lo sguardo puntato a terra con una smorfia in volto che era il tentativo di trattenere le lacrime. Ci rimasi male, ma non poteii nemmeno affermare che mi aspettassi comportamenti diversi.
Sempre gentile e altruista, il mio Paolo.
Sempre capriccioso e orgoglioso, il mio Arkin.
Non li vidi né sentii più, sino a uno dei giorni più brutti della mia vita. Era estate, più precisamente il 14 luglio del 2010, il mese tutt’ora più insopportabilmente caldo della mia esistenza. Fu il primo anno che non passavo le vacanze estive al mare, stavo camminando con la mia migliore amica dei tempi delle medie quando ci fermammo all’edicola per prendere un giornalino. Uno di quelli tipici da tredicenni, pieni di poster delle star della Disney che se ritrovi dopo qualche anno ti viene da fare un facepalm epico e chiederti come hai potuto spendere tanti soldi in cretinate del genere. Ma all'epoca ti sembrava di star facendo gli affari di una vita.
Mentre la mia amica si fiondò dentro, per esaminare gli ultimi arrivi alla ricerca del giornalino che aveva il poster più bello, e soprattutto mancante, degno di poter andare a unirsi agli altri sul muro ormai completamente coperto delle nostre camere da letto, io rimasi all’entrata dell’edicola, pietrificata davanti alla civetta. Non mi ero mai fermata a leggere il giornale, sia mai gli articoli di cronaca, con tutte le loro brutte notizie; in fondo, a me che me ne poteva importare se a Milano un uomo aveva rapinato una banca? Io manco c’ero mai stata ancora, in una banca, per non parlare di Milano. Per questo non seppi spiegare cosa avesse guidato i miei occhi quel giorno: il destino, il karma, Dio, Babbo Natale, Son Goku, Jack Frost, chiamatelo come vi pare, fatto sta che i miei occhi si incollarono alla foto del ragazzino appena adolescente e, per la prima volta in vita mia, lessi un articolo di giornale. La foto era quella di un Paolo appena adolescente, a lato della pagina; sotto, la didascalia con il suo nome, in alto il titolo che ricordo tutt’oggi come se lo avessi ancora di fronte agli occhi: “Bimbo di tredici anni muore mentre gioca a calcio”. Mi sentii mancare e caddi a terra in ginocchio, mentre le lacrime mi rigavano il viso. Fu un pianto silenzioso, di quelli che ti fanno estraniare dal resto del mondo, non importa cosa possa accaderti intorno. Privo di singhiozzi o scosse al petto, perché già di suo troppo doloroso, tanto che il corpo ha paura di fare qualsiasi movimento, rischiando di innescare un qualche meccanismo di autodistruzione.
La mia amica e l’edicolante mi vennero subito vicini, cercando di farmi rinvenire e dicendomi parole che non riuscivo a sentire. Ero già nella mia bolla di disperazione. Tutto ciò che mi occupava gli occhi era il volto del mio amico e a riempirmi la mente sola una parola, che non riuscivo in alcun modo a metabolizzare: morto.
Al funerale ricordo di esserci andata da sola e di nascosto, non volevo nessuno in quel momento. Sgattaiolai via di casa mentre mio fratello e mia madre dormivano beati, lasciando un biglietto con scritto che me ne andavo a guardare l’allenamento di canottaggio dei senior, dato che erano gli unici ad avere il permesso di scendere in barca senza l’allenatore. Presi dunque la bici e pedalai quelle due ore e mezza che mi distanziavano dal mio vecchio paese, ringraziando che le persone la domenica mattina preferissero dormire piuttosto che stare per strada.
Ricordo ancora la chiesa stracolma, l’aria irrespirabile estiva, la bara del mio amico d’infanzia in mezzo a tutto; il dolore che mi squarciava il petto, ma restava nascosto.
Restai in disparte per tutto il tempo, non riuscendo a distogliere lo sguardo da quella maledetta cassa. I ricordi del bambino che avevo conosciuto che mi affollavano la mente e scorrevano uno dietro l’altro a una velocità allucinante. Non esisteva altro, in quel momento. Non ebbi nemmeno il coraggio di andare dai suoi genitori per far loro le condoglianze, certa che non mi avrebbero nemmeno riconosciuta. A oggi, è ancora una cosa di cui mi pento.
L’unico barlume di lucidità ce lo ebbi quando vidi Arkin, impossibile non riconoscere quei due zaffiri. Era in prima fila e i genitori avevano speso due parole tremanti per ringraziarlo, dopo che aveva salutato Paolo.
Quando mi passò davanti nell’uscire dalla chiesa, i nostri occhi si erano incontrati per un breve istante. Ricordo bene la sensazione di quell’attimo: fu come se il suo sguardo mi avesse inflitto una pugnalata al centro del petto.
Non sapevo se lui mi avesse riconosciuta, perché non aveva fatto alcun cenno, ma non aveva importanza: mi ero sentita male, quegli occhi blu mi avevano fatto male.
Sono passati anni, il dolore per Paolo si è fatto sopportabile con il tempo. Ancora una parte di me, quella più razionale, è sempre stata incapace di comprendere come fosse possibile che abbia fatto così male perdere qualcuno con cui non avevo più contatti da anni. Ciononostante, il dolore non se n’è mai andato del tutto. Io non l’ho mai superato, né dimenticato, l’ho solo nascosto, sempre.
D’altronde, nascondere le mie emozioni, cercare con tutte le mie forze di non riconoscerle, è sempre stato tutto quello che sono riuscita a fare. Se non le riconosco, non le devo affrontare: in questo modo, persino la paura e la rabbia diventano cose di poco conto, che riesco a tenere a bada quel tanto che basta per liberarle nei momenti più appropriati, come quando di notte sono sola e posso piangere quanto voglio, senza rischiare che nessuno mi senta o mi veda.
Tranne Grugra, il mio gatto mezzo selvatico. Ma di lei non mi vergogno.
All'inizio della storia che segue, stavo frequentando il terzo anno di Università e tutto stava procedendo bene. Da sempre non vedevo l’ora di andare alla facoltà di Scienze del Turismo e in quel momento mi pareva tutto quanto un bellissimo sogno. O almeno, così credevo. Sono una di quelle persone che ha sempre saputo cosa voleva fare sin da bambina: dirigere un mio albergo. Il sogno rappresentato sulla dreamboard nella mia cameretta sarebbe quello di avere un albergo con vista sui monti della mia terra, un po’ rustico, con possibilità di far fare ai clienti delle passeggiate a cavallo, escursioni e quant'altro. Qualsiasi cosa per poter permettere ai turisti di scoprire quanto sia meravigliosa la mia terra natia.
Comunque, adesso non è più il momento di sognare, devo tornare coi piedi per terra e raccontarvi la storia che vi ho promesso sin dall’inizio. Ed è quello che farò adesso, a cominciare dalla prossima pagina!
Eh sì, dalla prossima pagina, perché ora sono le tre e mezza di notte e se vengo scoperta ancora sveglia non arrivo integra a domani…
Camilla
Le scritte in nero sono dal punto di vista di Camilla, quelle in blu saranno dal punto di Arkin.
Attenzione
Come avrete potuto già notare, questo racconto è scritto utilizzando la prima persona dei protagonisti. Siccome entrambi sono toscani, del centro oltretutto, anche il loro racconto è in toscano, soprattutto per quanto riguarda i dialoghi. Ho avuto come beta readers dei non-toscani che mi hanno assicurato che è perfettamente chiaro anche a chi non di zona, ma ci tenevo comunque a chiarire subito questa cosa. Alcuni dialoghi saranno in “dialetto stretto” e questi ultimi saranno accompagnati da delle “traduzioni in italiano” tra parentesi, così come le traduzione di norvegese e francese.
Questa storia parla di fatti e personaggi in parte realmente accaduti e vissuti. Per questioni di privacy, la maggior parte dei nomi sono stati cambiati.
Woah. Non pensavo di tornare a pubblicare qualcosa, dopo, quanto...? Un paio d'anni...?
Lo ammetto, una parte di me credeva non sarei più tornata. E invece eccomi qui. Questa storia dovevo farla uscire dalla memoria del computer, in un modo o nell'altro. L'avevo già pubblicata qualche tempo fa (parlo di anni, me disgraziata), ma poi... Oddio, onestamente c'erano stati eventi che avevano fatto decidere di cancellare. Poi quel che è successo l'anno passato me l'ha fatta riprendere in mano e mi son decisa a finire di scriverla e "metterla via". Almeno, nella mia testa, diventerà un qualcosa di "fatto" anziché "resta nella memoria del computer per una vita". Mi sono rotta di avere le cose nella memoria del computer per una vita, sempre per un motivo o per un altro, lasciarle lì ad ammuffire. Che senso ha, dico bene? Una fa un lavoro sì per se stessa, ma per poterlo poi pubblicare in qualche modo, e poter andare avanti. Ecco, questo è il principale motivo per cui ho deciso di pubblicare: andare avanti. Non avere quel racconto completo nel database che sta lì, mi vado a rileggere ogni tanto, lo cambio di continuo, una frase qui, una frase là, anziché concentrarmi su progetti nuovi, su cose che magari mi interessano anche di più. Magari questa cosa non avrà senso per molti di voi, ma so che, dietro quello schermo, c'è almeno una persona che ha capito perfettamente quello che intendo e tanto mi basta.
Di solito, racconti "complessi" come questo li dedico a qualcuno... Anche solo per pulirmi la coscenza. Ma questa volta no, questo racconto non lo dedico a nessuno, se non hai suoi personaggi. Sono loro che fanno la storia e, per quante sberle mi vien voglia di dar loro in un sacco di momenti, senza di loro non ci sarebbe il racconto. Quindi questa volta, questa storia è dedicata solo ed esclusivamente ai suoi personaggi! Sorry lettori
Beh, io penso di aver parlato abbastanza... Ci risentiamo al prossimo capitolo magari, eh. Sabato prossimo, ciao ciao!

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 2
*** Pagina 1 ***
Pagina 1.
Ci sono persone che potrebbero incontrarsi in milioni di vite e sempre riconoscersi,
altre che saprebbero incontrarsi milioni di volte e sempre perdersi.
Qualcuno lo chiama destino,
io la chiamo consapevolezza.
- Massimo Bisotti
Quella sera di fine marzo feci più tardi del previsto all’Università, ritrovandomi costretta a prendere il treno che era ormai buio.
Ho paura di davvero poche cose, in cima alla lista ci sono i pidocchi e le lumache, ma la stazione dopo il tramonto è una situazione che mi spinge a stare costantemente all’erta.
Indossai le cuffie e misi a random le canzoni che avevo sul telefono, nel vano tentativo di rilassarmi. Il breve viaggio di appena venti minuti trascorse tranquillo e scesa dal treno mi diressi a passo svelto verso casa di mio padre. Nelle orecchie iniziò a suonare la sigla di Dragon Ball, la prima stagione, la voce di Giorgio Vanni mi fece finalmente distendere un poco i nervi e mi strappò un piccolo sorriso.
Avevo sempre adorato Goku, mi ero innamorata perdutamente di lui dal nostro primo incontro e non lo avevo più abbandonato; per quanto potessi crescere, “diventare adulta”, lui si era preso un pezzo del mio cuore di bambina e non lo avrebbe mai lasciato. Era suo e lo sarebbe stato sempre.
Era stato il mio eroe dell'infanzia, il mio forse unico punto fermo nel periodo di maggior trambusto della mia vita: che fossi a casa di mia madre, a casa di mio padre, a casa dei nonni o del babysitter di turno, non importava quanto “pacco postale” mi sentissi, Goku era lì, dal lunedì al venerdì, alle 13h40 su Italia 1, con una linea di eventi logica e costante, che non veniva spezzata da niente, in cui tutto era collegato. Mi aveva trasmesso valori che mi accorsi di aver ricevuto solo da più grande e sui quali avevo inconsciamente basato gran parte della mia vita e della mia stabilità mentale. E sapevo che me li aveva trasmessi lui, perché nella mia famiglia li avevo solo io, anche per questo gli ero infinitamente grata.
Qualche altro passo, nelle orecchie a suonare la parte “da intenditori”, come la chiamava quello che presto sarebbe diventato mio cognato, che altri non era che la parte della canzone estesa che non si sentiva alla tv.
Ero appena arrivata a rilassarmi totalmente nella melodia tanto da mettermi a canticchiare nella mia testa assieme a Vanni, che mi sentii sfiorare la spalla. Spostai appena lo sguardo e vidi che si trattava di una mano maschile. Giuro, ciò che accadde il momento successivo a quella vista fu completamente fuori dal mio controllo, non lo feci intenzionalmente, nel modo più assoluto. E ancora mi sento in colpa. Senza sapere né come né perché, due secondi dopo quella vista, mi ritrovai con il polso della mano che mi aveva sfiorata stretto nella mia destra, una schiena davanti alla faccia e l’altro mio braccio piegato ad angolo retto a fare pressione sulla gola del malcapitato.
Ci vollero un paio di secondi buoni prima di riuscire a rendermi conto cosa avessi appena fatto e liberare il tipo dalla mia presa. Mi tolsi in fretta le cuffie e, con il volto completamente a fuoco per l’imbarazzo, chiusi gli occhi e unii le mani a preghiera, implorando perdono.
«Tranquilla… Non è successo nulla… Ma sta’ più attenta, io volevo solo dirti che ti era caduta la felpa, mica molestarti.» Disse ironico lui, voltandosi e porgendomi l’oggetto in questione, mentre ancora si massaggiava la gola. Sollevai le palpebre con espressione colpevole, per fargli ancora le mie scuse, quando rimasi ammutolita, intrappolata in quegli occhi color zaffiro, rimasti immutati anche dopo tutto quel tempo.
Restammo entrambi in silenzio e immobili per secondi eterni, semplicemente a guardarci, entrambi con gli occhi sbarrati e increduli.
«Camilla…» Sussurrò appena lui. Io risposi, altrettanto flebile: «Arkin…»
Per la seconda volta in quel giorno, non riuscii a controllare il mio corpo: spezzai l’immobilità che si era creata tra noi e gli avvolsi il collo in un abbraccio. In un primo momento lui rimase immobile, rigido sotto il mio tocco, dopodiché si sciolse e mi circondò la schiena. Nascosi in automatico il volto nell’incavo che aveva tra il collo e la spalla, mentre respiravo il profumo di abete che aveva sempre avuto la sua pelle. Non quello orribile e invadente dei deodoranti per auto, ma quello autentico, frizzante, che ti fa pizzicare il naso e ti fa venire in mente i boschi cosparsi di neve della montagna o dei luoghi freddi.
Lo aveva sempre avuto, il mio Arkin, quel meraviglioso profumo.
Mi strinse più forte, scavalcandomi la spalla con il mento, mentre io non riuscivo semplicemente a crederci.
Sarà sembrato scontato, ma nonostante non abitassimo poi così lontani, non avrei mai pensato di incontrarlo di nuovo.
«Arkin, tutto bene?» La voce femminile alle mie spalle mi riportò al presente, facendomi voltare con espressione scocciata, perché avrei voluto che quell’abbraccio non si interrompesse così in fretta.
«E tu chi sei?»
Avrei potuto farle la stessa domanda, ma mi bastò un’occhiata lampo per capire chi fosse: un’oca, il tipo perfetto che avrei voluto prendere a sberle già solo per come si vestiva. Ma come si fa ad andare in giro con il tacco 15 a spillo in pieno giorno? Okay, era il tramonto passato ormai, ma insomma… Oltretutto con un vento gelido come quello, come faceva a stare a gambe scoperte? Ah no, scusate, non erano scoperte, aveva le calze strappate, sotto gli shorts a metà chiappa…
Oc- “No, Cami... Ferma. Non si giudicano le persone, lei può vestirsi come cazzo le pare, è un suo diritto. Conta fino a dieci e se non ti piace, guarda dall'altra parte.”
«Manu, questa è Camilla, una mia amica d’infanzia.» Mi presentò Arkin, sciogliendo completamente l'abbraccio e distanziandosi di un passo da me. La sua mano rimase comunque a sfiorarmi il braccio come una carezza, velato tentativo di far calmare Manu e allo stesso tempo non offendere me per il distacco quasi improvviso.
«Oh, un’amica d’infanzia? Allora tutto a posto!»
“Dio che sorriso falso.”
«Per un attimo, a vedervi così appiccicati, avevo creduto fosse ben altro.»
“Certo che, a prescindere da come ti presenti, me lo rendi davvero difficile però, non odiarti a prima vista…”
«In effetti, sono stata la sua fidanzata fino alla seconda elementare.» Dissi, in uno scatto d'orgoglio, rendendomi conto solo in un secondo momento di quanto disperata poteva sembrare come frase, ma non mi importava. Lei mi fulminò con lo sguardo, occhiata che ci misi meno di un istante a ricambiare altrettanto calorosamente. “Okay, ti sei appena fatta una nemica, bella.”
«Comunque, biscottino…» Tornò a rivolgersi ad Arkin, ignorandomi. Io lanciai un’occhiata al mio vecchio amico, unendo le labbra tra loro con forza per trattenermi. Lui scostò lo sguardo dalla parte opposta a me, il suo braccio salito non so bene quando ad avvolgermi le spalle, passandosi nervosamente la mano libera nei capelli, facendomi capire che aveva compreso perfettamente il motivo di quella mia occhiata veloce.
Manu aprì la bocca, ma prima che un qualsiasi altro suono potesse uscirne, Arkin le si avvicinò e le disse, spingendola delicatamente per le spalle verso la porta: «Perché intanto non ti avvii in negozio? Io ti raggiungo subito, saluto Camilla.» Lei mi lanciò un’occhiata fulminante, prima di acconsentire e fare come il mio amico le aveva richiesto, congedandosi con un semplice e gelido: «Moviti.»
Mi trattenni dal salutarla ironicamente con la mano, concentrandomi per non mostrare il sorriso della vittoria sul volto, più che altro perché non volevo far passare guai ad Arkin. Se quella era la sua fidanzata, di guai ne aveva già abbastanza.
«Biscottino?» Chiesi dopo secondi di silenzio, mordendomi le labbra per non scoppiare a ridergli in faccia. Lo vidi fare una smorfia adorabile, guardando il cielo e portandosi una mano ai capelli biondi. «Già… Ecco… Gliel’ho detto di non chiamarmi così, ma…»
«Ah, ma non è mica un problema dai. Certe persone non sanno trattenersi da affibbiare nomignoli pucci pucciosi ai loro partner.» Dissi io in un sorriso, scuotendo la mano in cenno che non era la prima volta che sentivo cose del genere. E per mio dispiacere, non era davvero la prima volta. «E di’ un po’, come altro ti chiama? Orsacchiottino? Amorino? Cucciolotto? Trottolino amoroso?» Mi voltai appena per guardarlo e mi dovetti sforzare veramente tanto per non scoppiare a ridergli in faccia, vista l’espressione che fece al sol sentir pronunciare quei nomi. Al che non seppi evitarlo e chiesi, incredula: «No… non ci credo… Ti chiama veramente “trottolino amoroso”?» Il rossore che gli infiammò le guance parlò anche troppo esplicitamente. Non ebbi bisogno di altre conferme e non riuscii più a trattenermi, iniziando a ridere tanto che mi uscirono le lacrime dagli occhi.
«Ah ah ah… Davvero divertente, sì…» Bofonchiò lui, infilando le mani nella tasca dei jeans scuri per tirarne poi fuori il telefono e porgermelo. «Lasciami il tuo numero.» Io lo guardai che mi stavo ancora asciugando gli occhi, dopodiché mi sforzai, veramente tanto, di smettere e tornai eretta, sorridendogli. Presi lo smartphone e vi salvai il mio numero, per poi porgerglielo nuovamente. Lui mi fece uno squillo, in modo che avessi anch’io il suo, dopodiché lo salutai con un cenno della mano.
Feci in tempo a fare pochi passi, che mi sentii chiamare e mi voltai. Lo vidi portarsi indice e medio uniti alla fronte e allontanarli subito dopo, sussurrando in un sorriso dolce: «Vi ser deg, min lille stjerne. (Ci vediamo, stellina mia.)»
Mi scappò un sorriso, per poi imitare il suo gesto e rispondere: «Vi ser deg, min skytsengel. (Ci vediamo, mio angelo custode.)»
Mi strizzò l’occhio, dopodiché lo vidi entrare nel negozio di abiti. Mi voltai, riprendendo la via verso casa di mio padre con un sorriso che mi attraversava il volto da parte a parte e non accennava minimamente a svanire.
«Hey, Arkin, devo dirti una cosa.»
«Ma che sei ancora sveglio…»
«Ho appena sognato Camilla.»
«Chi?»
«Camilla… Non è possibile che non ti ricordi di lei!» Paolo mi aveva guardato con le sopracciglia chiare vicine tra loro, seriamente frustrato. Io avevo alzato un sopracciglio, ancora assonnato, non comprendendo il motivo di quello sguardo fulminante. «Intendi la bimba della materna?»
L’espressione del mio amico si era improvvisamente ammosciata, sin troppo. Odiavo quell’espressione, era quella che adottava quando parlava agli idioti. «Certo, chi altra?»
«Che ne so io…» Sbuffai infastidito, rigirandomi dall’altra parte del letto dell’hotel in cui stavamo alloggiando per partecipare al torneo di calcio estivo organizzato dalla regione. In realtà, era più un raduno che un campionato vero e proprio, ma noi volevamo comunque il primo posto. Il giorno successivo avevamo la finale, alla sera saremmo tornati a casa; quella notte l’avremmo dovuta passare a riposare, non a chiacchierare.
Erano passati secondi di silenzio, perciò avevo chiuso gli occhi e mi stavo preparando ad addormentarmi, convinto che il mio amico avesse finito di parlare a vanvera. Speranza che era stata spezzata subito. «Comunque. Stanotte ho sognato Camilla e quando mi sono svegliato, mi sono accorto che stavo piangendo.»
Mi ero voltato verso di lui, un’espressione interrogativa in volto e un braccio lasciato cadere morbido sul torace, rimasto lì per la posizione laterale che avevo fino a pochi istanti prima.
«A te… non manca la nostra amicizia?» Mi aveva chiesto con un piccolo sorriso sulle labbra, il tono di voce basso e nostalgico, gli occhi puntati verso il soffitto scuro.
«Non ci ho mai pensato.» Avevo risposto, dopo qualche istante. La voce mi era uscita più bassa e triste di quel che avessi voluto. Paolo aveva riconosciuto subito quel mio tono di voce: si era voltato con un sorriso raggiante verso di me, sorreggendosi con il braccio sul materasso per tirarsi un po’ su e puntare meglio quegli occhi azzurri come il cielo più sereno nei miei, esclamando entusiasta: «Beh, pensaci ora!»
Mi ero voltato dall’altra parte, grattandomi nervosamente i capelli corti e borbottando, imbarazzato nemmeno io sapendo per cosa: «Mmmh… Sì, un po’ mi manca…» Il ricordo dell’ultima volta che l’avevamo vista mi aveva colpito prepotentemente, facendo indurire il mio tono e il mio sguardo all’istante, prima di voltarmi verso il mio migliore amico e continuare: «Ma d’altra parte, non posso farci nulla. È lei che se n'è andata e le amicizie finiscono.»
Il sorriso di Paolo non aveva accennato a sparire, né diminuire. «Sì ma, ora siamo grandi… Potremmo rintracciarla e tornare amici.»
«Credo sia cambiata, non sarà più la bambina che conoscevamo… E noi non siamo più i bambini che eravamo. Certe amicizie è meglio averle solo come ricordo.» Avevo detto, iniziando a essere seriamente frustrato da quella discussione. Non avevo fatto in tempo a sbuffare, che le parole colme di speranza del mio amico mi avevano raggiunto le orecchie: «Non sono d’accordo.»
Ovvio che non lo era... Lo avevo guardato con occhi confusi, mentre lui si voltava verso la finestra e il cielo ormai scuro e stellato oltre a essa. «A me piacerebbe poterla ritrovare un giorno, riallacciare i rapporti con lei e tornare a essere uniti come un tempo… Sai… In realtà, sognarla mi ha fatto venire in mente che mi piaceva da piccoli…»
«Certo che ti piaceva, passavamo le giornate assieme, a provare che ti stesse pure antipatica.»
Avevo sbuffato, passandomi ancora una mano nei capelli. Lui abbassò le palpebre, esclamando allegro, rivolto nuovamente verso di me: «No, intendo… mi piaceva, piaceva… Volevo che fosse la mia fidanzatina.» A quella confessione, mi si era gelato il sangue e lo avevo guardato con occhi spaccati. Lui aveva ricambiato la mia sorpresa con uno dei suoi sguardi più dolci, affermando con una sincerità nella voce di cui non avevo mai potuto dubitare: «Ma sono stato molto felice quando vi siete messi insieme voi due. Ho sempre fatto il tifo per voi e lo rifarei anche oggi. Siete semplicemente perfetti insieme. Credo davvero che nessuno di voi due potrebbe mai trovare un partner in grado di domare l’altro così bene.»
«Io non devo essere domato, non sono un animale!» Il mio cuscino lo aveva colpito in pieno volto, strappandogli una risata divertita, per poi tornare da me quando ormai gli avevo già dato nuovamente le spalle. «Sei davvero strano oggi… Si può sapere che ti è preso? Nervoso per la partita di domani?»
«Mah… Può darsi… Dev’essere il sogno che mi ha un po’ sconquassato…»
Ero restato in silenzio, rannicchiandomi ancora un po’ sotto il lenzuolo fresco e chiudendo gli occhi, godendo del vento leggero che ci concedeva il ventilatore a soffitto in quella notte oltremodo afosa.
«Ehi, Arkin…» La voce di Paolo era risuonata ancora nella stanza, facendomi saltare i nervi e distraendomi dal dormiveglia in cui mi ero appena crogiolato. «Possibile che sei ancora sveglio? Che c’è…»
Mi aveva risposto in un sussurro appena udibile: «Se domani vinciamo, rintracciamo Cam e riallacciamo i rapporti con lei…»
Ormai completamente sveglio, avevo riflettuto qualche istante prima di rispondergli. «Ti ho già detto che non credo sia una buona idea… E chissà dov’è…»
«Io voglio farlo… Credo che, anche se siamo cambiati, andremo di nuovo tutti e tre d’accordo come un tempo.» Aveva ripetuto, con più convinzione. Tanta convinzione che mi aveva portato a voltarmi verso di lui e guardarlo negli occhi, non riuscendo a contraddirlo un’ulteriore volta.
Le sue sopracciglia si erano avvicinate tra loro, quegli occhi pieni di energia mi avevano incatenato a loro, imprigionandomi nella loro determinazione. «Promettimelo, Arkin. Se domani vinciamo la coppa, riallacciamo i rapporti con Cam e torniamo a essere felici come allora.»
«Zitto e dormi…» Avevo borbottato duramente, dandogli per l’ultima volta le spalle, deciso a non voltarmi più verso di lui quella notte. Nonostante non lo vedessi, ero perfettamente conscio che quello sguardo non fosse minimamente cambiato. Avevo tirato un sospiro e, prima di abbassare le palpebre, avevo bisbigliato: «Devi riposare, altrimenti non potremo dare il meglio in campo. E vincere.»
Avevo udito un energica affermazione e il suono del lenzuolo che si avvolgeva attorno al suo corpo. «Cam… Aspettaci… Domani vinceremo per te.» Lo aveva detto con un ultimo sussurro leggero, appena udibile, prima che io sentissi il suo respiro farsi più pesante e, quindi, informarmi che si era finalmente assopito. Avevo chiuso gli occhi anch’io, intrecciando le dita delle mani davanti al volto, come a tenere la mano di qualcuno.
Per la prima volta dopo anni, quella notte avevo nuovamente sognato Cam.
“Se solo avessi saputo che quella era l’ultima notte della tua vita…”
Scostai gli occhi dal campo da calcio e alzai lo sguardo verso il cielo. La luce di una stella, più luminosa delle altre, mi catturò gli occhi. Ripensai inevitabilmente al mio amico, rimasto fermo all’età di tredici anni. Chiusi le palpebre e me lo immaginai seduto lì accanto a me su quella panchina, che batteva nervosamente i tacchetti delle scarpe da calcio sull’erba, in attesa del suo turno di entrare in campo e giocare.
Odiava stare fermo ed era un ottimo giocatore, probabilmente il migliore della squadra ma, per qualche strano motivo, il mister lo faceva entrare sempre solo nel secondo tempo. Solo dopo intuii che fosse perché sapeva del suo male al cuore e non voleva che si sforzasse troppo.
Ricordo che, fino all'ultimo, non era certo se sarebbe venuto al raduno o meno. Fui io, stupidamente e con la supponenza di un ragazzino che non capisce nulla, che andai a casa sua e convinsi i genitori a lasciarlo venire. Dissi persino loro che non si dovevano preoccupare di nulla, che lo avrei tenuto d'occhio personalmente e non gli sarebbe capitato niente.
Che coglione.
“Eppure loro non mi hanno mai odiato... Anzi…”
Ogni volta che mi capitava di incrociarli, mi salutavano sempre con un sorriso colmo di affetto e mi trattavano come fossi uno di famiglia.
L'altro giorno, al bar, avevo incrociato per caso suo padre e aveva insistito all'inverosimile per offrirmi la colazione. Eravamo rimasti a parlare quasi mezz'ora di tutto e niente, mentre mangiavamo una pasta assieme. “A ripensarci mi sembra impossibile.”
La sera antecedente alla partita, Paolo mi aveva parlato di voler tornare a essere felice. Non avevo idea di che cosa stesse parlando: ai miei occhi lui era sempre raggiante, pieno di energia, incapace di stare fermo e contenitore di tanto entusiasmo da poter spostare una montagna.
Non avevo idea che in realtà fosse malato.
Non avevo idea che il cuore gli esplodesse nel petto ogni volta che lo sforzava troppo.
Non avevo idea che fosse destinato a morire prima di diventare adulto.
Non me ne aveva mai parlato, sicuramente per non farmi preoccupare, sapevo bene com’era fatto: non diceva mai nulla che potesse creare preoccupazioni agli altri, si caricava sempre tutto sulle proprie spalle. Ciò nonostante, nonostante sapessi com’era fatto, ci sono stati momenti in cui l’ho odiato per avermi taciuto la sua malattia, momenti durante i quali lo avrei riempito di pugni fino a rendergli la faccia irriconoscibile, se me lo fossi trovato davanti. Momenti nei quali avevo pensato che tutti quegli anni passati assieme erano stati solo una bugia, perché non si tace una cosa del genere al proprio migliore amico, se lo si considera tale.
Crescendo, divenni sempre più certo che ad averlo fatto restare in silenzio era stata la paura. Paura di venir guardato con occhi diversi, che non lo avrei più guardato come chi consideri al proprio pari, ma con la pietà dei più sfortunati. E mi odiai. Avrei voluto prendere me stesso a botte fino a rendermi irriconoscibile, perché aveva ragione. Aveva schifosamente ragione.
Se lo avessi saputo, non sarei più riuscito a guardarlo con occhi che non fossero di pietà, non lo avrei più trattato come un amico, ma come un malato. E mi odiai ancora di più, perché per colpa mia avevo fatto vivere il mio amico nella paura, nell'impossibilità di essere sincero con una delle persone a cui voleva più bene. Perché lo sapevo, che mi voleva bene. Voleva più bene a me che a se stesso, anche se non me lo ero mai meritato.
“Però…”
Se lo avessi saputo, forse avrei potuto impedire che giocasse quella partita.
Sicuramente avrei evitato di passargli il pallone e incitarlo a correre più veloce che poteva verso la porta, per segnare e vincere la coppa.
Forse avrei potuto evitare che il cuore gli esplodesse nel petto, quel giorno.
Forse avrei potuto evitare di veder morire il mio migliore amico davanti ai miei occhi.
“Se solo tu me ne avessi parlato…” Sospirai stanco, per l’ennesima volta negli ultimi otto anni, passandomi una mano sul volto e sdraiandomi sulla panchina.
A occhi chiusi, credetti di sentirlo. Udii la voce di Paolo che rideva e si divertiva come un matto quando giocava a pallone. Lo sentii sfidarmi a chi faceva più palleggi, a chi faceva il tempo migliore, a chi dribblava più in fretta il maggior numero di avversari.
“Sempre raggiante e competitivo, Paolo…”
Il suono del cellulare provenire dalla tasca mi fece uscire dalla bolla di ricordi in cui mi ero rinchiuso, facendomi tornare al presente. Scorsi il dito sullo schermo e lessi il messaggio, mentre un sorriso mi si era già formato inaspettatamente al solo vedere il nome del mittente.












Per chi non riuscisse a caricare le foto, la chat tra Arkin e Cam è la seguente:
Acquisti finiti, trottolino amoroso?
Sul serio? Dopo 15 anni che non ci sentiamo, è questa la prima cosa che mi vieni a chiedere? Se ho finito gli acquisti? Con tanto di presa per il culo?
Dovevo chiederti se per caso avevi cambiato le tendine della tua cameretta?
Lo sai cosa?
Tu sei veramente…
Gaaaaaaahhh!!!
Ma perché ci provo…?
Non saprei, sei sempre stato tu quello strano tra noi
E qui ci sarebbe così taaaaaaanto da poter ribattere…
Se non mi sbaglio, sei stata tu quella che è andata ad abbracciare con la faccia il vetro della porta dell’asilo. Perché era “troppo pulito per essere visto”...
Non te ne dimenticherai mai…?
Ti avevo avvertita, a suo tempo.
…
Eddai Cam, non i tre punti!
Sono sadici!
…
OKAY
Mi dispiace!
Colpa mia! Hai ragione te!
Contenta?
Yup, decisamente~
Ho sempre affermato che sei un piccolo diavolo travestito da umano…
...Come?
N U L L A
-.-’
O:)
Come ti pare…
Ma… Davvero ti ricordi di queste cose…?
Io ricordo tutto, principessa.
Tutto…?
Yes.
Ricordo anche cos’è successo quando abbiamo voluto volare.
Okay, quello…
Ho ancora la cicatrice.
Mi sono già scusata per quello!!!
Mi hai quasi ammazzato!
Hey.
E non è vero, non ti sei mai scusata.
Avevamo 4 anni.
Ed eravamo TUTTI d’accordo sul lanciarci. Non ti ho spinto o altro, tu sei saltato perché lo hai voluto fare.
Avevi detto che era sicuro.
E lo era!
Io non mi sono fatta nulla, d’altronde
Non cambierai davvero mai… È davvero così mortificante per te dire semplicemente “mi dispiace, Arkin”?
Mi dispiace, Arkin…
GRAZIE!
...che tu non sia in grado di saltare da un albero senza quasi ammazzarti!
Lo sai cosa?
Ho sempre saputo che eri un piccolo diavolo.
PER QUESTO TI HO NASCOSTO LA PENNA DI MINNIE!
D:
Allora sei STATO TU!
NON HO COCCOLATO IL GATTO PER UNA SETTIMANA PERCHÉ MI DICESTI CHE ERA STATA COLPA SUA!!!
Ho mentito u.u
Esattamente come tu hai mentito dicendomi che era stato il mio cane a rubarmi la pizza!
Non ricordo niente del genere…
21 marzo 2001. È stata la prima volta che abbiamo cucinato la pizza insieme.
La tua era disgustosa, la mia spettacolare.
Oh, sì!
Mi ricordo ora!
La pizza clay!
Yup
Non riesco ancora a credere che le abbiamo realmente messe in forno...
Già…
Ricordo tua sorella correre in cucina sbraitando “da dove diamine viene questo fumo nero?!”
In effetti, quella è stata la parte migliore
Ahahah E poi sarei io il piccolo diavolo?
Già, ma il mio personale~
Comunque
Che ne dici di vederci uno di questi giorni?
Ti va’? Puoi?
Certo!
Dimmi solo quando e dove!
Alla statua del paese, quella del soldato che getta la granata nella valle.
Domani a mezzogiorno, che ne dici?
Beh… In realtà oggi ma… Hai capito
Perfetto!
Pranziamo insieme?
Certamente! Ci facciamo un bel picnic, cucino io
Tu sai cucinare?!
E non la pizza clay? lol
Sono pieno di sorprese, stellina
Lo sei davvero
Allora? È deciso, ci stai?
Sissignore~
Mezzogiorno del fuso orario italiano… Non te lo dimenticare, promettimelo!
Non voglio fare la figura dell’idiota nel centro della piazza che aspetta un fantasma.
Non ti fidi di me?
Mi fido di te…
È dei tuoi cromosomi femminili, che non mi fido.
Già… Dannazione, le ragazze, vero? Come possono riuscire a fare sempre tardi?!
Hai finito di prendermi per il culo?
Ti voglio bene anch’io, bambinone <3
Non preoccuparti, non farai la figura dell’idiota. Ci vediamo a mezzogiorno, promesso!
Devo finire di studiare e poi me ne filo a letto, notte Arkin! A domani!
Sogni d’oro, stjerne
Sogni d’oro, skytsengel
Se non avete mai provato a cuocere la pasta della clay, tutti sono bravi con il pongo e il das, ma ci vuole d'avere le mani di un artista con la pasta clay, andati ad abbracciare una vetrata che non avevate visto a causa della maschera di Carnevale coi buchi per gli occhi fatti male o non siete mai saltati da una magnolia con un lenzuolo a mo' di paracadute per poter volare come Goku, però le ginocchiere e le gomitiere a protezione c'erano, la sicurezza prima di tutto, mica scemi, avete avuto un'infanzia orribile. Non sono io a dirlo, è scienza.
Un tempo ero solita pubblicare di martedì e giovedì mi pare... L'ultima abitudine che ricordo, quantomeno, è questa. Quindi visto che oggi è martedì e ho solo da aspettare l'ora di andare a letto, mi son detta "perché no?"
Anticipo: il giovedì no, perché è un macello. Però venerdì sì, quindi che s'ha a fare una prova per il martedì e il venerdì? Che guarda caso sono proprio Marte e Venere, i pianeti di uomo e donna... Cavolo, manco a farlo a posta. Giuro che è una cosa venutami in mente ora mentre sto scrivendo le note, non era assolutamente premeditata.
Ah, volevo aggiungere solo un'ultima cosa prima di lasciarvi, riguardo alla storia. Per quanto riguarda la malattia di Paolo... non è propriamente come pensa Arkin, ma si scoprirà più avanti, il che spiegherà forse un po' meglio anche perché i genitori del ragazzo non gli danno colpa di niente. Anche perché davvero non ha colpa di niente, a mio parere, però sono cose delicate di cui parlare, ed è per questo c. Quindi niente, volevo solo chiarire questo punto, ecco.
Quindi, bon, nulla... A venerdì!
Sì lo so che avevo detto che ci si vedeva sabato, ma 'sta storia è lunghetta per i miei standard, una pubblicazione a settimana poi non mi finisce più... E poi chi mi conosce lo sa già che di secondo nome io faccio "coerenza", per chi invece non mi conosceva ancora... deh bambini, l'autrice sono io, quindi, come si suol dire dalle mie parti, vu v'attaccate.
Con sincero affetto,

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 3
*** Pagina 2 ***
Pagina 2.
Se non ci mette troppo,
l'aspetterò una vita.
- Oscar Wilde
Stavo già armeggiando in cucina, quando le labbra di Gemma mi sfiorarono la pelle della guancia per darmi il buongiorno e far poi subito dopo apparire sul suo volto un'espressione infastidita. «Arkin... Dannazione, fatti la barba la mattina, sei peggio di un porcospino...»
Mi voltai verso di lei con un sopracciglio alzato, mentre prendeva il necessario per preparare la colazione a sé e i suoi figli. Alzai le mani con ancora la padella in una e il cucchiaio di legno nell'altra, chiedendo con fare ovvio: «Ti sembra che sia pronto per uscire di casa?»
Gemma si voltò e mi squadrò per qualche secondo, per poi alzare un sopracciglio e rispondere alla mia domanda con un altro quesito: «Da quando cucini di prima mattina?»
Non mi diede il tempo di rispondere, che gli occhi le iniziarono pericolosamente a brillare e mi tirò le guance, aggiungendo con la voce che usava quando avevo 6 anni e portavo i primi bei voti a casa: «Ommioddio, il mio fratellino sta uscendo con qualcuna! Chi è la gentil donzella? Allora, allora?»
Stavo per mandarla beneamente in quel posto, quando mio nipote mi venne in aiuto e iniziò a piangere, richiamando le attenzioni di mia sorella, facendola allontanare dalla cucina e tirare a me un sospiro di sollievo, mentre poggiavo nuovamente sul fuoco la padella dove stavano cuocendo i funghi.
12h27
Alzai il braccio sinistro e lo scossi per fare in modo che la manica scendesse da sola, liberandomi il polso e quindi l’orologio, del quale guardai le lancette con le labbra serrate: era in ritardo. E, come se non fosse abbastanza il fatto che la stessi ancora aspettando, avevo già ricevuto un paio di occhiate strane da gente che non conoscevo, mentre altri, che invece conoscevo anche sin troppo bene, si erano avvicinati e mi avevano chiesto sogghignando cosa stessi facendo, come un imbecille, con un cestino da picnic ai piedi della statua del soldato con la granata in mano in una giornata grigia come quella.
“D’accordo. Aspetto fino a meno venticinque, poi me ne vado.” Mi ripetei per l’ennesima volta, mentre mi maledicevo per essermi scordato di mettere il telefono sotto carica quella notte e non avere, quindi, nulla con cui ingannare il tempo e non pensare a quanto sembrassi cretino.
O anche solo per chiamare Camilla e chiederle dove si fosse cacciata, certo.
12h35
Guardai nuovamente l’orologio, ma non ebbi il coraggio di andarmene: mi fidavo di lei ed ero certo sarebbe arrivata. Probabilmente aveva solo avuto un piccolo contrattempo…
12h43
Okay… Un bel contrattempo. Ma mi aveva detto che sarebbe arrivata, volevo crederle e aspettarla.
Sapevo sarebbe arrivata.
Doveva arrivare, anche perché i vecchini del paese seduti al bar di fronte alla piazza stavano iniziando a fare scommesse sul come e perché mi trovassi lì, attendendo di vedere quanto sarei restato prima di andarmene e, soprattutto, se lo avrei fatto da solo o con qualcuno.
Accidenti, come mi vergognavo... E dannavo, al tempo stesso: ma anche io, non potevo scegliere un punto di ritrovo più appartato anziché il centro del paese, maremma cinghiala?
12h56
Altri quattro minuti. Al tocco me ne sarei andato, un’ora di ritardo era inaccettabile. E non mi aveva nemmeno chiamato per avvertirmi!
Okay, forse lo aveva fatto e io non avevo visto nulla perché il mio telefono era morto quella notte… Ma faceva lo stesso.
13h03
Sospirai rassegnato, mi alzai dal piedistallo della statua e mi diressi verso la macchina, cercando di mantenere un minimo di contegno e apparire come se mi trovassi lì per puro caso.
Attraversai la strada e feci per aprire la portiera quando mi sentii chiamare a gran voce dal bar: «Oi’, bimbo!» Il tavolo di vecchini che avevo visto e udito scommettere sul mio imminente futuro, mi invitò con secchi cenni delle mani ad avvicinarmi a loro. Ubbidii, mesto. Tanto, ormai che avevo da vergognarmi ulteriormente?
«Tu vedrai ch’andrà meglio la prossima vorta, ir mare gli è pieno di pesci e uno co’ gli occhi azzurri ‘ome i tua, un ci mette morto a tira’ su quarcosa. (Vedrai che andrà meglio la prossima volta, il mare è pieno di pesci e uno con gli occhi azzurri come i tuoi, non ci impiega molto prima di tirare su qualcosa)» Sbarrai gli occhi e arrossii oltre quello che credevo potesse essere il limite umano, riuscendo a sussurrare un lieve e imbarazzante ringraziamento solo dopo lunghi secondi.
«Vieni, piglia quarcosa da be’ con noi. T’offriamo ‘na coa ‘ola. (Vieni, prendi qualcosa da bere con noi. Ti offriamo una coca cola.)» Disse un altro, alzandosi e andando al banco per ordinarmi la bibita prima che potessi rispondere. Mi scappò un sorriso, presi una sedia da un tavolo vuoto vicino e mi misi con loro a giocare a carte. Tanto sapevo che sarebbe stato completamente inutile provare a eclissare l’invito: era come dire a una nonna che non si ha più fame; provateci e, se riuscite, fatemi sapere come avete fatto.
Passai così una mezz'oretta buona assieme ai miei nuovi amici, raccontando loro perché fossi lì e perdendo ogni singola partita di briscola, burraco e scala quaranta, mentre sorseggiavo la bevanda fresca direttamente dalla bottiglietta di vetro. Perché la CocaCola dalla bottiglietta di vetro piccola è la più buona in assoluto. Finché Bruno non mi batté sulla spalla e mi indicò la statua della piazza, alla quale, seduto dov’ero, davo le spalle. «Arkine, ‘uarda un poinino dietro de te. Gli è mi’a ‘uella, la bimba ch’aspettavi? (Arkin, guarda un po’ dietro di te. È mica quella, la ragazza che aspettavi?)»
Mi voltai, rimanendo a osservare per qualche secondo l’immagine di Camilla che si mordeva nervosa il labbro inferiore e si guardava con gli occhi preoccupati intorno, all’evidente ricerca di qualcosa o qualcuno, il telefono all'orecchio. Sapevo benissimo di essere quel qualcuno e la cosa mi fece venire in mente un’ottima, sadica, idea. Mi voltai verso i cinque anziani uomini che avevo vicino con fare cospiratorio, sussurrando: «Sì, è lei...»
«E ìcche tu fai ancora seduto ‘ui, allora? Vai no! (E che stai facendo ancora seduto qui, allora? Vai, no?)» Mi ordinò bonariamente TicTac, con la cadenza del suo paesino d’origine, vicino Firenze. Chissà qual era il suo vero nome, non l’ho mai scoperto: tutti lo chiamavano così; era dovuto al fatto che, da quando aveva smesso di fumare più di trent'anni prima ed era arrivato nel nostro paesino, aveva sempre un pacchetto di tic-tac bianche nel taschino della camicia.
Stavo per rispondere, ma Attilio mi precedette, chiedendo: «Oh, bimbi… Ma ‘uella lì, ‘un gl'è la nipote della Irda? (Ma quella là, non è la nipote di Ilda?)»
«Ma lo sai che ‘ittu c’hai ragione? Gli è proprio la su’ nipote, gl'è bellina come la su’ nonna da giovane… Ma ‘un s’era trasferita in città da piccina ‘oi su’ genitori? (Ma lo sai che hai ragione? È davvero sua nipote, è bella come sua nonna da giovane… Ma non si era trasferita in città da piccola con i suoi genitori?)» Rispose Baby, un altro di cui non ho mai saputo il vero nome, per avere subito risposta da Marco: «Ma no… La mi’ moglie mi disse che i sua han divorziato anni fa e lei gl’e tornata a sta’ ‘ui con la mamma. (Ma no… Mia moglie mi disse che i suoi hanno divorziato anni fa e lei è tornata a stare qui con la madre.)» Calò un burraco pulito con un sorriso e TicTac imprecò con un “tu ma’ cinghiala” a mezza voce.
«Bimbi!» Li richiamai, facendoli tornare a puntare i loro sguardi su di me: non potevo permettere si perdessero proprio mentre esponevo loro il mio piano. «Ascoltatemi, voglio farla patire un po’, come ho fatto io aspettandola per un’ora… Adesso io resto qui con voi e quando lei se ne starà per andare, voi me lo dite e allora io le vado incotr…»
«Bimbo, e a me mi sa che ‘ittu dovresti sta’ zitt… (Ragazzo, mi sa che dovresti stare zitt…)» M’interruppe Franco, ma non lo lasciai finire e lo ripresi subito: «Non distrarti, segui il mio discorso. Dicevo: quando lei se ne va, voi mi fate un cenno e io la raggiungo al volo. Okay?»
«Cos’è che vorresti fare, te?»
Strinsi gli occhi e mi morsi la lingua, restando immobilizzato per qualche secondo nell’udire quella voce, prima di voltarmi lentamente sotto le mezze risate dei cinque uomini e trovarmi di fronte Camilla, con le braccia incrociate sotto il seno e lo stesso sguardo cupo di quando da bambini scopriva un mio scherzo di pessimo gusto, preparandosi a farmi la predica del secolo.
«Ehilà… Ciao Cam…» Sussurrai leggermente spaventato, salutando con un timido cenno della mano. Lei strinse gli occhi, mi colpì il braccio con la borsa, dentro la quale non capirò mai cosa tiene perché colpisce con la forza di un macigno procurando ematomi non poco dolorosi, dopodiché si allontanò indignata. Dopo essermi portato la mano a stringere la zona lesa e aver smorzato in gola qualche imprecazione, mi detti una mossa ad alzarmi e la fermai a pochi passi dal bar, prendendola per un polso, con ancora il volto distorto in una smorfia di dolore dovuto alla botta. «Ehi! Cam aspetta!»
«Che c’è?» Sbottò lei, guardandomi appena con gli occhi lucidi accigliati. Conoscevo quell’espressione, gliela avevo già vista da bambina: era un mix tra rabbia, delusione e tristezza. Una botta al cuore per chiunque le volesse bene, praticamente.
Ingoiai tutto il mio orgoglio, per poi mostrarle il mio sorriso più dolce e le dissi: «Non andare via, siamo ancora in tempo per il nostro picnic.»
«Perché mi volevi far aspettare chissà quanto?» Chiese lei con voce appena tremante. Altra botta al cuore, per la cronaca.
«Perché sono un idiota…» Le dissi scuotendo leggermente la testa, continuando a sorriderle.
«Sì… lo sei…» Sussurrò lei, guardandomi storto, mentre le lacrime venivano ricacciate lontano dai suoi occhi. Si scrutò poi attorno, il volto tornato disteso e raggiante come al solito, chiedendo serenamente: «Allora? Il nostro picnic?»
«È in macchina, vado a prenderlo e ci mettiamo a mangiare.» Le dissi, facendo un cenno di saluto ai miei nuovi amici del bar, i quali mi dettero l’in bocca al lupo con frasi che non ho il coraggio di ricordare, ma che fecero sorridere divertita Camilla, per poi andare a prendere il cestino e dirigermi con lei al giardino accanto alla piazza. Stendemmo la tovaglia, prendemmo dal cestino le cibarie, il necessario per mangiare e ci godemmo il nostro picnic, chiacchierando di tutto e nulla, finché non notai una cosa, al rannuvolarsi del cielo: «Mi erano mancati i tuoi occhi multicolor.»
«I miei che?» Chiese lei, strabuzzando lo sguardo e posando il boccone di pasta che si stava portando alle labbra.
«I tuoi occhi multicolor.» Sorrisi io, indicando con l’indice il cielo senza staccare lo sguardo dal suo. «Non ricordavo quasi più che quando è nuvoloso diventano grigi. D’altra parte, non sono mai riuscito a ricordarli davvero. Troppi colori.»
«Ah ah…» Annuì ironicamente lei, forse credeva che scherzassi, per poi sentenziare: «I tuoi invece sono sempre azzurri. Due fottutissimi zaffiri che prendono per il culo chiunque li guardi con una semplicità e una naturalezza disarmante.»
Mi scappò un sorriso, mentre abbassavo lo sguardo e lo rialzavo l’istante dopo, riposizionandolo in quello suo, attualmente cinereo: «Noto con piacere che anche il tuo modo di fare i complimenti non è cambiato.»
Camilla posò il piatto ormai quasi vuoto a terra, alzando un sopracciglio e storcendo la bocca ironica, mentre elencava sulle dita affusolate: «Okay… Allora, facciamo il punto della situazione fino ad adesso: i nostri occhi non sono cambiati, i miei atteggiamenti neppure, la tua faccia da schiaffi neanche…» Si portò le mani a pugno sui fianchi, con finto fare disarmante, concludendo: «Non ci vediamo da 15 anni, possibile che siamo rimasti identici?»
«Beh… Io ero un gran figo allora e lo sono ancora di più adesso…» Risposi con un sorriso strafottente, stirandomi all’indietro e appoggiando poi i palmi delle mani al terreno, in modo da non perdere l’equilibrio.
Lei ribatté, altrettanto strafottente: «Chiudi la coda, pavone… Se non vuoi che ti strappino le penne e ne facciano un trofeo.»
Stavo per ribattere e continuare quel divertente giochino, quando una goccia di pioggia mi colpì in piena fronte. «Merda, inizia a piov…»
«Linguaggio.» Mi interruppe lei, con fare da maestrina saccente, mentre si portava con tranquillità un nuovo boccone alle labbra, fregato dal mio piatto.
«Sul serio?» Chiesi alzando un sopracciglio incredulo, sinceramente sorpreso da quell’uscita.
«Sì.» Ribatté subito Camilla, per poi guardarmi e aggiungere con finto fare offeso: «Sei pur sempre in presenza di una mademoiselle, moderati.»
Un piccolo sorriso furbo mi prese autonomamente il possesso del viso, mentre mi tiravo in avanti verso di lei e sfoderavo la mia arma migliore: «Les mes plus sincères excuses, mademoiselle. Comment puis-je faire pardonnes? (Le mie più sincere scuse, signorina. Come posso farmi perdonare?)»
Me l’aveva servita su di un piatto d’argento.
Strabuzzò gli occhi, sinceramente sorpresa, per poi fingere malamente un tono indifferente e dire: «Uh uh, il signorino ha imparato il francese… E chi se l’aspettava, questa? Quale sarebbe dunque la prossima mossa, Sir?»
«Mmmh… Fammi pensare…» Alzai gli occhi al cielo, feci una pausa d’effetto, dopodiché dissi, secco: «Portarti a letto, decisamente.»
«Usando il francese? Sei sleale, bimbo. E oltretutto per nulla fine, non lo sai che bisogna aspettare il terzo appuntamento per il sesso?» Sogghignò lei. Io le risposi con un sorriso, iniziando a mettere in fretta dentro le cose, mentre un’altra goccia mi accarezzava la pelle e mi scorreva fastidiosa lungo il collo. «Dai, andiamo. Ci ripariamo a casa mia, non voglio prendermi un raffreddore.» Lei acconsentì con un lieve sorriso.
Aprii la portiera della macchina, per entrare a corsa dato che ormai aveva davvero iniziato a piovere e, prima di partire, ormai al sicuro, precisai: «E per la cronaca, io ho aspettato 15 anni. Altro che terzo appuntamento…» La vidi con la coda dell’occhio ridere di gusto, mentre inserivo le chiavi.
«Allora, me lo dici o è un segreto di stato a cosa è dovuto il ritardo di oggi?» Mi chiese Arkin, mettendo la retromarcia. Il suo tono non era per nulla arrabbiato, solo curioso. Forse fu proprio per quello che mi sentii ancor più a disagio e dispiaciuta.
«Segreto di stato.» Cercai di sviare, imbarazzata, mettendomi la cintura.
Mi lanciò una breve occhiata, ma più che sufficiente, mentre tornava a guardare avanti e inseriva la prima. Dio, quanto odiavo quegli occhi. Feci un respiro profondo e parlai: «Ieri sera ho finito di sistemare gli appunti più tardi del previsto e stamani sono andata a diritto.» Lo guardai con un occhio chiuso, già pronta per la ramanzina che sarebbe ben presto arrivata, mentre a denti stretti sussurravo un imbarazzato: «Scusa…»
«Dai, scegli qualcosa. Abbiamo tempo di ascoltare due canzoni prima di arrivare a casa.» Mi disse, porgendomi il suo mp3. Rimasi un attimo stranita del fatto che non avesse detto nulla, ma il sorriso semplice che aveva sulle labbra mi rilassò istantaneamente.
Presi il lettore musicale e iniziai a scorrere la coda del catalogo, non potendo fare a meno di aggrottare le sopracciglia man mano che procedevo. «Adelen, Alexandra Joner, Gabrielle, Marcus & Martinus, Staysman & Lazz, Ylvis.... Ma chi è ‘sta gente?»
«Come sarebbe a dire? Non ne conosci nemmeno uno?»
«Ah, perché scusa, dovrei anche? L’unico nome italiano è Veronica di Maggio, ma il titolo della canzone è in vichingo.»
«Okay, per gli scandinavi te la buco che non li conosci perché okay, può starci. Ma com’è possibile che non conosci nemmeno Billy Talent, Nightcore, Immortal… Ma dove vivi?»
Con un’ottava maggiore del normale, esclamai: «Scusami? Vuoi veramente metterti a discutere di musica con me?»
«Sentiamo allora, te chi hai nella playlist del telefono?»
«Bon Jovi, James Blunt, Toto, Ed Sheeran, Venditti, Battisti, De André, Dalla…»
«Dalla?»
«Sì. Dalla, Lucio Dalla. Cos’hai contro di lui?»
«No no, nulla… Figuriamoci. I gusti son gusti… E i tuoi sono, evidentemente, antichi.»
Pausa drammatica. Dopodiché lo guardai e, in un sussurro grave, chiesi: «Come scusa?»
«Ascolti gente… di altri tempi, ecco.»
«Beh, scusa tanto se non sono il tipo da tunz tunz parapara tunz tunz.»
«Già… Sei troppo sofisticata.» Il sorrisetto strafottente sul volto, mentre svoltava e usciva dal paese.
«Sentimi, bellino. Vedi di prendere poco per il culo, visto che, tanto per dirne una, “Caro amico ti scrivo” è una delle più belle canzoni mai venute al mondo.»
Lui, per tutta risposta, fece un sospiro scoraggiato. «Una ventenne con i gusti che manco mio nonno… S’anda’ bene…»
Se non fosse che stava guidando, gli avrei dato un nocchino. «Te lo ridi’o: piglia po’o per il culo, te. E ora impara da della vera musica.» Tirai fuori il mio cellulare e lo collegai all'entrata usb della macchina. «Lezione numero 1: 4 marzo 1943, Dalla e De Gregori.»
«Oh signore…» Lo sentii mugolare, ma non ribatté ulteriormente.
Arrivammo all’abitazione di Arkin nel giro di pochi minuti, appena l’ultimo accordo della canzone smise di suonare dallo stereo. Lui non lo ammetterà mai, ma io fui più che soddisfatta quando vidi i lucciconi ai suoi occhi, a canzone finita, mentre apriva la portiera.
Aveva smesso di piovere e non facemmo in tempo a chiudere il cancello del giardino alle nostre spalle, che un meraviglioso esemplare di husky saltò addosso al padrone di casa e iniziò a lavargli la faccia, scodinzolando entusiasto. Non potei trattenere una risata, dovuta quasi più alla reazione di tentata protesta del mio amico che alla scena in sé.
«Okay, adesso basta…» Cercò di fare il serio Arkin, venendo bonariamente ignorato dall’animale. Un grugnito di insoddisfazione e, mentre la lingua rosea continuava a percorrergli la faccia, sbraitò: «Freya! Sitter! (Freya! Seduta!)»
Il cane drizzò le orecchie per un breve istante, poi si allontanò di un paio di passi, in modo da permettere ad Arkin di muoversi liberamente, mettendosi diligentemente seduto. Rimase immobile come una statua, mentre il mio amico si alzava in piedi e si puliva la faccia con espressione infastidita, utilizzando la stoffa della maglia. «Dannazione… Alla faccia del cane da guardia… Faresti scappare i malintenzionati a forza di leccate.» Stavo per rispondergli a tono, dicendo che non si doveva permettere di parlare così a un animale che aveva semplicemente fatto le feste al proprio padrone, ma cambiai immediatamente espressione non appena notai il suo sorriso disteso e lo sguardo amorevole, mentre si chinava per grattare l’husky dietro le orecchie, facendola scodinzolare felice.
«God min baby… (Brava la mia bimba…)» Lo sentii sussurrare. Anche se non avevo idea di cosa avesse appena detto, dall’assonanza con l’inglese e dal suo tono di voce estremamente dolce, non poteva che essere un complimento.
Mi avvicinai di qualche passo, chinandomi sulle ginocchia per essere alla loro altezza e con una mano a sorreggermi il volto. Rivolgendomi ad Arkin, chiesi curiosa: «Come mai gli parli in norvegese?»
Lui mi guardò per un attimo, sinceramente confuso. Distolse poi lo sguardo, tornando a puntarlo su quello dell’animale, rispondendo in un bisbiglio: «Non mi ero reso conto di star parlando in norvegese…» Alzai un sopracciglio, ancora più confusa. Come si fa a non rendersi conto in che lingua si sta parlando? Soprattutto quando non è la lingua maggiormente utilizzata nel corso della vita quotidiana. Stavo per domandarglielo, quando mi precedette e fece le presentazioni. «Cam, ti presento Freya. È il nostro cane da guardia, ma… Beh, le manca un po’ di comprendere ancora la parte del “vedi lo sconosciuto e, quantomeno, ringhia”.» Disse con un sorriso tirato, concedendo una carezza all’husky sul folto pelo argenteo del collare. Aggiunse poi, con tono più fermo, facendo un cenno con la testa verso di me: «Freya, greets. (Freya, saluta.)» Fu così che l’husky mi si avvicinò e mi offrì la zampa, accompagnata da un abbaiare dal tono socievole. Fui tanto colpita che rimasi paralizzata per qualche istante, venendo poi riscossa dalla voce divertita di Arkin: «Rimarrà così finché non le stringi la zampa o non le dico di lasciar perdere.»
«Eh? Ah… certo…» Guardai il cane negli occhi, dello stesso colore del ghiaccio, dopodiché sorrisi e le presi dolcemente la zampa: «Piacere di conoscerti Freya, io sono Camilla.» L’husky abbagliò un’altra volta, con il medesimo tono gioviale di prima, poi mi leccò brevemente la mano con la quale le avevo stretto la zampa e tornò al fianco del suo padrone. Lo guardò con occhi adoranti, scodinzolando appena, mentre lui le concedeva delle brevi carezze sul cranio.
«Stavolta però ti sei accorto di parlare norvegese?» Chiesi, tornando in piedi e guardandolo perplessa. Lui ricambiò il mio sguardo, tornando anche lui in piedi e dicendo con un semplice sorriso: «Sì, ma i comandi glieli ho insegnati in norvegese quando era cucciola. Se parlo in italiano, non li comprende.»
«E perché lo hai fatto?»
«Per due buoni motivi.» Spiegò, facendomi al contempo il cenno di seguirlo verso l’entrata di casa. «Il primo è che in norvegese suonano terribilmente più fighi…» Lo disse con un’espressione da spaccone sul volto, che non ci misi troppo a far sparire, dandogli un picchio sulla fronte e mormorando uno sbuffato: «Ma piantala, faccia a schiaffi…» Lui rispose con un sorriso divertito, per poi tornare serio e dire: «E poi, il secondo è che in questo modo soltanto noi di casa possiamo darle ordini. Così non rischiamo che le capiti nulla di brutto.» Notai una punta di tristezza nella sua voce, ma non feci in tempo a chiedere che la porta di fronte a noi si spalancò, mostrando una bimba che sembrava avere all’incirca cinque anni.
Dopo un breve attimo di sorpresa, gli occhi chiari della piccola brillarono vivaci e saltò in braccio a Arkin, gridando: «Zio!»
Appena la bimba si accorse di me, portò le labbra all'orecchio di Arkin per sussurrargli qualcosa. Quando si distanziò, mi accorsi del rossore che aveva preso possesso delle guance del mio amico che, con tono nervoso, disse: «Ehm… No… Non… Senti Francesca, dov’è la mamma? Devo evidentemente fare una bella chiacchieratina con lei…»
«Mamma sta finendo di dare da mangiare a Gabri. Così poi possiamo giocare con Freya.»
«Capisco… Comunque, questa ragazza è un’amica dello zio, si chiama Camilla. Al massimo chiamala “tata”, okay? Ma chiedile il permesso prima.»
«Okay.» Rispose senza alcun remore la piccola, che mi ritrovai nel giro di pochi secondi davanti agli occhi, a porgermi la manina senza alcun timore. «Ciao, io sono Francesca.» Posai lo sguardo sul volto gioviale di lei, vedendo con la coda dell’occhio l’espressione di Arkin: non gliela avevo mai vista, era un misto tra dolcezza, orgoglio, scuse e chissà cos’altro. Ciò nonostante, le labbra distese e gli zaffiri brillanti mi fecero tornare abbastanza in me e, seppur con voce ancora imbarazzata, strinsi la mano alla piccola che avevo di fronte. «Piacere mio, Francesca.»
«Posso chiamarti tata?»
«Ehm… Sì, certo.»
«Bene.» Francesca sorrise entusiasta, stringendo la mia mano e tirandomi verso Arkin, per poi prendere anche la sua e avviarsi verso Freya, che già era scodinzolante sul prato con la palla da tennis in bocca. «Andiamo a giocare!»
«Ferma lì, piccola peste.» Disse Arkin con un sorriso, arrestandosi e facendo puntare gli occhi della nipote su di lui. Alzò un sopracciglio e l’angolo opposto delle labbra, dicendo: «Qual è la regola per giocare con Freya?»
La piccola sbuffò, poi rispose, guardando scocciata dall’altra parte: «Solo in presenza di mamma, babbo o nonna.»
«Appunto, quindi adesso torniamo dentro e aspettiamo la mamma. Forza.»
«Ma…» Francesca non fece in tempo a protestare che Arkin l’aveva presa in braccio e la stava portando dentro casa, sogghignando vittorioso: «Niente ma, microbo.» Diresse poi uno sguardo verso di me: «Dai vieni, forse stavolta ce la facciamo a entrare in casa senza che qualcuno mi salti addosso.» Risi, andandogli dietro e varcando la soglia dell’abitazione con ancora il sorriso sulle labbra.
Siccome sono una brava persona che ci tiene a rompere le balle con note didattiche alla cultura generale dei suoi lettori, vi lascio qui il link della canzone di Dalla:
https://www.youtube.com/watch?v=H0hwEG721nY&ab_channel=LucioDalla-Topic
Questa invece è la versione di Dalla e De Gregori, testo "non censurato" live:
https://www.youtube.com/watch?v=Eu92CzWMVpY
E giusto perché vi voglio tanto, ma proprio tanto bene, vi lascio pure "Bocca di Rosa", di De André, perché... vabbe' dai, perché se Dalla scriveva poesie anziché semplici canzoni, De André scriveva storie vere e proprie:
https://www.youtube.com/watch?v=3Hk4QDafAGo&ab_channel=FabrizioDeAndr%C3%A9-Topic
Se non le ascoltate, non vi voglio al prossimo capitolo, chiaro?
|
Ritorna all'indice
Capitolo 4
*** Pagina 3 ***
Pagina 3.
(And all I can taste is this moment
And all I can breathe is your life
'Cause sooner or later it's over
I just don't want to miss you tonight)
E tutto quel che posso assaporare è questo momento
E tutto quel che posso respirare è la tua vita
Perché presto o tardi finirà
Non voglio perderti stanotte
- Iris, Go Go Dolls
Appena fui in quella casa, una marea di ricordi mi invase la mente. Avevo passato parte dell’infanzia lì dentro, con i due migliori amici che avessi mai potuto desiderare. Avevo cercato per una vita un’amicizia tanto profonda come quella che avevo con Arkin e Paolo, senza riuscire a instaurare un rapporto che la ricordasse vagamente con nessuno. Finché non avevo conosciuto Aurora.
«Stai bene?»
La voce di Francesca mi fece riprendere dal senso di nostalgia infinita che mi stava per trasportare via, i suoi occhi grigi a osservarmi confusi. Gli zaffiri di Arkin la seguirono subito, facendo dipingere un’espressione preoccupata sul volto del mio amico: «Hai gli occhi lucidi, Cam…»
Chiusi le palpebre, cacciando indietro le lacrime che mi stavano salendo e scostai la testa, sorridendo: «Non è nulla, è solo il sonno mancato di stanotte.»
Arkin mi guardò non del tutto convinto, quando sua nipote gli fece cenno di farla scendere a terra. Nuovamente coi piedi sul pavimento, venne da me, mi prese per mano e mi trascinò verso la sala, decretando con un sorriso: «Vieni tata, andiamo a giocare!»
Un sorriso mi distese le labbra, mentre stringevo la mano della bimba di fronte a me e, prima che Arkin potesse ribattere, le rispondevo: «Subito!»
Con la coda dell’occhio, vidi il sorriso di Arkin divenire morbido come il burro, mentre andava a chiudere la porta d’ingresso, lasciando la povera Freya fuori a giocare da sola con la palla, e raggiungerci nell’altra stanza.
Casa di Arkin non era cambiata quasi in nulla, aveva mantenuto l’arredamento di una volta, quasi interamente di legno che richiamava le spettacolari travi a vista del soffitto. Niente era stato tolto o spostato, c’erano solo le aggiunte di qualche foto e contenitore per i giochi della nipotina e una scrivania con un computer nell’angolo. Mentre Francesca andava a recuperare qualche giocattolo, io mi avvicinai quasi inconsciamente al camino, il vero re della sala. Avevo sempre amato quel camino, ma ancor di più avevo sempre adorato lo spazio al suo fianco, colmo di cuscini, per potercisi accoccolare alla giusta distanza perché nulla potesse prendere fuoco quando le fiamme scoppiettavano nelle fredde serate d’inverno, e abbastanza vicino da poter percepirne tutto il calore. Bere la cioccolata calda in quell’angolino in compagnia di Arkin e Paolo era uno dei ricordi più belli che custodivo.
Venni distratta da dei passi alle mie spalle, di una donna che stava in quel momento scendendo le scale. Prima che una di noi due potesse pronunciare un saluto, Arkin entrò in sala e si diresse da lei. «Tu…» Paratolesi davanti alla base della scalinata, le prese la guancia e gliela tirò, fulminandola con gli occhi e sussurrando a denti stretti: «Che cosa diamine vai a raccontare a mia nipote…» La donna, per tutta risposta, ricambiò il gesto di Arkin, iniziando a prendergli entrambe le guance e iniziando a tirargliele. Gli sussurrò qualcosa, che però non riuscii a capire a causa dell’attuale deformazione delle bocche di entrambi. Vedendoli, mi fece attraversare la mente da un lampo. Schiocchiai le dita, esclamando: «Gemma!»
L’attenzione dei due si posò su di me, non appena pronunciai il nome della sorella maggiore del mio amico. Un’espressione confusa comparì sul volto paffuto di Gemma, ma Arkin mi presentò prima che lei potesse chiedere chi fosse la sconosciuta che conosceva il suo nome.
«Camilla…» Borbottò un attimo, immersa nei propri pensieri, per poi alzare nuovamente lo sguardo verso di me ed esclamare raggiante: «Ah, sì! Mi ricordo di te! Sei quell’adorabile bimba della materna.» Scostò senza tante cerimonie il fratello e venne verso di me, abbracciandomi di slancio. Riuscii a vedere Arkin portarsi una mano alla fronte e scuotere la testa sconsolato, facendomi sorridere. Sua sorella si allontanò quel poco per parlare, tenendo le mani sulle mie spalle e, guardandomi negli occhi, esclamò sorpresa: «Accidenti, come sei cresciuta… Non ti avevo davvero riconosciuta, Camilla! Eppure i tuoi occhi hanno la stessa luce di quando eri piccola… Come stanno a casa? Tutto bene? Che cosa fai, adesso? Studi? Lavori? Sei tornata ad abitare in paese?» Stavo per rispondere, ma Arkin mi precedette: «Ma cos’è questo interrogatorio?» Separò me e Gemma, frapponendosi tra noi, non dandomi la possibilità di rispondere a domande che, per quanto mi riguardava, non trovavo affatto sconvenienti o fuori luogo.
«Lasciala respirare, non credi di esagerare con la tua impicciosaggine? Non ha fatto in tempo a dire nulla, che sei partita con il terzo grado.» Guardai la nuca di Arkin, storcendo le labbra. Feci un sospiro e scostai il mio amico di lato, spingendo sul suo fianco con il mio gomito. «Sei tu che sei una rottura…» Mi rivolsi poi a Gemma e, sotto lo sguardo frustrato di lui, risposi a tutti i suoi precedenti quesiti con un sorriso sincero.
Gemma ricambiò il mio sorriso e iniziammo a chiacchierare come fossimo due vecchie amiche che non si vedevano da tempo, sotto lo sguardo scioccato di Arkin, finché Francesca non andò dalla madre e le disse che doveva andare in bagno. La donna si affrettò quindi ad andare al piano superiore con la bimba, lasciando me e Arkin in sala.
Guardai un attimo il mio amico, il quale rispose prima che potessi chiedere qualunque cosa: «Francesca va in bagno da sola, ma la porta del bagno è vecchia e la maniglia troppo dura per lei e non riesce ad aprirla. È una cosa che va sistemata, ma non c’è ancora stata occasione.»
Annuii brevemente e mi guardai un po’ intorno, improvvisamente sentendomi un poco a disagio. Eravamo entrambi fermi in piedi nella sala, immersi improvvisamente nel silenzio e non capivo perché nessuno dei due dicesse o facesse nulla per toglierci da quella situazione.
Senza volerlo, mi scappò uno sbadiglio, dovuto alla stanchezza per la notte praticamente in bianco appena passata che si era ripresentata di colpo. Arkin mi guardò con un mezzo sorriso: «Se vuoi puoi dormire un po’.»
«No che non posso… Non sono sola e non sono a casa mia.» Ribattei, con gli occhi che stavano però diventando sempre più pesanti. “Dannazione, odio gli abbiocchi…”
«Non essere stupida. Casa mia è casa tua, da sempre.» Mi riprese lui. Capii dal tono di voce che si era davvero offeso per quanto avevo detto e, con nonchalance, mi porse la mano: «Vieni, andiamo a letto.»
Distolsi lo sguardo imbarazzata, sdraiandomi sul divano in quel momento completamente libero, dandogli la schiena. «Dormo qui…» Anche se non potevo vederlo, riuscii comunque a percepire benissimo il suo sopracciglio alzarsi ritmicamente con atteggiamento nervoso, mentre ritirava la mano e la riportava lungo il fianco.
«Solo un paio di minuti… Per far passare il colpo di sonno…» Mugolai, chiudendo le palpebre.
Rilassai il corpo, in attesa di cadere in balia di Morfeo, quando sentii una sensazione fresca e morbida. Aprii gli occhi e mi accorsi che Arkin mi stava coprendo con un soffice lenzuolo. "Si ricorda ancora che adoro la morbidezza di una copertina anche se fa caldo?"
«Grazie…» Sussurrai, voltandomi verso di lui, ancora chinato a terra per sistemare meglio la coperta.
«Di nulla, stjerne.» Rispose, con un sorriso rilassato.
Rimasi a osservarlo rimboccarmi le coperte alla bell’e meglio ancora per un po’, dopodiché aprii le mani davanti al volto, sapendo che lui avrebbe capito, sussurrando appena per richiamare la sua attenzione: «Skystangel…»
Interruppi il lavoro precario di rimboccamento delle coperte in cui ero impegnato, portando lo sguardo su di lei e vedendola con le mani aperte, a poca distanza dal volto. Capii immediatamente cosa voleva.
«Non siamo un po’ grandicelle per questo?» Chiesi retorico, con un sorriso divertito. Per tutta risposta, Camilla gonfiò le guance e ribatté: «Sei noioso!» Quell’espressione mi fece ridere, cosa che dette evidentemente fastidio alla mia amica. «E va bene, non importa! Non ne ho bisogno, era solo per fare un piccolo tuffo indietro nel tempo! Lasciamo perdere!» Mugolò, voltandosi nuovamente verso lo schienale del divano, dandomi così le spalle e chiudendo gli occhi con ancora un’espressione risentita sul volto.
Le labbra mi si distesero da sole in un sorriso, mentre andavo a unire la mia mano a quella di Camilla, sedendomi a terra e prendendo una rivista dal tavolino di fronte a me per ingannare il tempo. «Mi dispiace, ma io non ho affatto sonno. Non posso venire nel mondo dei sogni con te.» Intrecciai le dita con le sue, sentendo il suo respiro leggero sulla pelle. «Ma terrò comunque la tua mano stretta nella mia, in modo da proteggerti.» La percepii sorridere, mentre le ciglia che si chiudevano mi solleticarono per un istante la pelle. «Søte drømmer, min lille stjerne. (Sogni d’oro, mia piccola stella.)» Sussurrai leggero, posando gli occhi sulla rivista che avevo tra le gambe. In principio, avevo l’intenzione di leggere per ingannare il tempo, ma i ricordi mi presero il possesso della mente senza che potessi controllarli.
Quello di tenere la mano a Camilla era una tradizione, o abitudine, non saprei come chiamarla, che risaliva ai tempi dei riposini pomeridiani della materna. Dopo pranzo, quando rientravamo dal cortile, le maestre ci facevano distendere nella stanza del piano superiore della scuola e, chi voleva, poteva dormire per un po’. Io non ero molto propenso all’idea, ma Cam e Paolo iniziavano a barcollare regolarmente una mezz’ora dopo aver pranzato, quindi avevo sempre finito per seguirli nella stanza del pisolino in modo da non restare solo.
Cam si era svegliata ancora una volta, facendo destare anche me. I suoi occhi erano colmi dalle lacrime, il respiro affannato.
La maestra Gianna era venuta a vedere cos'era successo, sedendosi sulla brandina e prendendo la mia amica in braccio, accarezzandole i capelli e sussurrandole nell’orecchio delle parole dolci per cercare di calmare le scosse che le percuotevano il petto.
Quando si era calmata, la maestra le aveva chiesto se preferiva a giocare nel cortile con gli altri o se voleva provare a tornare a dormire. Cam era rimasta in silenzio un po’, per poi scendere dalle gambe dell’adulta e rimettersi sotto la coperta in silenzio. Un’altra carezza sulla guancia ancora rossa e la maestra era tornata alla propria postazione, immersa dai suoi fogli indecifrabili.
«Camilla…» L’avevo chiamata, appena eravamo rimasti gli unici a poterci sentire.
«Arkin… Ti ho svegliato? Scusa…» Aveva detto sottovoce, con tono triste e ancora tremante. Avevo scosso la testa, aggiungendo con un sorriso: «Non preoccuparti.» Camilla si era riparata maggiormente sotto la coperta, nascondendo gli occhi. «Le ho sognate di nuovo… Le seghe tonde… che tagliano le persone…» Aveva rivelato dopo un po’, la voce sempre più bassa.
Riuscivo a sentire i suoi singhiozzi e vedere le sue lacrime anche se il suo volto era completamente coperto. Avevo alzato la testa per vedere cosa stesse facendo la maestra e, dopo essermi accertato che i suoi occhi fossero fissi sui fogli, ero sgattaiolato fuori dalla mia postazione e mi ero intrufolato sotto le coperte della mia amica, sussurrandole appena: «Fammi spazio…»
Ci eravamo così trovati stretti nel piccolo lettino, entrambi sotto la coperta dei Cavalieri dello Zodiaco di Camilla. L’avevo guardata e le avevo chiesto perché continuasse a fare tutti quegli incubi, se fosse successo qualcosa di cui non mi aveva parlato, ma lei aveva scosso la testa. «Non devi preoccuparti, Arkin… Prima o poi andranno via da soli… Devo solo aspettare e quando crescerò tutti questi brutti sogni non mi faranno più paura. Babbo ha detto così…» Lo aveva detto con un tono che non mi era piaciuto per nulla, perché appartenente a qualcuno che si era completamente arreso. E il fatto che fosse un consiglio di suo padre mi faceva arrabbiare ancora di più: Cam adorava il suo babbo, a me invece non era mai piaciuto, né come padre né tanto meno come persona. Troppo "adulto", "sopra gli altri"... trattava tutti come adulti stupidi, ti faceva sentire piccolo e insignificante rispetto a lui.
Avevo scosso la testa e l’avevo guardata dritta negli occhi, dicendole serio: «Non esiste! Non si scappa mai, gli incubi si affrontano faccia a faccia! Vanno affrontati come Goku fa coi cattivi! Se vogliamo diventare forti come Goku, dobbiamo comportarci come lui e combattere come lui!» Un sorriso era apparso sul volto di Camilla, al solo sentir nominare il nostro eroe preferito, il che mi aveva rassicurato. Le avevo stretto le mani nelle mie, continuando con un sorriso di riflesso al suo: «Stai tranquilla, affronteremo i tuoi incubi insieme. Se ci teniamo stretti per mano e ci pensiamo fortissimissimo prima di addormentarci, saremo nello stesso sogno e, dovesse succedere qualcosa, lo combatteremo insieme.»
«Quindi se penso a Goku, potrò sognare lui?» Aveva chiesto lei, gli occhi ricolmi di una nuova speranza.
«Beh… Sì, ma… Non hai bisogno di Goku, ci sono già io con te!»
«Ma tu non sei forte come Goku…»
Ero rimasto spiazzato da quell’affermazione. Avevo abbassato lo sguardo e, dopo averci pensato bene, le avevo risposto: «Lo diventerò…» Camilla mi aveva guardato perplessa, io avevo alzato gli occhi per puntarli nei suoi e affermare, con più sicurezza nella voce: «Diventerò forte come Goku, anzi persino più forte di lui! E così ti proteggerò da tutto e tutti!» Avevo scostato poi lo sguardo, incapace di sostenere la vista di quegli occhi multicolor, aggiungendo: «Sono io il tuo fidanzato, è mio compito farti stare bene… Non di Goku…»
«Grazie.» Aveva sussurrato Camilla, facendomi voltare nuovamente verso di lei. Aveva chiuso gli occhi con un sorriso, aumentando di poco la stretta delle nostre mani e portandosele a poca distanza dalle labbra, come stesse sussurrando una preghiera, aggiungendo flebile: «Grazie skystangel…»
Non avevo potuto fare a meno di sorridere, all’udire l’unica parola che conosceva della lingua di mia madre provenire dalle sue labbra. «Søte drømmer, min lille stjerne. (Sogni d’oro, mia piccola stella.)» Avevo sussurrato, prima di chiudere anch’io gli occhi e addormentarmi.
Da quell’episodio, ogni volta che ci era capitato di dormire insieme, Camilla mi aveva chiesto di tenerle la mano per evitare di fare degli incubi.
Le labbra mi si distesero in un sorriso a quel ricordo, che consideravo dolce, facendomi aumentare inconsciamente la stretta nella mano di Cam. La percepii muoversi alle mie spalle, lasciando la presa per potersi rigirare. Togliendomi dalla testa di ricercare la sua mano a tentoni, mi voltai per guardarla e ritrovarla mediante la vista, rimanendo però incantato dalla sua espressione distesa. I dolci lineamenti del suo volto rilassati le davano l’aria di una fanciulla completamente indifesa.
L’avevo osservata spesso da piccoli mentre dormiva ed ero sempre rimasto affascinato dalla sensazione di calma che trasmetteva quel volto assopito. Mi sorpresi ad accorgermi che, nonostante non avesse più l’aspetto della bambina di un tempo, riusciva comunque a trasmettermi la stessa, identica sensazione di calma di allora.
Un mormorio incomprensibile attirò la mia attenzione, facendola concentrare sulle sue labbra. Non le avevo mai viste così da vicino da quando ci eravamo ritrovati, erano forse la cosa che era cambiata di più del suo volto. Da bambina erano color pesca, avevano una forma piacevole e lineare, appena ti sfioravano sembrava di essere stati accarezzati da un morbido cuscino. Quelle di adulta invece erano di una sfumatura di un dolce roseo, dotate di un appena accennata forma a cuore: il labbro inferiore impercettibilmente più carnoso rispetto a quello superiore, il quale, nella posizione a bocca socchiusa in cui si ritrovava per poter respirare meglio, lasciava vedere la non troppo pronunciata incurvatura centrale. Non potei fare a meno di chiedermi se anche la sensazione che lasciavano quando ti sfioravano, fosse cambiata rispetto a quando eravamo bambini o meno.
Mi persi completamente all'ammirazione di quelle labbra, dimenticandomi di qualsiasi altra cosa.
«Camilla, vuoi qualcosa da bere?»
La voce di mia sorella mi fece tornare al presente di colpo, facendomi rendere conto che mi ero avvicinato decisamente troppo. Scattai in piedi, rivolgendomi verso le scale con l’indice teso poggiato sulla mia bocca, invitandola a fare silenzio. Gemma mi guardò con occhi perplessi, perciò mi diressi verso di lei e sussurrai: «Cam sta dormendo, ha passato la notte in bianco a studiare e ora ha bisogno di riposare. Parla a bassa voce o rischi di svegliarla.»
«Non potevi farla dormire nella stanza degli ospiti, su un letto? Ma sei proprio senza attenzioni.» Mi riprese mia sorella, facendomi portare due dita a massaggiare la tempia per tentare di racimolare tutta la calma che ero in grado di raccogliere: «È crollata sul divano in meno di un minuto, non è colpa mia.»
Mi diressi poi in cucina, dove mi aspettava ancora il compito di lavare tutto ciò che avevamo utilizzato per il breve picnic di quel giorno.
«Ehi, fratellino...» La voce di mia sorella mi fece voltare verso di lei, mentre sistemavo l’ultimo bicchiere nella piattaia. Solo in quel momento notai che era scesa da sola, perciò mi venne spontaneo chiederle dove fossero i bimbi.
«Entrambi nel lettone che dormono come ghiri.» Rispose lei, con un sorriso orgoglioso e colmo d’affetto, venendosi a sedere all’isola. «Fra è voluta andare a controllare il fratellino e alla fine si è addormentata anche lei.»
«E tu ne approfitti per il tuo tè delle cinque?» Chiesi con un sorriso, immaginando i miei due nipotini dormire accoccolati l’uno all’altro nel lettone. “Domattina li voglio andare a svegliare io, costi quel che costi… Me li voglio godere da appena svegli di mattina come si deve, per una volta…”
Gemma si versò il liquido scuro dal bollitore nella tazza, già pronto da prima che io iniziassi a rigovernare. Il tè pomeridiano era una delle poche abitudini che era riuscita a mantenere anche dopo essere diventata mamma. Mi guardò seria, dopo aver battuto un paio di volte il biscotto sul piattino per liberarlo dalle briciole in eccesso e poi inzupparlo nella bevanda ancora fumante. Anche quella, abitudine che aveva sempre avuto. «Non glielo hai ancora detto, a Camilla?»
«Non c’è bisogno che lo sappia.» Risposi seccamente, voltami e uscendo subito dopo dalla stanza, in modo da evitare ulteriori domande cui non volevo rispondere.
Varcai la soglia del soggiorno appena in tempo per vedere la mia amica destarsi.
Alzai le braccia al cielo, stirandomi la schiena più che riuscivo nel tentativo di uscire completamente dallo stato di dormiveglia. Era incredibile: avevo appena dormito su un divano, eppure non mi sentivo così piena di energie da non sapevo quanto.
«Ben svegliata, stjerne.» Mi voltai verso la cucina e trovai il sorriso e gli zaffiri brillanti di Arkin darmi il benvenuto nel mondo reale, facendo nascere sul mio volto un sorriso di riflesso. Ogni volta che li osservavo, quegli occhi mi facevano l’effetto di una droga. Annegavo nel loro azzurro e non volevo più uscirne, desideravo inebriarmi di quel profondo color zaffiro e diventare io stessa parte di loro, a costo di tramutarmi nella gemma omonima. Mi avevano sempre fatto quell’effetto, sin da bambina.
«Ti va un po’ di tè?» La domanda mi fece tornare al presente, spostando lo sguardo verso Gemma, affacciatasi in quel momento dalla cucina, con una tazza fumante in mano.
Guardai l’orologio che portavo al polso destro e l’espressione mi si fece subito dispiaciuta.
«Ehm… In realtà… Dovrei tornare a studiare…» Sussurrai, gli occhi bassi e sinceramente dispiaciuti per non potermi godere una bella tazza di tè accompagnata da qualche chiacchiera.
«Oh… Capisco. Beh, ti riporto a casa allora, nessun problema.» Arkin si avviò alla porta, prendendo le chiavi dallo svuotatasche e aprendo l’uscio in un unico, veloce, gesto. Feci un veloce cenno di saluto a Gemma e mi sbrigai ad andar dietro al mio amico, mentre riflettevo sull'impostazione insolita che aveva avuto la sua voce nella risposta che mi aveva appena dato: il tono era stato indifferente, frettoloso, quasi persino contento della possibilità appena offertagli di uscire da quella casa.
“Chissà che gli frulla in quella testa…” Non potei fare a meno di pensare. Non dovetti comunque attendere molto per una risposta, visto che Arkin tirò un profondo sospiro non appena ebbe chiuso la portiera della macchina, poggiando la fronte sul volante. «Mi dispiace…» Disse, di punto in bianco. Io lo guardai sinceramente interrogativa, non capendo davvero per cosa avesse bisogno di scusarsi.
«Mia sorella è una gran impicciona, ma non è cattiva… E i miei nipoti sono… Beh, tu hai conosciuto solo Fra perché Gabriele era già a dormire e io la adoro, ma mi rendo conto che a un estraneo possa apparire anche impertinente. E poi…» Lo fermai subito, dandogli uno scappellotto sulla nuca. Si lamentò con un semplice “ahio”, per poi alzare la testa a guardarmi confuso, una mano a massaggiare il punto che avevo appena giocosamente colpito.
«Mi sono divertita molto oggi, sono contenta che tu mi abbia presentato Freya e Francesca. E sono molto felice di aver rivisto Gemma e aver potuto fare quattro chiacchiere con lei. E mi è dispiaciuto davvero tanto non potermi fermare a prendere un tè e salutare Fra, né aver potuto conoscere Gabri prima di venir via.» Gli sorrisi sincera: «Piantala di preoccuparti, è stata una giornata fantastica! Grazie, skystangel.»
Arkin rimase in silenzio a guardarmi stupito per qualche momento, prima di guardare dall’altra parte e mettere poi in moto, con un lieve velo di rossore in volto e un sussurro appena accennato: «Non c’è di che...»
Non potei fare a meno di farmi scappare una breve risata di fronte al suo dolcissimo imbarazzo, prima di guardare fuori dal finestrino e godermi il paesaggio che mi scorreva davanti agli occhi, mentre indicavo la via per casa di mia madre al mio amico.
«Questa… Non era casa di tuo zio?» Chiese Arkin, quando imboccammo una delle tante vie secondarie appena fuori dal centro del paese. Io risposi freddamente. «Era.»
«È... successo qualcosa per caso?» Mi guardò per un istante, mentre gli facevo cenno di raggiungere la fine della strada e imboccare il viale a destra.
«Lunga storia.» Mi voltai verso il finestrino, ma riuscii a vedere l’occhiata che stava a significare: “okay, non ne vuoi parlare, chiaro.” Avevo sempre apprezzato quel lato di lui: riusciva a capire quando fermarsi nel fare domande.
«Ci sentiamo per telefono, d’accordo?» Sorrise, mentre aprivo la portiera e scendevo di macchina, una volta arrivati di fronte al giardino. Da lì in poi, le macchine non potevano passare, l’unico modo per raggiungere il piazzale era percorrere la scia di lastricato a misura d’uomo a lato del prato. Oppure, come facevo sempre io da piccola, togliersi scarpe e calzini e iniziare a correre coi piedi nudi sull’erba, che procurava un piacevole solletico.
«Certo. Salutami Gemma e i bimbi.» Feci un cenno di saluto e uscii dalla vettura, ma venni fermata dalla voce del mezzo norvegese dopo nemmeno due passi: «Ah ah ah. Dove pensi di andare?»
Mi voltai interrogativa e lo vidi che mi mostrava la guancia destra, picchiettandosela con l’indice. «Salutami come si deve.»
Sorrisi furbamente alla sua provocazione, rimettendo la testa in macchina per avvicinarmi a quella faccia a schiaffi. Feci per lasciargli un casto bacio sulla guancia, ma inspirai e invece gli poggiai le labbra sul collo, facendogli una pernacchia e scoppiando a ridere subito dopo.
«Non era così!» Tentò di protestare, ma non ce la fece a trattenere le risa. Aveva sempre sofferto il solletico sul collo.
Poggiai le braccia sul sedile della macchina per sorreggermi meglio, metà del mio corpo ancora fuori. Con un sorriso furbo, gli ricordai che era lui quello che mi riempiva di baci quando ci salutavamo. Lui rispose con un sogghigno, avvicinandosi a me: «Ne vorresti uno da adulti ora, per caso?»
«Continua a sognare.» Gli risposi, sogghignando più di lui. Arkin lasciò cadere la testa in avanti, sorridendo.
Nell’atmosfera fattasi improvvisamente dolce, mi sfiorò la nuca e mi lasciò un bacio leggero sulla guancia sinistra, mentre sorridevamo entrambi. Ancora vicino al mio orecchio, sussurrò: «Vi ser deg, min lille stjerne. (Ci vediamo, stellina mia.)»
«Vi ser deg, min skytsengel. (Ci vediamo, mio angelo custode.)» Prima di dirigermi verso casa gli sorrisi ancora, riaprendo gli occhi e sentendomi abbracciare ancora una volta da quelle due gemme color zaffiro.
Note autrice non rilevanti per la storia (perhé quelle dei capitoli precedenti siccome sì, vabbè)
NO. No no no no nonononononononono NOOO! MI SONO SALTATE LE STORIE!! UWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA T-T T-T T-T
....Non volevo mi saltesseero le storie. Mi ero affezionata tanto alla mia paginetta d'autrice, era tutto in ordine, messo per benino, con una bell'insieme di colori dei ratings, dove vedevo tutto quel che avevo fatto su un'unica pagina... sniff sniff E' una rottura, perché mo' se voglio leggere di Kin devo caricare un'altra pagina! Ed è sola soletta di là! UFFA.
Okay. Basta, finisco qui. Il mio lato da maniaca sta venendo troppo fuori.
Onestamente sono ancora indecisa se far stare arancio la storia o gialla, dubbio che ho sempre avuto. Però... boh, per un po' si fa restare ancora così, poi si vede. La decisione non dipenderà assolutamente dai ratings delle storie che le sono vicino sulla pagina utente, proprio no.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 5
*** Pagina 4 ***
Pagina 4.
I'm only human
I'm only human
Just a little human
I can take so much
'Til I've had enough
(Sono solo un'umana
Sono solo un'umana
Solo una piccola umana
Posso sopportare così tanto
Finché non ne ho abbastanza)
- Human, Christina Perri
Alla fermata dell'autobus e con le cuffie nelle orecchie, cercavo di ignorare il più possibile la richiesta sempre più disperata della mia gola di essere attraversata da un qualsiasi tipo di liquido. Mi schiacciai ancora di più contro il muretto alle mie spalle, nel tentativo di prendere quella poca ombra che la quercia del giardino di quella casa riusciva a offrirmi. Non ho mai saputo se si trattasse di coincidenze o meno, ma chissà per quale ragione il tempo atmosferico sembrava avercela con me nei giorni in cui ero nervosa ancor prima di mettere piede giù dal letto. Se uscivo e mi scordavo l'ombrello, appena mi allontanavo da casa iniziava a diluviare, per poi smettere quando entravo in un qualsiasi edificio e ricominciare appena ne uscivo. Se mi dimenticavo gli occhiali da sole, ogni volta c’erano dei raggi talmente forti che spaccavano le pietre e mi facevano dolere gli occhi per ore. Se rimanevo appiedata, mi dimenticavo la bottiglietta, sacra, dell’acqua perché mi ero preparata di corsa per colpa di una sveglia che non era capace di fare il suo lavoro, con tanto di caldo della malora, seppure fossimo appena entrati in aprile.
Tirai un sospiro rassegnato a quello che pareva essere il mio destino, mentre aspettavo il quinto pullman della giornata, il quale, se tutto fosse andato bene, sarebbe arrivato nel giro di una quarantina di minuti. Cercai di pensare positivo e concentrarmi sulla canzone degli Eagles che avevo nelle orecchie, quando l’ombra di una macchina e il suono del clacson mi fecero guardare avanti. Da dietro al finestrino appena abbassatosi, vidi il volto sorridente di Arkin: «Serve un passaggio?»
«Devo andare in città… a casa di mio padre…» Borbottai, incerta se accettare o meno l’offerta. Il suo sorriso si allargò, mentre si stendeva per aprirmi la portiera e fare cenno di salire: «Salta su, stjerne.»
Rimasi al mio posto, sinceramente combattuta se salire in macchina o meno. Non volevo essere un impiccio. «Davvero?»
Arkin abbassò gli occhiali da sole che fino a quel momento gli avevano nascosto gli occhi e, serio, affermò: «Se non sali in macchina entro due secondi, ti prendo di peso e ti lego sul tettuccio al posto bici.»
Non potei fare a meno di ridere, salendo e ringraziandolo con un sorriso. Nemmeno ce lo aveva, la sua polo, il posto bici sul tettuccio.
Il tempo di ripartire, che Arkin chiese subito: «Allora… come mai appiedata?»
«Aspettavo il pullman…» Risposi io, evasiva.
«Beh, sì… L’avevo capito questo, dato che eri alla fermata del pullman… Riformulo: perché non sei andata in macchina in città?»
«Perché… non… so guidare… Cioè.» Mi corressi subito: «Mettiamo bene le cose in chiaro: non è che non so guidare. Io so guidare. È solo che non… sono... legalmente autorizzata a farlo…»
«Mi stai dicendo che non hai la patente?»
Non risposi, il volto rivolto contro il finestrino del passeggero per evitare di guardare Arkin in faccia, come se il paesaggio dei campi mezzi coltivati fosse la cosa più interessante del mondo.
«Com’è possibile? Io e te abbiamo la stessa età, perché non l’hai presa a 18 anni come tutti?»
«Perché si dà il caso che io a diciott'anni, a differenza di tutti, fossi troppo impegnata.»
«Ah ah… Sì… Certo… E io sono il figlio illegittimo del principe di Norvegia. Dai, non avevi voglia, ammettilo.»
«Ma lo sai che sei proprio un rompiscatole?»
«Ah, davvero? Allora sono sceso di un gradino, fino a ora ero da prendere a schiaffi.»
«Lo sei ancora…» Poi, con tono da cane bastonato, chiesi: «Hai dell’acqua?»
Mi fece cenno con la testa, non distogliendo gli occhi dalla strada: «Nel cruscotto ci dovrebbe essere una bottiglietta.»
Aprii entusiasta, ma l’espressione mi si rabbuiò non appena vidi la targhetta rossa sulla plastica, facendomi borbottare: «Ma è frizzante…»
«Beh… Sì, a me piace frizzante e…» Disse lui, alzando le spalle e, dopo avermi lanciato una breve occhiata, esclamò: «Che stai facendo?»
«La sgaso.» Risposi io non curante, mentre agitavo con forza la bottiglietta nella mia mano, aprivo appena e richiudevo subito il tappo, per poi ripetere l’operazione in modo da togliere il più possibile l'anidride carbonica dal suo interno.
«Ma è la mia acqua!» Esclamò, il mezzo-norvegese al mio fianco, con un tono che doveva essere tra lo sconcertato e l’arrabbiato.
Io risposi con una semplice alzata di spalle: «Tanto tu non la bevi.»
«E se avessi avuto sete anch’io?»
«Appena arriviamo ti do un’intera cassa, contento?» Sbuffai, annoiata da quella discussione: ma perché doveva fare sempre di tutto un problema, anche dove non ce ne erano?
Batté la mano sul volante, come per affermare meglio la propria posizione, per poi indicare il contenitore di plastica tra le mie mani: «Io non voglio una cassa, io volevo quella bottiglietta lì!»
«Ma lo sai che sei più immaturo di un bambino?» Sbuffai, guardando dall’altra parte e facendo fare all'acqua l’ultimo shakeramento. Il semaforo era appena diventato rosso e Arkin approfittò della fermata della vettura per voltarsi verso di me ed esclamare un teatrale: «Ah! Io sarei l’immaturo?»
Non risposi, perché troppo impegnata a estinguere l’arsura che mi stava disintegrando la gola.
«Accidenti… Avevi proprio sete, eh…» Commentò Arkin, ripartendo. Risposi solo dopo aver ripreso fiato, asciugandomi le labbra umide con il polso. «Sì, sono due ore e mezza che aspetto il pullman…»
«Sul serio? Come mai, non è passato?»
Attesi un attimo prima di rispondere, riflettendo se fosse stato il caso di dire la verità o meno. Alla fine scelsi che di lui potevo anche fidarmi: «In realtà è passato ogni mezz’ora, come di regola, solo che ogni volta l’autista non aveva il biglietto da darmi, perciò non sono potuta salire.» Scostai lo sguardo verso il finestrino, mordendomi la lingua, pentendomi subito della scelta fatta, già consapevole di come sarebbe proseguita la conversazione. “Ho sbagliato... Non avrei dovuto espormi così tanto.”
Dopo qualche secondo di silenzio imbarazzante, quasi avesse aspettato lo stop per potersi fermare e guardarmi, Arkin sussurrò: «Che… cosa?» Non risposi, cosa che fece proseguire lui: «Fammi capire… Tu hai aspettato due ore e mezza, con quaranta gradi all’ombra, senz’acqua, in piedi, perché l’autista non aveva da darti il biglietto?» Abbassai gli occhi, mentre un’ondata di un’emozione cui non ero mai riuscita a dare un nome mi attorcigliava lo stomaco. O meglio, voluto dar un nome.
«Perché?»
“Piantala con quello sguardo, non sono un’idiota. So come gira il mondo. Solo che non mi piace, non mi va giù e io così non mi comporto. Ne va della mia coscienza!”
«Salire senza no, eh? Che avresti fatto se non fossi passato io?»
«È illegale prendere il pullman senza il biglietto timbrato.»
«Tu non sei una persona normale… Oltretutto tu lo volevi pure, è colpa dell’autista se non te l’ha dato, se saliva il controllore non poteva nemmeno farti la multa.»
«Non c’entra nulla la multa.» “È una questione più importante.” «Se il mio buon senso mi vieta di fare qualcosa, io non la faccio. Punto.»
«Rischi grosso a fare così. Ti metteranno tutti i piedi in testa…»
«Io non credo al “mangia o vieni mangiato”. Credo che, dando il buon esempio, magari qualcuno potrebbe anche invitarmi a tavola e nessuno resterebbe a bocca asciutta.»
«Potresti morire di fame nell’attendere quell’invito.»
«Allora si vede che sarà destino che io muoia di fame.» Lo guardai, un sorriso triste a distendermi le labbra. «Ma non potrei vivere con la coscienza che, per mangiare io, ho fatto morire di fame qualcun’altro.»
«E a quei vivi che ti lasceresti indietro non pensi?» Quella fu l’ultima domanda, priva di risposta, che venne pronunciata. Restammo ognuno nel proprio silenzio nei cinque minuti successivi, entrambi senza alcuna intenzione di riprendere il discorso. Solo dopo aver varcato il cartello con il nome della città, Arkin distese le labbra in un sorriso e, come non fosse successo nulla, mi chiese: «Da che parte devo andare?»
«Gira a sinistra al prossimo incrocio.» Risposi, grata di poter ricacciare indietro quella sensazione allo stomaco e tornare a toni leggeri. Lui mi lanciò una breve, scettica, occhiata. «Ma c’è un viale privato.»
«Sì, casa di babbo è in fondo a quel viale.»
La macchina svoltò e, mentre percorreva la strada costeggiata da file di cipressi e tigli, vedevo la faccia del mio amico farsi sempre più incredula. “No, ti prego… Non quell’espressione…”
«Mi stai… prendendo… in giro…»
“Non chiedermelo… Ti prego.”
«Ma quanti cazzo di soldi c’hai?»
Mi morsi le labbra, incapace di trattenere un moto di stizza. Dovetti concentrarmi con tutta me stessa per rispondere. «Non sono soldi miei, sono i soldi di mio padre.»
«È la stess…»
«No!» Più che un esclamazione, fu una specie di rantolo. Mi schiarii la voce, cercando di riprendere il controllo. «Non è assolutamente la stessa cosa… Attraversa il piazzale e parcheggia nel garage.»
«Parcheggio?» I suoi occhi erano confusi, ma avevano anche una piccola luce di curiosità innocente. Cercai di sforzarmi il più possibile su quel piccolo barlume e accennai un sorriso. «Non vuoi entrare e vedere casa?»
«Diamine, sì! Subito!»
Una volta scesi di macchina, mi guardai un attimo attorno per essere certa che fosse tutto tranquillo, dopodichè ci dirigemmo in casa.
Dovetti trascinare Arkin per un braccio per l’intero tragitto, ma alla fine riuscii ad arrivare in camera mia senza troppe complicazioni. “Me la sono cavata con un cenno di mano e un sorriso ai soli giardinieri. Riflettendoci, è andata alla grande…” Pensai, mentre aprivo la porta e quasi ci spingevo il mio amico all’interno.
«Hey, te la vuoi dare una calmata?» La voce di Arkin mi fece tornare al presente, la mia espressione in preda alla confusione. Lui tirò un sospirò, voltandosi verso di me e prendendomi i polsi, in modo da tenermi ferme le mani lungo il corpo. «Hai detto che mi avresti fatto vedere casa tua…»
«Di mio padre.» Lo corressi subito, immediatamente di nuovo lucida. Lui mi guardò un attimo più confuso. Tirò un altro sospiro e lasciò la presa sui miei polsi, riprendendo lì dove l'avevo interrotto con voce più calma, una mano nella tasca dei jeans e l’altra lasciata cadere lungo il dorso. «Hai detto che mi avresti fatto vedere casa di tuo padre, ma mi hai strattonato dalla macchina a qui senza darmi tempo di vedere nulla. E tra l’altro, pareva tu volessi nascondermi da tutti.»
Scostai lo sguardo, restando in silenzio. «Ho qualcosa che non va? Ti vergogni di me, per caso?» Lui inclinò la testa, le braccia incrociate al petto, in attesa di una mia spiegazione che arrivò solo dopo che fui riuscita a sciogliere il nodo che avevo in gola. «Non stavo nascondendo te, ma me stessa. Non mi piace stare in mezzo alla gente che lavora per mio padre, non mi piace parlare con loro o avere a che fare con loro. Mi trattano come una principessa, mi guardano come fossi una privilegiata, ed è una sensazione che detesto. Non è colpa mia se sono sua figlia, se lui è uno coi soldi… Non è una cosa che ho scelto io…»
Arkin non disse nulla, non commentò la mia piccola spiegazione, mi diede solo qualche lieve patta sulla testa, sussurrando: «Su, su…» Alzai lo sguardo per vedergli un sorriso strafottente in volto: «Se può esserti di consolazione, io non ti vedrò mai come la principessina di papà. Per me sarai sempre quella bimba che quando si incazza pare un cinghiale.»
«Un… un cosa?» Esclamai inorridita, il volto completamente in fiamme. Avrei voluto dargli uno schiaffo, ma la sua risata mi fermò la mano: «Finalmente! Ecco un’espressione che ti si addice!» Non feci in tempo a ribattere, che Arkin mi diede le spalle. Iniziò a guardarsi attorno, esaminando la mia camera da letto e, dopo qualche secondo di silenzio, si voltò verso di me con un’espressione quasi dispiaciuta: «Questa non è la tua stanza. È una camera degli ospiti, dico bene?»
Mi scappò un amaro sorriso a sentirgli porre quella domanda, sentendomi però anche scaldare un poco il cuore. Decisi di seguire il mio intuito e farlo parlare, magari sarebbe riuscito a farmi sentire compresa, almeno lui: «Perché? Cos’ha che non va la mia camera?»
Arkin sfiorò il muro color denim chiaro, gli occhi leggermente strizzati, segno evidente che stava cercando le parole giuste nella sua mente. «È... fredda…» Si guardò un poco attorno, la mano sempre a sfiorare la parete. «Non ti rappresenta per nulla. È una bella camera, non mi fraintendere: è enorme, il mobilio è fantastico, l’accostamento dei colori è impeccabile per quel che ne capisco io, però… Come dire… Non è tua… Sembra fatta da un designer, buttata lì e lasciata a se stessa. Non c’è una tua foto, non una dei tuoi amici o della tua famiglia, non ci sono tuoi disegni, tutti i libri, noiosi dai titoli, sono ordinati nelle scaffalature, non c’è nulla sul comò se non l'abat-jour.» Si avvicinò alla libreria e mi guardò stranito, quasi non riuscendo a credere a ciò che leggeva. «“Le 48 leggi del potere”? Seriamente?»
Non avevo mai nemmeno aperto quel libro. Così come il buon 80% di quello che era stipato lì dentro, composto da testi su come fare soldi, essere imprenditori di successo, politica e cose del campo della finanza. Saranno anche state ottime letture, per carità, ma non erano assolutamente il mio genere. Erano tutti regali di mio padre.
Il restante 20% erano libri per l'università e dizionari vari. E un paio di libri su Michelangelo Buonarroti e Leonardo Da Vinci, i miei amori Rinascimentali. Anche se erano anni che non prendevo un pennello in mano, non ero mai riuscita a togliermi dalla testa e dal cuore le emozioni che mi trasmettevano quei due Geni. Ammiravo e adoravo tutto di loro, persino la loro relazione d'odio. Ma era una passione, se così si vuol chiamare, che tenevo per me, non mi ero mai trovata a mio agio a parlarne con altre persone, e non credo l'avrei mai fatto. L'unica valvola di sfogo che avevo era Aurora, che tutte le volte ascoltava i miei infiniti sermoni e sproloqui con una pazienza infinita, dandomi pure spago anche se sapevo benissimo che le importava poco. Anche per questo la amavo.
Arkin si scostò dalla libreria. «Non c’è nulla di te qui dentro, questa potrebbe benissimo essere la stanza di una qualsiasi ragazza. Una che aspira a diventare la prossima Bill Gates.» Fece un piccolo sospiro, dopodiché guardò me e aggiunse: «La tua camera da bambina era un’esplosione di colori e personalità, costantemente in disordine probabilmente, ma chi ti conosceva sapeva vedere te in quel casino, che apparentemente non aveva né capo né coda. E trovarti. Ricordo ancora la luce che avevi negli occhi quella mattina che sei venuta alla materna con i capelli ancora tinti dalla pittura che avevi usato di nascosto per dipingere il muro, perché nel bel mezzo della notte ti era venuta voglia di pitturare con le mani le pareti.»
Chinai il capo per nascondere il volto, il labbro inferiore che tremava vistosamente già alla parola “fredda”. Possibile che lui avesse capito in meno di un minuto quello che mio padre non comprendeva da anni?
Vidi le scarpe da ginnastica di Arkin avvicinarsi e nel giro di poco le sue braccia mi avvolsero in un tenero abbraccio. Non disse nulla, non mi chiese nulla, rimase solo a cullarmi dolcemente nel più assoluto silenzio, accarezzandomi i capelli. Ho sempre odiato quando mi toccano i capelli, solo il mio parrucchiere è autorizzato a metterci le mani, ma quel tocco leggero era così piacevole e rilassante che non provai nessuna frustrazione nel riceverlo.
Rimanemmo così per qualche minuto abbandonate, finché non mi fu completamente passata e potei asciugarmi gli occhi senza temere che le mie emozioni sfuggissero di nuovo al mio controllo. In effetti, quel giorno le avevo messe anche troppo alla prova.
Alzai lo sguardo ancora un poco spento e trovai quei due zaffiri che mi osservavano rassicuranti, accompagnati da un sorriso strafottente che avrebbe fatto invidia a Terence Hill nel ruolo di Trinità. Non potei fare altro che ridire e appoggiare la fronte al petto del mio amico, dolcemente sconfitta da quell’accidenti di sua capacità di tirarmi su il morale.
Arkin si staccò e andò a sedersi pesantemente sulla sedia girevole, davanti la scrivania. «Uh, figo…» Sussurrò appena, prima di iniziare a girare come una trottola, ridendo sinceramente divertito, mentre io lo guardavo con un perplesso sopracciglio alzato. Ma davvero avevamo la stessa età? Sul serio il ragazzo davanti a me aveva ventidue anni? Era impossibile: un attimo era il perfetto amico, un confidente e scrutatore d’anima come dubito esistano pari… e l’attimo dopo diventava un bambino in piena regola, anzi persino peggio!
Riusciva sempre a sorprendermi, ma ancora non avevo capito se in modo positivo o meno. Però, questa era una caratteristica che mi aveva sempre affascinata: l’essere in grado, da un secondo all’altro, di lasciarsi prendere dalla spensieratezza più pura e genuina, la capacità di divertirsi con nulla e riuscire a influenzare coloro che ti stanno attorno con una gioia innocente. È un tipo di forza che io non ho mai avuto: la capacità di mettere a proprio agio e far sentire compresi chiunque ti trovi davanti. Dal canto mio, da quando hanno deciso che dovevo essere adulta, lo sono semplicemente diventata. Era successo così, da un giorno all'altro, senza nessun vero preavviso né desiderio personale, senza più nessuna capacità di provare quella gioia innocente se non per mezzo di ricordi che si facevano sempre più sbiaditi. “O forse, ho solo finto di diventarlo…”
Mi rabbuiai un attimo a tali pensieri, ma poi sentii Arkin fare allegramente “wiiiiiii” ogni volta che si dava una nuova spinta per girare ancora più in fretta e mi scappò una risata, accompagnata però dal gesto automatico di scuotere scoraggiata la testa: era uno spettacolo decisamente triste. Anche se in senso buffo. Un buffo triste.
Decisi di smettere di pensare a un modo per definirlo e andai a sistemare i vestiti che la cameriera mi aveva lasciato sul letto, lasciandolo al suo divertimento.
«Okay… Basta, mi viene da vomitare…» Decretò alla fine, dopo cinque minuti buoni di trottola, facendomi scappare un sorriso rassegnato.
«Metto apposto questa maglia e poi ho fatto.» Dissi, prendendo la cruccia e stendendo l’abito. Lui fece un cenno di ok con la mano, spostando gli occhi scrutatori sulla scrivania.
Seduto al contrario sulla sedia, dopo una breve manciata di istanti allungò la mano e prese il portafoglio. Non dissi nulla, tanto dei soldi ero certa che gli importasse meno di niente, anche perché sarebbe cascato male visto che era già tanto se ci avesse trovato 5 euro. Sicuramente era molto più interessato all’indecente foto nella carta di identità, ci avrei potuto mettere la mano sul fuoco; e avrei pure vinto.
Lo aprì, mentre ero certa nella sua mente stavano già andando a formarsi battutine preparatorie su come ero venuta male quando, contro ogni mia aspettativa, tirò fuori un pezzo di carta plastificata, proferendo tra il confuso e l’incredulo: «Ma… questo…» Gli lanciai un’occhiata e vidi che teneva in mano il biglietto a forma di cuore che mi aveva regalato quando eravamo bambini. Mi sorprese un poco il fatto che lo avesse trovato con tanta facilità, perché credevo di averlo nascosto bene.
«Sì, è il tuo bigliettino.» Gli risposi con un sorriso, avvicinandomi e posizionandomi dietro di lui. Il mio amico mi guardò, sorpreso: «Ma lo hai conservato per tutto questo tempo? Sul serio?» Rimisi il portafoglio al suo posto. «Che domande, certo! È importante per me.»
«Certo che è davvero orribile…» Bofonchiò, aprendolo e rigirandoselo perplesso tra le mani. Io sorrisi, lasciandomi sfuggire una risatina sincera: «Ah ah, sì concordo in pieno!»
Arkin mi guardò storto, per poi bofonchiare offeso: «Sei cattiva…»
«E perché? Sei tu che l’hai ammesso.» Sbattei le palpebre, interrogativa.
«Sì, ma tu avresti dovuto dire qualcosa per contraddirmi… Qualcosa come “ma no, non è vero che è orribile”, “sei troppo critico con te stesso”, “avevi solo 3 anni quando lo hai fatto, scemo”... Roba così…» Disse lui, tentando di imitare il tono di voce di una ragazza, ottenendo però il risultato di suonare come una gallina a cui viene tirato il collo. Mi trattenni dal farglielo notare, stringendo le labbra tra loro per non scoppiare in una risata poco carina, mentre Arkin tornava a guardare il pezzo di carta con aria delusa, poggiando il mento sullo schienale della sedia.
Non potei fare a meno di storcere la bocca e prenderlo un poco in giro, sedendomi sul letto a una piazza e mezzo, dietro di lui: «Ma cosa sei, una di quelle adolescenti in cerca disperata di complimenti, che postano le loro foto e dicono “sono orribile” solo per sentirsi dire quanto in realtà siano bellissime?» Lui mi guardò storto, dopodiché si alzò e si diresse nell’altra stanza, allorché io gli chiesi: «Ehi… dove stai andando?»
«A buttare questo obbrobrio.» “Cazzo, la sua memoria!” «Mentre mi trascinavi di qua e di là ho intravisto un caminetto acceso, devo solo ritrovarlo.»
Sì, non avete letto male: acceso. “Per atmosfera”, così diceva sempre mio padre quando gli chiedevo perché tenesse il finto - l’ho sempre considerato tale, visto che per accenderlo bisogna utilizzare il bioetanolo anziché la legna - camino in funzione anche quando fuori si scoppiava di caldo. Non era raro nemmeno che, in contemporanea, accendesse l’aria condizionata. Mio padre era sempre stato un mago di sprechi e risparmi stupidi, in tutti i frangenti. Comprava la carne in offerta che scadeva il giorno successivo, per poi andare a cena al ristorante stellato e lasciarla ammuffire nel frigorifero, se non ci fosse stata la cameriera che la gettava. Mi ripeteva sempre che il rispetto per gli altri e, soprattutto per ciò in cui credono, è la cosa più importante e quelle rare volte in cui andavamo a comunioni, battesimi e via dicendo, era il primo che imprecava prima, durante e dopo l’intera cerimonia, offendendo preti, la cerimonia in sé e tutti “quegli imbecilli che credono a ‘sta roba”. Un uomo pieno di contraddizioni, mio padre.
«Cosa? No, non provarci nemmeno!» Gridai, scattando in piedi e correndogli dietro per impedirglielo.
«Sì invece!» Ribatté lui, fermandosi e stendendo il braccio verso l’alto per impedirmi di riprendermi il biglietto, dato che avevo iniziato a saltellare isterica nel tentativo di riappropriarmene, colmando quei 18 centimetri che ci separavano. «Ma lo hai fatto tu!»
«E tu avresti dovuto bruciarlo tempo fa! È inguardabile!»
«Eddai Arkin! È mio!»
Lui mi guardò con un sopracciglio alzato, un’aria sufficiente in volto: «Tecnicamente l’ho fatto io, quindi è mio.»
Smisi di saltellare e lo fulminai, correggendolo: «No, tecnicamente tu lo hai regalato a me, quindi adesso…» Glielo strappai dalle mani, approfittando della sua distrazione, per poi portarlo con cura al petto e concludere: «Questo biglietto è mio e tu non puoi più riaverlo indietro!» Lo accarezzai dolcemente e mi diressi verso la mia camera, parlando alla carta come fosse un pupo: «Tranquillo piccolo, ora c’è la mamma qui con te, è tutto apposto… Quel vecchio babbuino prepotente non ti farà più del male…»
«Vecchio babbuino prepotente?» Ripeté lui, guardandomi storto e alzando nervosamente un sopracciglio. Io mi voltai e, per tutta risposta, gli mostrai un sorriso a 32 denti.
«Signorina Camilla!»
Il sorriso mi morì l’istante in cui la voce di Janak mi giunse alle orecchie, mentre il corpo si irrigidiva involontariamente. Dovetti sforzarmi con tutta me stessa per voltarmi verso di lui e rispondere al saluto nel modo più naturale possibile. «Ciao Janak.»
Il robusto indiano sulla cinquantina si diresse verso me e Arkin, il sorriso che aveva costantemente in volto più brillante che mai. «Signorina Camilla, che bello vedervi. Restate a cena stasera? Suo padre è…»
«All’estero. Sì, lo so.» Lo interruppi, le labbra serrate e il finto sorriso più naturale che riuscivo a fare. Inspirai profondamente per cercare, invano, di rilassarmi. «Sto solo nel pomeriggio, torno a dormire da mia madre. Per mangiare non preoccuparti, mi arrangio da sola.» Presi Arkin per il polso e me lo tirai dietro verso l’uscita, sorpassando l’uomo e tenendo lo sguardo sul pavimento, sperando con tutta me stessa che non mi parlasse né guardasse più.
Alzai gli occhi non prima di vedere la luce dell’esterno.
Percepii le mani di Arkin sulle spalle, che si rilassarono solo in quel momento. «Tutto okay?»
Annuii, non sapendo che altro fare. Stavo seriamente iniziando a sentirmi male, in quel momento avrei voluto solo correre in camera, spalancare la finestra e chiudere a chiave la porta. E non pensare a nulla, far tacere quelle brutte sensazioni che mi attanagliavano lo stomaco e mi facevano martellare la testa.
Arkin scese un paio di gradini e si voltò verso di me con un sorriso, facendomi tornare presente a ciò che mi accadeva intorno. «Devi studiare ora, dico bene? Io vado.»
«Mi dispiace…» Fu tutto quello che riuscii a dire, senza riuscire a sorridergli. Avrei potuto rifilargli un sorriso falso, ma non volevo. Non con lui.
Come mi avesse letto nel pensiero, le sue labbra si distesero a formare un’espressione di gioia degna di un bambino quando entra in un negozio di caramelle. «Non preoccuparti, dovevo venire comunque in città, ho un appuntamento con degli amici.» Mi accarezzò la guancia con affetto e mi guardò negli occhi, aggiungendo: «E la prossima volta che hai bisogno di un passaggio, chiamami.»
«Lo sai che non lo farò mai.» Ribattei. Lui avvicinò la sua fronte alla mia, sfiorandola appena. «Già… Ma io almeno ci provo. Vi ser deg, lille stjerne. (Ci vediamo, stellina.)» Mi lasciò un lieve bacio sulla nuca e si voltò, avviandosi alla macchina, la mano alzata in cenno di saluto.
«Mh… Vi ser deg… (Ci vediamo...)» Sussurrai, guardandolo fare retromarcia e imboccare il viale. Rimasi immobile sugli scalini fino a che non fui più in grado di vedere la sua Polo bianca, dopodiché girai i tacchi e mi diressi a corsa in camera mia.
Sì, beh... La ragazza ha seri problemi relazionali. E di ansia, quella di tipo sociale. Dovrebbe andare da uno psicologo, ma... beh, uno dei suoi maggiori problemi è la sua relazione con il denaro. Non è essere tirchi, o parsimoniosi, o non averli... E' proprio paura di spendere, non tanto perché si teme o si sa che finiscono, ma proprio paura nel termine più concreto del termine. Per questo ha il portafoglio praticamente vuoto. E questa sua paura del denaro è una buona base per la sua ansia sociale. Non è semplice avere a che fare con le persone in età scolastica (parlo di elementari-medie, molto prima di quanto accade qui) se hai il terrore di invitarli a casa tua. C'era un flashback di Cam sull'argomento, ma non sono ancora sicura di volerlo inserire nel racconto onestamente, forse stonerebbe meno come os, devo rifletterci un poco.
Ha un sacco di pippe mentali in testa, non si fosse capito.
Io onestamente non vedo l'ora di presentare Aurora, la ragazza da un tocco di colore alla storia. E poi è l'unica che riesce a far ragionare un po' Cam. E lei e Arkin insieme sono uno spettacolo pirotecnico, spero davvero solo di riuscire a tramettere la sua energia e il suo entusiasmo infinito. Tutti dovrebbero avere un'Aurora nella loro nicchia di amici...
Bon, grazie se siete arrivati fino a sto' punto, avete una pazienza infinita anche voi evidentemente!
Alla prossima, bye bye!
|
Ritorna all'indice
Capitolo 6
*** Pagina 5 ***
Brevissima prefazione: se non siete pratici di termini di canottaggio, in fondo avete le note.
Okay, ora vi lascio al capitolo... ciao manina!
Pagina 5.
Un ragazzo e una ragazza possono essere solo amici,
ma prima o poi, si innamoreranno l'uno dell'altra.
Forse temporaneamente, forse nel momento sbagliato,
forse troppo tardi o forse per sempre.
- 500 Days of Summer, Tom Hansen
Feci appena in tempo a chiudere a chiave la porta, che il cellulare iniziò a vibrare. Vidi il nome della mia migliore amica sullo schermo e risposi che ero ancora in caduta libera verso il materasso. Non feci in tempo a dire nulla, che la voce entusiasta di Aurora mi raggiunse l’orecchio: «Idraaaaaaaa!»
«Allora Elsa? Finiti gli allenamenti? Com’è andata sul caro amato remoergometro?»
«Non ne posso più! Odio quell’attrezzo!» Sbuffò lei, facendomi sorridere.
«Bugiarda… Hai sempre adorato quella macchina di tortura, tant’è che ti ci sei sposata.»
«Sì, ma oggi abbiamo divorziato. E stavolta sul serio. Definitivamente!» Non riuscii a trattenere una risatina. La conoscevo talmente bene che era come vederla: appena uscita di palestra, stava camminando verso casa, lo zaino sulla spalla sinistra, i capelli biondi ancora bagnati raccolti in una treccia alla bell’e meglio e la faccina offesa.
«Il test lo hai fatto stamani? Com’è andato?» Chiesi, sapendo che non aspettava altro che parlarmene. Finse indifferenza, ma l’eccitazione nella voce era palpabile anche dal telefono: «Mmh… Non è stato il mio miglior tempo… Vedremo come andrà…»
«Sono certa che ti chiameranno anche quest’anno.»
«Speriamo… Ho davvero voglia di Varese, mi manca il brio di barche come l’8+ o il 4-… Sono stufa di scendere in singolo.»
«Scendi in singolo perché sei la migliore.»
«Scendo in singolo perché la mia compagna di 2- mi continua a dare buca!» Ribatté, un velo di tristezza misto a rimprovero nella voce. Mi faceva male sentirla così, ma io ero stata chiara. Non risposi, perciò lei proseguì, quasi con un sussurro: «Immagino che quest’anno non potrò contare sul tuo appoggio, se mi chiameranno a Varese…»
«Ti chiameranno. Sei la stella nascente delle Fiamme Oro, che viene allenata da due medaglie olimpiche. Ti chiameranno.»
«Non hai risposto alla domanda principale…» Ormai si era fermata, arrivata al sottopassaggio. Lo sguardo si era oscurato un attimo e le labbra si erano strette tra loro, così come le mie, mentre sussurravo l’ennesimo: «Mi dispiace…»
Aurora scrollò la testa, le ciocche di capelli bagnati della frangia che le si appiccicavano alla fronte, mentre il sorriso tornava padrone del suo volto: «Non importa dai… Mi basta di sapere che tifi per me, anche se da casa!»
«Ci puoi contare, tiferò sempre per te. Anche quando arriverai alle Olimpiadi!»
«Ah... Sarebbe un sogno! Non vedo l’ora di poter arrivare su quei campi gara… Voglio l'oro di Tokyo!»
«Beh, te l’ho sempre detto, le carte in regola le hai tutte.» Una risata orgogliosa e colma di aspettativa mi arrivò dall’altra parte del telefono. «Già. Soprattutto la testa dura!»
Udii il suono del passaggio a livello, il che significava che ormai la mia amica era quasi arrivata a casa. «Ehi, Idra, senti un po’. Stasera voglio festeggiare il risultato del test alla ventola, che ne dici di andarcene al pubbino?»
«Stasera?» Mugolai, non del tutto certa di voler accettare. Non tanto per lei, ma il luogo.
«Sì daiiii! Fallo per meeee!»
«Ma non vai con Leo? Non ho voglia di fare la terza incomoda, dai.»
«Okay, primo: quando mai sei stata la terza incomoda?» Un lieve cigolio: stava aprendo il cancello di casa sua.
“Vero. Non mi hanno mai fatto sentire così. Anzi, semmai il terzo incomodo pareva proprio Leonardo…” Pensai, non potendo fare a meno di sorridere.
«E secondo: voglio festeggiareeee! Non mi dirai che non mi sono meritata una bella birra in compagnia della mia migliore amica!»
«Mmmh… Dipende… Che media hai fatto stamani?»
«1:53.7, signorina bella.»
«E hai pure paura che la Federazione non ti chiami? Ma sei completamente impazzita?» Esclamai.
«Ho sentito le ragazze del 4+ e non è il tempo migliore… La Sara ha fatto 1:53.2.» La porta di casa venne chiusa sbattendo, il grido di sua madre che la rimproverava dicendo che doveva controllarsi perché sennò l’avrebbe ripagata lei, la sua scusa poco sincera e un mugolio che stava a significare “se la riparo io, almeno non la faccio rifare di legno marcio”.
«Elsa…»
«Dimmi.»
«Stasera ti giuro che ti spezzo le gambe se avrai il coraggio di dirmi una cosa del genere pure in faccia, così è davvero la volta buona che a Varese non ci vai.» Settenziai, seria. La sentii sorridere, uno di quei sorrisi che le arrivavano fino alle orecchie. «Ti voglio un mondo di bene anch’io Idra! Allora è fatta. Ci vediamo alle nove al pubbino, così stiamo anche un po’ insieme solo noi due, quell'altro tanto fa tardi.»
«Leo lavora in trasferta stasera?» Chiesi, giusto per far durare la conversazione quei dieci secondi di più e, soprattutto, accertarmi che tra loro due continuasse ad andare tutto a gonfie vele. Ci fosse stato qualche problema, lo avrei capito dalla sua prossima risposta.
«Yup!»
“Perfetto, tutto a gonfie vele.”
«Ma non hai l’allenamento domattina? Non è un po’ tardi le nove?»
«Domattina andiamo tutti un paio di orette dopo, stasera anche gli altri sono a festeggiare per dimenticarsi delle fatiche del test.»
«Capisco…» Mi sentivo un po’ in colpa nei confronti della mia amica, ma Aurora smorzò, o quantomeno provò, i miei sensi di colpa all’istante: «No, non voglio andare con loro. Vanno in spiaggia e io okay che voglio festeggiare, ma tanto oltre le due non riesco ad andare e non ho voglia di svegliarmi con tutti gli scherzi che mi farebbero in piena notte.»
Sogghignai, ringraziandola mentalmente. «Senti, io sono a casa di mio padre… Vado 5 minuti prima così ordino, okay? Il solito?»
Attimo di silenzio, poi la dichiarazione: «Ti amo.»
«Ti amo anch’io, ma stasera offri tu.»
«Ancora meglio, offre Leo!» Ribatté lei, come fosse la cosa più ovvia del mondo, mentre sentivo l’acqua del lavello scorrere, dove aveva messo il body e gli indumenti dell’allenamento.
«Mi pare giusto.» Mi alzai e iniziai a tirar fuori i libri dalla borsa.
«Tu stai bene?» La voce di Elsa era un attimo mutata, sapevo fosse dovuto al fatto che mi trovavo a casa di mio padre. Aurora sapeva bene che effetto mi facesse quel posto.
Chinai un attimo la testa, aprendo lo schermo del portatile davanti a me e accendendo i due schermi extra che avevo sulla scrivania. «Sì... Preferisco lavorare su due schermi per la tesi, mi torna meglio. Il mio portatile è troppo piccolo, poi mi fanno male gli occhi, lo sai. Stai tranquilla. Dovrò pur sfruttare quel che ho per fare bella figura, che dici?» La percepii tirare un respiro profondo dall'altra parte del telefono, tentativo di far svanire la preoccupazione “da mamma” che provava.
Tirai un sorriso, ripensando a quanto fosse incredibile il modo in cui fossimo legate, senza sorprendermene poi tanto. Avevamo vogato talmente tanto insieme, senza costrizioni esterne, che il nostro legame non poteva annullarsi solo perché non scendevamo più in barca. Non avevo mai avuto ben chiaro cosa fosse il rapporto che si era creato tra noi, in modo così dannatamente naturale, ma non era semplice amicizia. Era qualcosa di molto più profondo, di questo ero certa, senza sfociare nel desiderio sessuale. Elsa per me era come una metà del mio corpo, se non l'avessi avuta al mio fianco probabilmente sarei sopravvissuta comunque ma... non sarebbe stato vivere.
Avevo avuto paura, tanta paura, che qualcuno potesse portarmela via, che questa unione tra noi potesse svanire e andare nel dimenticatoio. Solo il pensiero mi faceva andare ai pazzi.
Scrollai la testa e tirai un sorriso, dicendo con voce leggera: «Non farti troppo bella stasera, okay?»
«Puoi stare tranquilla, sono talmente stanca che non ho voglia nemmeno di truccarmi!» Eccola lì. Era tornata di nuovo la mia Elsa, il mio tsunami di gioia ed energia. «Oggi pomeriggio ho già avvertito che mi faccio tre ore di fondo versione relax.»
“Fondo relax, eh…”
«Non andarti a sperd…» Non feci in tempo a finire la frase, che, già sapendo cosa le avrei detto, Aurora mi interruppe in difensiva, esclamando tutto d'un fiato: «Devo lavare il body, ci vediamo stasera! Bye bye!»
“Sì, si andrà sicuramente a sperdere in singolo.” Pensai tra me e me con un sorriso, mentre aprivo il libro, indossavo le cuffie e mettevo la sveglia alle sette e mezza, per prepararmi ad uscire.
«Bimbi, finalmente!»
«Certo che ce ne avete messo di tempo, eh? Eravate a un tête à tête?»
«Non ti ruberei mai l’amante, non è abbastanza dotato per me.»
«A proposito di amanti… Tommaso dov’è? Non doveva venire con voi?»
«Manca l’anima gemella?»
«Voglio organizzare una cosa a tre, vuoi unirti anche tu?»
«Bene che se ne stia lontano per un po’...» Sussurrai, per poi riprendere a bere. Francesco rispose agli occhi interrogativi del resto del gruppo: «Tommy e il vichingo hanno avuto qualche problema oggi pomeriggio… Troppi shottini prima di venire qui. Ora è a bere al balcone, tornerà dopo una birretta o due.»
«Ma… e da mangiare?» Chiese Alessandro, per far distogliere l’attenzione.
«Hai bisogno di mangiare con la birra?» Sogghignai.
«Beh sai com’è, io non ho sangue vichingo nelle vene!»
«La volete smettere con sta’ storia del vichingo?» Risi, scostando la sua mano dall’arruffarmi i capelli.
«Ehi, norreno.» Si intromise Stefano, facendomi voltare verso di lui mentre il commento di Mirko gli giungeva in risposta: «Uh, questa è scolastica.»
«Deformazione professionale.» Sogghignò, mettendosi a sedere di fronte a me e prendendo una delle birre che erano sul tavolo. «Senti, perché non fai un’opera di carità e vai a prendere un hamburger e patatine per tutti?»
«Perché non alzi il culo e vai da solo?» Ribattei con un sorriso, versando altra birra nel mio bicchiere. Lui mi guardò con fare ovvio: «Perché tu qui sei l’unico in ferie.»
«Appunto, sono in ferie. E lasciatemele godere, no?» Sogghignai, prendendo un altro sorso di tedesca.
«Okay. Facciamo le persone adulte e mature.» Propose Daniele, per poi squadrarci tutti in modo serio. Attese che gli occhi fossero su di lui, dopodiché iniziò a fare la conta, partendo da sé, mentre noi altri ridacchiavamo: «Ambarabà ciccì coccò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore; il dottore si ammalò e la figlia si sposò, ambarabà ciccì coccò!»
«E ti pareva…» Mugugnai, mentre finivo la birra con un ultimo, lungo sorso. Mi alzai reggendomi al piano del tavolino, visto che l’indice del mio amico, al termine della conta, si era posato su di me. Avvertii un lieve giramento di testa, ma non ci feci caso. In fondo, erano almeno un paio d'ore che avevo oltrepassato il mio livello di resistenza, ma non importava: come avevo già detto, ero in ferie.
«Era destino, Arkin.» Sogghignò Emanuele, dandomi una patta sulla spalla.
«Non dirlo mentre te la ridi sotto i baffi…» La mia mano andò ad appoggiarsi sulla sua testa, spingendolo verso il piano del tavolo di legno, mentre gli passavo dietro e mi dirigevo barcollando verso l’entrata del pub. “Cazzo… Forse la vodka di oggi pomeriggio era da evitare…”
Mi appoggiai allo stipite della porta d’ingresso appena in tempo per non cadere, quando udii una voce familiare provenire dal balcone del pub: «No, guarda. Sto bene così, ti ho già detto che sto aspettando un’amica.»
“Cam… e Tommaso?”
«Beh, appunto! Anch’io sono con degli amici, unitevi a noi no?»
«No, grazie. Vogliamo starcene un po’ per conto nostro.» Vidi il sorriso sforzato di Camilla e mi ricordai della sua espressione mentre la lasciavo quella mattina. Mi avvicinai, come spinto da una forza invisibile.
«Capisco, capisco… Le ragazze devono avere il loro spazio da sole, per parlare delle loro cose…»
«Grazie.»
«Che ne dici di unirvi a noi dopo allora? Quando avete finito la vostra chiacchierata?»
«Io veramente… preferirei di no.»
«Eddai bambola, voglio solo…» Il mio pugno impattò con il suo naso prima che potesse finire la frase, facendolo cadere dallo sgabello.
«Ma che cazzo ti prende, razza di imbecille! Mi hai rotto il naso!»
Mi chinai su di lui, gli presi il collo della camicia e portai il suo volto vicino al mio, con occhi di fuoco e un sussurro colmo d'ira: «Non osare mai più chiamarla “bambola”.»
«Hey hey, diamoci una calmata!» Un ragazzo dello staff del pub venne a dividerci, mentre un altro dava un sacchetto con del ghiaccio a Tommaso.
«Se volete darvele di santa ragione, fuori da qui!»
Guardai negli occhi il ragazzo di fronte a me. «E tu che cazzo fai? Vedi uno provarci insistentemente con una ragazza non interessata e non muovi un dito?» Mi bloccai dal sputargli contro altra rabbia, solo perché percepii le braccia di Cam avvolgermi il dorso da dietro.
«Andiamo via.» Mi sussurrò, flebile.
Ubbidii, lasciando che mi prendesse per mano e mi precedesse. All’uscita, strappai di mano una bottiglia di birra a Edoardo. Era ammassato all’entrata con il resto del gruppo, incuriositi, come buona parte della clientela, dal trambusto che avevo fatto.
Trascinai Arkin a un parchetto poco distante dal pub. Un posto tranquillo, dove avrei potuto cercare di capire che diamine gli fosse preso.
Mi sedetti su una delle panchine che costeggiavano la fontana, per lasciargli la mano e fargli cenno di sedersi accanto a me. Lui mi guardò qualche momento, il volto spento, per poi sorridere e portarsi la birra alle labbra. Aggrottai le sopracciglia e feci un respiro profondo per mantenere la calma, visto che in quel momento avrei voluto spaccargli quella stramaledetta bottiglia in testa. Mi alzai e lo guardai dritto negli occhi, cercando di assumere il tono più autoritario che fossi in grado di fare: «Stacca immediatamente le tue labbra da quella bottiglia.»
Lui diede un ultimo sorso, dopodiché ubbidì, un sorrisetto di sfida che rispecchiava esattamente il tono degli occhi. Si avvicinò a me e, a una distanza troppo misera, con la punta delle dita a sfiorarmi il mento, mi sussurrò sulle labbra: «Dovrei posarle su di te?»
Rimasi un attimo di sasso, ma mi ripresi in fretta: non era lui a parlare, ma l’alcool che aveva in corpo. Per questo odiavo quella roba: faceva fare e dire alle persone cose che normalmente non sarebbero mai passate per la testa. Come il suo pugno al tizio di poco prima.
Odiavo l’alcool. E, in quel momento, odiavo anche quella piccola parte di me che si sentiva felice del fatto che il mio amico avesse picchiato un altro perché aveva osato chiamarmi “bambola”, appellativo che avevo sempre odiato, sin da piccola. “Bambola” lo diceva mio zio alla sua ragazza e a me non piaceva già allora: nella mia testa, era un nome con il quale un uomo si riferiva a un giocattolo, un oggetto inanimato, non a una persona, una partner, per quanto potenziale questa potesse essere.
«Baciami, tanto siamo entrambi ubriachi!» Esclamò Arkin, superandomi e salendo tutto pimpante in piedi sulla panchina di metallo, mentre cercavo di togliergli la birra dalle mani.
«Io non sono affatto ubriaca.» Finalmente riuscii a prendere la bottiglia, che mi affrettai a gettare nel cestino più vicino, per poi tornare da lui sulla panchina. Scese con un piccolo salto e si mise a sedere, guardandomi dritto negli occhi. «Ma io sì!» Mi prese le mani e ne baciò il dorso canzonatorio, non distogliendo lo sguardo dal mio.
«Lo vedo, per questo sono qui, per evitare che tu ti ammazzi andando a sbattere contro qualche pino rientrando a casa!» Mi chinai per essere alla sua altezza, non riuscendo a trattenere un velo di rimprovero dalla mia voce. «Che ti è preso poco fa? Ti rendi conto che avresti seriamente potuto finire a botte con quel tizio?» Lui rispose ridendo sprezzante: «Eddai Cam, dillo che tanto non mi hai mai dimenticato!»
Non feci in tempo a ribattere, che mi tirò a sé e, tuttora non so come, mi intrappolò tra sé e la panchina. Avvicinò il suo volto al mio, di colpo completamente serio. «Prova a guardarmi negli occhi, e dirmi che non mi ami.» La sua voce aveva perso ogni traccia di ilarità, era divenuta grave, terribilmente sensuale.
Odiavo l’alcool. E odiavo quella parte di me che avrebbe voluto cedere agli zaffiri che avevo davanti.
Ingoiai il nulla, ma alla fine riuscii a sussurrare un flebile: «Tu stai sragionando.»
«Sì. Sto davvero messo male…» Riuscivo a sentire il suo alito che sapeva di birra e chissà cos’altro, mentre la distanza tra i nostri volti diminuiva ulteriormente. «E indovina un po' di chi è la colpa... Dovresti darmi il mio risarcimento, non credi?» La sua fronte si unì alla mia, i suoi occhi blu potevano benissimo reggere il confronto coi lampioni accesi che in quel momento illuminavano la strada. «Arkin, riprendi il controllo di te. Che direbbe Manuela se ti vedesse ora?» Non mi rispose. Si intrufulò nell’incavo tra il mio collo e la mia spalla, iniziando a lasciarvi una scia di baci che sapevano d’alcool e desiderio. Era serio, era ubriaco; il pensiero di baciarlo per davvero mi accarezzò la mente, ma lo ricacciai indietro all'istante.
Liberai le mani e, con non poca fatica, gli presi le guance, facendogli alzare il volto e guardarlo nuovamente negli occhi. «Devo riportarti a casa, hai bisogno di andare a dormire.»
«Casa mia è troppo lontana.» La voce era diventata incredibilmente lucida tutto d’un colpo, ma sapevo benissimo essere solo un effetto passeggero. Non feci in tempo a rispondere, che lui fece un piccolo sorriso compiaciuto: «Non hai detto che non mi ami.»
Tirai un profondo respiro, dopodiché dissi: «Andiamo a casa.»
Arkin si distanziò con un breve riso, iniziando a camminare - o meglio, barcollare - un passo dietro a me, senza però lasciarmi mai la mano. Aveva una presa dolce e bisognosa d’affetto, come quella di un bambino piccolo, allegra e giocosa. Non pareva per nulla la stretta di mano di un adulto, tantomeno ubriaco.
In quel momento mi odiai con tutta me stessa per non avere la patente e non poterlo riportare a casa sua. Non sapendo dove altro andare, ci dirigemmo a casa di mio padre, passando dal retro. Ringraziai mille volte le abilità che avevo acquisito negli ultimi anni nell’introfularmi in quella casa senza che nessuno mi vedesse, anche se lo avevo sempre fatto per non avere a che fare con chi lavorava là dentro, più che per il non farmi vedere in sé. Ed era vero che mio padre in quel momento era all’estero, ma in casa c’era il guardiano e non avevo nessuna intenzione che facesse la spia su chi portavo a casa di sabato sera.
Arrivati in camera mia, Arkin quasi svenne sul letto. Mandai una breve nota vocale a Gemma, prendendo il numero dal telefono del mio amico collassato, dicendole che Arkin stava bene e che si era addormentato dopo aver bevuto un po’ troppo, che sarei rimasta con lui, giusto per non farla preoccupare sul fratellino disperso. Mi rispose dopo pochi secondi, ringraziandomi e dicendomi di tagliargli le mani se avesse provato a fare qualcosa di indiscreto, chiedendomi di chiamarla se avessi avuto bisogno di qualsiasi cosa, sia durante la nottata che in mattinata. Mi scappò un sorriso di fronte a tanta dolcezza, e mi tornò in mente quanto dettomi da Arkin qualche giorno prima, sul fatto che, da quando era diventata mamma, Gemma trattava come un figlio anche lui, più che come un fratello. “A me piacerebbe avere una sorella o un fratello maggiore che si comporta così con me.”
Mandai un messaggio anche ad Aurora, dicendole semplicemente che andava tutto bene e che l'avrei ricontattata in mattinata, per poi augurarle una buona serata e mettere il cellulare sotto carica sul comodino. Mi passai una mano sul volto, lasciandomi andare in un sospiro, poi l’occhio mi cadde sul corpo del mio migliore amico e sulla sua espressione assopita. Restai ad osservarlo per un po’ e, senza pensarci troppo, mi venne da paragonarlo al bambino di anni addietro. Eravamo certamente cambiati entrambi, ma lui decisamente di più, quantomeno fisicamente. I tratti infantili si erano completamente trasformati in quelli di un adulto, lasciando invariati solo i pigmenti. “L'espressione serena di quando dorme però, è rimasta la solita.”
Stavo per chiedermi quanta muscolatura avesse sviluppato - giusto per deformazione sportiva, siamo chiari, mica per altro -, quando il miagolare di Grugra, entrata in quel momento dalla finestra, mi distrasse. La guardai, posando l’indice sulle labbra con un sorriso. Come se avesse capito, venne a strusciarsi un poco tra le mie gambe, dopodiché risalì sulla base della finestra e riprese il suo giro all’esterno. Fino a poco tempo prima mi chiedevo come fosse possibile che sapesse sempre se mi trovavo a casa di mio padre o di mia madre, ma poi avevo perso le speranze di avere risposta. Era un gatto, non c'era una risposta se non questa.
Mi avvicinai al letto e cercai di coprire Arkin con il lenzuolo, ma quando feci per rimboccargli la coperta lui si rigirò e mi fece perdere l’equilibrio, facendomi cadere sul materasso al suo fianco e stringendomi l’attimo dopo in un abbraccio.
«Prova a dire…» Feci per guardarlo, ma con la testa sul suo petto e la sua mano sulla nuca che me la teneva ferma, non riuscii a vedere se fosse sveglio o meno. «Che non vorresti fare l’amore con me…» La sua voce era calda, colma di tanto affetto che quasi si incrinava; per nulla impastata da sonno, stanchezza o alcool. Se avessi dato retta solo a quella, probabilmente avrei creduto che fosse completamente cosciente e sobrio. «Perché io lo desidero da morire…» Chiusi gli occhi, rimanendo accoccolata tra le sue braccia, in silenzio, crogiolandomi nel piacevole calore di quel corpo a me sconosciuto, finché Morfeo non mi accolse nel suo mondo.
Quella notte sognai di fare l’amore con Arkin.
Okay, a 'sto giro sarò no breve, di più, per il semplice fatto che mi conosco troppo bene e se comincio a parlare di canottaggio e spiegarvi come funziona non smetterei più. Non per male, ma perché mi è davvero impossibile fermarmi...
Quindi, breve informazioni base sulle barche (chiamatele "canoe" e vi spezzo le gambe. Le canoe si usano nello sport della canoa, nel canottaggio si usano le barche. B A R C H E.).
Le imbarcazioni "base" (perché ce ne sono anche altre, tipo quelle storiche dello iole, ma stiamo sui dati di base che è meglio), suddivise in due serie , di punta e di coppia a seconda che ciascun vogatore disponga di uno o di due remi, sono denominate:
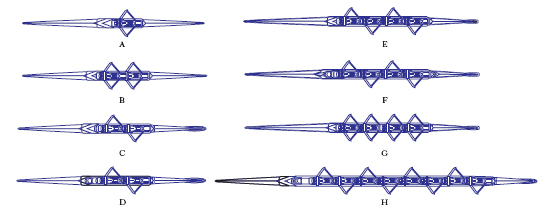
A. singolo (1x), con un vogatore di coppia;
B. due di coppia (2x doppio);
C. due di punta senza timoniere (2- due senza);
D. due di punta con timoniere (2+ due con);
E. quattro di punta senza timoniere (4- quattro senza);
F. quattro di punta con timoniere (4+ quattro con);
G. quattro di coppia senza timoniere (4x quattro);
H. otto di punta con timoniere (8+ otto).
La barca più bella (e più difficile) di tutti è il 2-. E no, non accetto critiche costruttive in merito.
L'imbarcazione della canzone dei Take That - The Flood, è bellissima e sono d'accordissimo, ma il 5x è una tipologia che NON ESISTE. E' stata fatta solo per il video della canzone. Nulla, ci tenevo a precisare la cosa visto che siamo in argomento... Comunque la canzone è bella.
Nel canottaggio è importante, se non essenziale, che ci sia un rapporto tra i vogatori. Bisogna andare in sincrono assoluto: stessi moviementi, stessa forza in gambe-schiena-braccia, stessa posizione di ogni parte del corpo, altrimenti la barca non va. Se hai da correggere l'equilibrio, la direzione, la forza che metti nella vogata ad ogni singolo colpo, la barca non va, sprechi energie e basta. L'ideale sarebbe anche avere un fisico simile, un'altezza che varia di poco, così come anche il peso, una buona apertura di braccia e schiena dritta. Si è più persone, ma bisogna essere una sola... un po' come la fusione in Dragon Ball. Ah, e la tecnica è molto più importante della forza; uno sulla forza e la resistenza ci può lavorare in seguito, è a questo che servono le sei ore e passa di allenamento giornaliero, ma bimbo mio se non hai la tecnica è come andare a zappare la terra con la paletta giocattolo da mare, senza secchiello.
Il canottaggio è forza e armonia che diventano una cosa sola, è questa la sua magia.
Ultima nota e poi giuro che mi zittisco: le Fiamme Oro sono una delle squadre sportive militari italiane. Di solito, se si vuole fare il lavoro di atleta, si entra in una di queste organizzazioni dove, una volta finita la carriera agonistica, si può scegliere se rimanere o meno. Quelle italiane sono:
- G.S. Fiamme Oro - Polizia di Stato
- G.S. Fiamme Gialle - Guardia di Finanza
- G.S. Forestale - Corpo Forestale dello Stato
- G.S. Fiamme Azzurre - Corpo di Polizia Penitenziaria
- G.S. Fiamme Rosse - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Un ultimo appunto, quando Aurora parla di "oro di Tokyo". Non so se lo sapevate/ricordate, ma nel 2020 le Olimpiadi si sarebbero tenute a Tokyo, solo che poi... beh. Lo sappiamo tutti quel che è successo. Questa storia si svolge a cavallo tra il 2018 e il 2019, quindi il Covid era un qualcosa che ancora non esisteva.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 7
*** Pagina 6 ***
Pagina 6.
E mi ha risposto quell'uomo
che all'amore non servono parole
ma cenni silenziosi
e sguardi di zaffiro.
Il bacio non ha nome,
non resta scritto nemmeno sulle tombe.
Il bacio è un rosa sospesa nel vento
e i suoi petali si sfogliano sulle labbra.
– Sergej Aleksandrovič Esenin
Scossi la testa, svogliato e infastidito dal trillio del cellulare. Un leggero mugolio mi uscì spontaneo dalle labbra: odiavo svegliarmi con il suono della classica sveglia, e quello dei telefoni mi era sempre parso più odioso dell’originale analogico. Io mi svegliavo con i Nickelback, perché la gente non poteva prendere esempio?
Il trillio riprese, il tono più alto di prima.
Con un sospiro frustrato allungai il braccio per prendere quel dannato apparecchio e spegnerlo una volta per tutte. Magari gettandolo fuori dalla finestra.
Aprii lentamente gli occhi, per andare a colpo sicuro e fermare al più presto quell’orribile suono, quando vidi il volto di Cam sul mio petto. “Ma che…”
Non seppi dire se fu solo la mia immaginazione, ma cadde il silenzio più totale: l’unica cosa che sentivo, era il respiro della mia amica. Cercai di ricordare come fossimo finiti lì, e d’improvviso il panico: che diamine ci facevo nel letto in casa di suo padre? Controllai alla velocità della luce la cosa più importante, tirando un sospiro di sollievo: okay, i vestiti li avevamo entrambi addosso, quindi non avevamo fatto cazzate. “E già questo è un gran risultato…”
Un suo respiro più pesante mi fece riposare lo sguardo su di lei, e mi rilassai subito: vederla dormire tranquilla e rannicchiata al mio petto era una sensazione impagabile.
Le accarezzai gentilmente i capelli, mentre la mente mi faceva ricordare sprazzi della notte precedente. Una fitta lancinante mi fece portare la mano libera al cranio. “Dannazione… la testa… Ho davvero esagerato con l'alcool stavolta.”
Non riuscii a riportare tutto alla luce, solo io che la trovavo al pub e davo un pugno a Tommaso, Cam che mi trascinava via, io che le dicevo che avrei tanto voluto fare l'amore con lei.
“Arkin, sei un grandissimo imbecille.” Passai la mano libera nei capelli. “Come devo fare con te…”
Il telefono ricominciò a squillare, strappandomi ai miei pensieri. “Nemmeno un bombardamento potrebbe svegliarti, eh?” Mi allungai per prenderlo e feci scorrere il dito verso destra senza nemmeno guardare lo schermo, in modo da silenziare quella tortura. “Sei davvero incredibile, Cam.” Le lasciai un bacio leggero sui capelli, gesto che, non so come, mi fece ricordare il sogno di quella notte.
“Cazzo.”
Un piccolo sorriso amaro mi distese le labbra, mentre andavo a poggiare il mento sulla sua testa. «Alla fine abbiamo fatto l'amore, eh…» Sussurrai. Abbassai le palpebre, amareggiato. “Dannazione… Non riesco proprio a non innamorarmi di te ogni volta che ti vedo, vero?”
Una voce che non conoscevo mi fece alzare gli occhi, che si diressero in automatico verso la sua provenienza: il cellulare di Cam. Lo presi e lo portai all'orecchio, rendendomi conto che prima non avevo spento la sveglia, ma risposto a una chiamata. «Pronto?»
Silenzio, per qualche istante. Dopodiché la voce di una ragazza mi raggiunse l'orecchio: «Tu chi cazzo sei?»
«Chi cazzo sei tu, piuttosto.» Guardai il nome sullo schermo: Elsa. “Ma chi è, la tizia di Frozen?”
«Sai com'è, di solito è chi chiama che si presenta.»
«Sai com'è», rispose lei, facendomi il verso: «Di solito quando chiamo la mia migliore amica la domenica mattina non mi risponde uno sconosciuto.»
“Touché.”
«Senti, non mi interessa chi sei, ma dov'è Camilla?»
«Qui tra le mie braccia che dorme.» Risposi, senza nemmeno riflettere troppo su quello che dicevo. «Ieri sera abbiamo fatto un po’ tardi, tra una storia e l'altra.»
«Ah.» Rispose lei. Dopo un momento di pausa, aggiunse: «Senti un po’, dove hai detto che siete?»
«A casa di suo padre, perché?»
«Mh… Quindi tu e Cami siete a letto insieme a casa di suo padre.»
«Sì… Ma non capisco il tuo ton…» Non mi lasciò finire, che iniziò con la minaccia del secolo: «Sentimi bene, bimbino bello. Primo, non ti azzardare a torcerle manco mezzo capello, perché altrimenti ti taglio tutte le ditina una falange alla volta, per passare poi alle braccia e al resto del corpo. Il mi' omo è macellaio, quindi ho i mezzi per farlo. Conosci gli albi, di Markus Heitz? Sappi che in confronto le loro torture ti parranno il paradiso. Secondo, non esiste e lo ridico un'altra volta per essere ancora più chiara, non esiste, che Cami porti un ragazzo a casa di suo padre, soprattutto in piena notte. Guarda, avrei potuto crederti molto di più se tu m’avessi detto che eravate in un campo di riso della pianura padana, ma a casa di su’ pa’ non esiste. E terzo…»
«Ah, c'è pure dell'altro?»
«Per te s’arriva anche al ventesimo punto, bimbino-che-sta-per-avere-tutte-le-sue-ossicina-rotte. Terzo: passami la mia amica!»
«Okay, ora tocca a me. Primo: tu sei pazza. Secondo: che tu ci creda o no, siamo davvero a casa di suo padre. Terzo: te lo scordi che te la passo, perché sta dormendo come un an...» Mi bloccai, perché in quel momento sentii Cam muoversi e star per svegliarsi. «Resta in linea.» Misi il telefono da parte e spostai delle ciocche di capelli dal volto della ragazza che avevo di fronte.
«God morgen, lille strejne. (Buongiorno, stellina.)» Dissi in un sorriso, mentre lei si stirava con ancora gli occhi chiusi. «God morgen… skystangel... (Buongiorno... angelo custode...)»
“Okay, questa è nuova.” Rimasi sinceramente colpito. «Da quando parli il norvegese da appena sveglia?» Chiesi in un sorriso. Lei mi rispose guardandomi negli occhi con aria furbetta: «Me l’hai servita su un piatto d’argento.» Si guardò attorno, un attimo stranita, poi chiese: «Ma c’è qualcun’altro qui?»
«Oh... Beh, c’è una certa Elsa…» Risposi, prendendo il telefono e porgendoglielo. Cam sbiancò all’istante. Stavo per chiedere informazioni, quando mi strappò il telefono di mano alla velocità della luce e iniziò a parlare con la pazza, alzandosi dal letto con un salto che manco un cerbiatto e facendo avanti e indietro per la stanza. Non sapendo che altro fare, mi accomodai meglio sul materasso, misi le mani dietro la testa e restai a osservare la discussione.
Capii solo tre cose della chiamata di oltre quaranta minuti: le due si sarebbero dovute incontrare la scorsa sera al pub, non fosse stato per l’incidente con il mio nome, Cam avrebbe dovuta chiamarla in mattinata per spiegarle tutto, ma non l’aveva fatto perché aveva dormito, e tra un’ora ci saremmo incontrati tutti e tre per il pranzo. Non capivo perché dovessi andare anch’io, ma a un posto che si chiamava “I Porci Comodi”, come avrei potuto dire di no?
«Aurora non è cattiva, è solo… una persona molto, ehm…»
Arkin cercò di aiutarmi a trovare la parola giusta, mentre apriva la porta del locale e mi faceva cenno di entrare per prima: «Pazza.»
«Entusiasta.» Lo corressi io. «Autentica, vive le sue emozioni così come sono. E le mostra, così come sono, come le sente.»
“Forse anche troppo, alle volte…” E giusto per confermarmi, non appena mettemmo piede all’interno del ristorante, la voce troppo euforica di Elsa mi arrivò alle orecchie: «Tu sarai mio figlio!»
“Eh?”
Sia io che Arkin ci inchiodammo sulla soglia del locale, guardando la bionda che stava avvicinandosi nell’istante in cui i suoi occhi color miele si erano posati sul mezzo norvegese al mio fianco.
Mi voltai verso di lui, confusa da cosa la mia migliore amica potesse intendere. Poi capii. “Oh no…”
Aurora intanto ci aveva raggiunti e stava osservando Arkin con delle stelle al posto degli occhi, le mani unite appena davanti al petto, nemmeno lo stesse pregando. Non aveva senso pregarlo, tanto lei aveva già deciso. «Tu sei perfetto! Ti sto cercando da mesi!»
L’espressione di Arkin in quel momento penso che non la dimenticherò mai. Mi spiace non essere riuscita a fotografarlo, davvero. Era palese dal suo sguardo che stava pensando a tutte le vie di fuga possibili da quella pazza sconosciuta, osservandosi intorno cercando di non darlo a vedere e allo stesso tempo mantenere lo sguardo su Aurora, per non perderla di vista. Mai perdere di vista la gente strana.
Arkin mi costrinse a fare un passo indietro tirandomi la maglia e mi mise il braccio davanti al dorso, come a protezione. “È davvero adorabile… Peccato non sia io ad aver bisogno di essere protetta.”
«Elsa, ti prego…» Sussurrai con tono conciliante, spostando il braccio del mio amico e frapponendomi tra lui e la bionda.
«Ma certo… perché mai non sono sorpreso che sia la tizia di stamani…» Sentii alle mie spalle Arkin sussurrare tra i denti, mentre Aurora mi avvolgeva il collo in un abbraccio. «Idra ti adoro! Mi hai portato il vichingo perfetto!»
Percepii lo sguardo stranito di Arkin, insieme a quelli dei clienti del ristorante, evidentemente incuriositi dalla nostra scenetta. “Forse pensa che le ho parlato della sua doppia nazionalità? Ma poi perché dobbiamo sempre attirare attenzione, uffa! È davvero troppo chiedere di stare tranquilla?”
«Uh, ma… Senti un po’», Aurora si allontanò da me e iniziò a punzecchiare i quadricipiti e le braccia del ragazzo al mio fianco, gli occhi diventati incredibilmente indagatori: «Hai mai pensato di fare canottaggio?»
“Cazzo, Elsa. Seria?”
«Ehm… No?»
Richiamai la mia amica in maniera secca, era giunto il momento di finirla: «Au.»
«Ah. Hai ragione…»
Chiunque avesse provato a chiamarla “Au” avrebbe ricevuto la sua ira eterna, ma da me e da Leonardo, in occasioni in quali capiva che aveva superato la linea, era accettabile e l’unico risultato era quello di farla rabbuiare per qualche istante, in volto l’espressione di un cagnolino bastonato. «Scusami Cami.» Fortuna che questo durava davvero solo una manciata di secondi: Aurora tese la mano ad Arkin sfoggiando il migliore dei suoi sorrisi: «A ogni modo, piacere di conoscerti Björn, io sono Aurora, ma tutti mi chiamano Elsa. Scusami per stamani, ma ero un po’ preoccupata… Sai com’è, con tutto quel che si sente in giro.»
Arkin le strinse la mano, ancora un poco perplesso dalla situazione.
«Ehm… Io non mi chiamo Björn? Ma piacere di conoscerti, comunque. Figurati, credo avrei reagito al solito modo fossi stato in te. Se non peggio… Io sono Arkin.»
«Aurora tende a chiamare la gente con soprannomi.»
«E tu sei la copia sputata di Björn Ragnarsson! Il che mi riporta all’argomento principale… Hai mai pensato di fare un cosplayer di Járnsíða?»
«Ma… Dici quello di Vikings?»
“Ed è così si inizia…” Contenta che i due fossero tornati loro stessi e fossero completamente a proprio agio l’uno con l’altra, almeno credevo, detti una pacca di incoraggiamento sulla spalla a entrambi, dirigendomi verso il retro del ristorante. «Voi avviatevi al tavolo, io devo andare un attimo al bagno.»
«Fai con comodo!»
«Eh? No, aspetta… cosa? Cam!»
«Vieni qui te, abbiamo un sacco di cui discutere! Il Lucca Comics è solo tra qualche mese!»
Sorrisi loro, mentre Aurora trascinava quasi di peso Arkin al tavolo. Era incredibile quanta energia possedesse quella ragazza; era davvero una forza della natura, in tutti i sensi. Molte volte, seppur con vergogna, le avevo invidiato profondamente quel suo potere.
“Scusa Arkin… Ma ho bisogno di qualche attimo da sola per tornare tranquilla…”
Rimasi qualche istante con i polsi sotto l’acqua corrente, a fissare il liquido che mi colpiva la pelle. Era una cosa che avevo sempre trovato estremamente piacevole e rilassante, nonché ipnotizzante. Di fatti, riuscii a riscuotermi solo udendo la porta del bagno aprirsi, facendo entrare un’altra persona. Terminai la mia terapia e mi guardai brevemente allo specchio, cercando di sorridere alla mia immagine riflessa. “Va tutto bene.” Mi ripetei più volte, per poi allargare il sorriso, asciugarmi le mani e dirigermi fuori, pensando di dover cercare con gli occhi i miei due migliori amici almeno per qualche secondo, prima di trovarli. Mi sbagliavo, per il semplice motivo che mi bastò seguire gli sguardi confusi e divertiti dell’intera sala, per trovare i miei due idioti.
«Piantala di dimenarti come un orso!»
«E tu piantala di giocare coi miei capelli! Mi fai male!»
«Che cosa state facendo…» Sussurrai loro a denti stretti, probabilmente con il volto viola per l’imbarazzo che stavo provando in quel momento. Aurora stava cercando di fare delle trecce ad Arkin, il quale, essendo sempre stato estremamente fioso in quanto a capelli, stava facendo di tutto per farla demordere, dimenandosi e lanciandole tutto quello che trovava sul tavolo e a portata di mano. Tovagliolini, chicchi di zucchero, sale e non osai continuare a esaminare cos’altro, si trovava metà in terra alle sue spalle e metà addosso a Aurora.
«Piantala Björn! Resta fermo!»
«Smettila, strega!»
«Finitela, tutti e due!» Stufa, li presi per le orecchie e li trascinai fuori dal locale, imbarazzata come mai in vita mia. “Non metterò mai più piede lì dentro… Dio che figura!”
Una volta che ci fummo allontanati abbastanza, mollai la presa su di loro e mi rivolsi a entrambi con una mano a massaggiarmi la tempia: «Sapevo che sareste andati d’accordo, ma non credevo a questi livelli… Non sin da subito, almeno…»
Arkin e Aurora si stavano dando le spalle, entrambi con le braccia incrociate al petto. L’unica cosa che dissero furono un “ingrato di un Björn” e un “pazza di una strega”.
Tirai un sospiro. “Dovevo immaginare che sarebbe andata a finire così, conoscendoli…” Li osservai per un attimo, dopodiché mi venne in mente un’idea per risollevare la mattinata, ma soprattutto andare a mettere qualcosa sotto i denti, visto che iniziavo seriamente ad avere fame. Sorrisi e, facendo finta che non fosse successo nulla, proposi: «Che ne dite di andare a mangiarci una crêpe e un gelato sul corso?» Gli occhi di entrambi si puntarono su di me, scintillanti. “Bingo.”
«Andiamo!» Proclamò Aurora, alzando il braccio e precedendoci come fosse una guida turistica. Arkin accettò senza nessun tentennamento e io potei ritenermi fortunata.
Dieci minuti dopo, ci trovavamo sulle panchine della piazza. Aurora con una crêpe fumante e stracolma di nutella che quasi scoppiava, Arkin con un gelato da cinque gusti differenti. Io avevo optato per uno yogurt super agghindato.
«Diceva che se la gente avesse saputo quanto energie metteva nei suoi lavori, non lo avrebbero considerato tanto straordinario.»
«Ma?»
«Ma, per me, Michelangelo è il genio del Rinascimento. Un Genio Divino.»
«E che mi dici di Leonardo Da Vinci?»
«Quello era un fottuttissimo amministratore delegato del Rinascimento!»
«Un che cosa?» Chiese Arkin, sorridendo divertito.
«Maestro delle mille arti, che però non ne portava a termine una.» Spieghai io, gli occhi che probabilmente mi brillavano tanto da sembrare che stessi sul punto di piangere. «Anche dei dipinti, Leonardo faceva bozzetti e i suoi allievi li portavano avanti. Non a caso uno dei suoi lasciti è “l'arte non è mai finita, solo abbandonata”. Michelangelo non era così: quel che iniziava, lo finiva. Campava a pane e acqua, lavorava anche la notte, aveva paura di morire prima di portare a termine una commissione, ma finiva. Da Vinci invece aveva talmente tante idee che gli frullavano nella testa, che non ce la faceva a finirne una… Forse per mancanza di tempo.»
«Onestamente non riesco a capire chi ti piace di più.»
«Perché? Devo per forza avere un preferito? Adoro entrambi.» Sorrisi. «E amo il rapporto che avevano tra di loro, nella mia testa ormai mi sono fatta talmente tanti filmini sulla loro relazione che potrei scriverci una collana! Se poi ci si ficca anche Raffaello in mezzo, allora sarebbe la threesome perfetta.»
Arkin alzò un sopracciglio, sorridendo preoccupato. «Ho paura a chiederlo ma... perché? Che rapporto avevano?»
«Dicesi di odio. Per me era semplice rivalità, c'era stima in fondo in fondo. Ognuno riconosceva il talento dell'altro e ne prendeva inspirazione. Penso fosse un amo et odio, dettato dalla rivalità e voglia di supremazia nei confronti dell'altro. Soprattutto per quanto riguarda Michelangelo, con quel caratteraccio che si trovava... Canaglia Divina... Certo è che quel bambino strafottente di Leonardo non gli dava mica tregua. Lo sapete che fece parte della commissione per decidere la posizione del David? E che lo voleva mettere in una nicchia, mezzo nascosto e da parte per non dar fastidio al passaggio dei soldati, nella Loggia della Signoria, anziché sull'arengario di Palazzo Vecchio? Ovviamente Michelangelo se l'è legata al dito... Ma dico, vi rendete conto?»
«Sacrilegio!» Esclamò Elsa, falsamente scioccata, che mi aveva sentita raccontare quella storia per la centesima volta. «E così come avremmo potuto ammirarne il culo perfetto?» Io risposi con un sorriso: «Esattamente!»
“In effetti, non poter avere in bella vista il culo migliore del mondo, sarebbe stato davvero uno spreco... Per non parlare di quelle mani...” Sogghignai tra me e me, rivedendo la mia scultura preferita in assoluto attraverso gli occhi della memoria. “Hai creato qualcosa di troppo bello, Maestro...”
«Io continuo a pensare che Da Vinci fosse il migliore comunque. E a proposito di “Leonardi”...» Mi voltai verso la mia amica appena in tempo per vederle fare un salto dal tronco d’albero su cui si era appollaiata degno dell’atleta che era. «Io devo vedermi con il mio, di Leo. Andiamo a vederci un film.»
Osservai l’ora e mi venne un colpo: era quasi il tramonto, eravamo davvero stati a chiacchierare per ore senza rendercene nemmeno conto?
Una volta tornata eretta a terra, ci lanciò un’occhiata da sopra la spalla: «Scusate, ma me la do a gambe!»
«Ci sentiamo stasera.» Le dissi con un sorriso, lei annuì: «Ti racconterò com’era il film!»
Non potei trattenermi: «Chi lo ha scelto?»
«Io.»
«Quindi… film di animazione dove scoppierai a piangere dopo qualcosa come, quanto, 1 minuto?»
Elsa mi mostrò uno dei suoi sorrisi più raggianti: «Ci puoi contare!»
Ridemmo insieme, poi Aurora si mise di fronte ad Arkin, seduto sullo schienale di una delle panchine che ornavano il parco della città dove ci eravamo fermati dopo pranzo. Gli diede un pugno leggero sul pettorale, un sorriso di sfida sul volto. «Trattami bene la mi' bimba, capito?»
Lui rispose con un sorriso che avrebbe fatto invidia a un attore professionista, mi cinse la vita e attirò a sé, sussurrando poi con le labbra sui miei capelli e gli occhi puntati in quelli di Elsa: «È nelle mani migliori del mondo.»
«Piantala, attore dei miei stivali.» Sorrisi io, allontanandomi da lui con una piccola gomitata, ricevendo un’espressione divertita da parte di entrambi.
In quel momento, ero felice. Era strano pensarlo, troppo strano dirlo, ma mi resi conto che non mi sentivo così felice da tanto tempo. “Vedere i miei due migliori amici sorridere così… Sono così felice che mi viene quasi da piangere, è ridicolo…”
Aurora ci salutò un’ultima volta con la mano e si diresse dalla parte opposta alla nostra, che prendemmo invece una delle traverse della città senza riflettere troppo. Avevamo solo voglia di camminare un po’ assieme, poco importava dove stavamo andando. Non eravamo ancora pronti a salutarci.
«Siamo sempre stati artisti…» Disse Cam di punto in bianco. Mi voltai un attimo a osservarla, aveva le mani unite dietro la schiena e camminava guardando le nuvole, in volto un’espressione di pura… leggerezza, non c’era altro termine per descriverla. «Ricordi come ci chiamavano da bambini?»
Un piccolo sorriso mi distese un attimo le labbra, lo sguardo cadde sulla punta delle mie scarpe. «L’attore, la pittrice e il musicista…»
«Già…»
«Buffo come nessuno di noi abbia coronato quel sogno d'infanzia. Avevamo talento…» Alzai il capo, cercando di nascondere il turbamento che sentivo nel petto con un tono leggero. Lei rispose con una risata forzata: «Per quanto mi riguarda, il pennello non porta il pane in tavola.»
«È quello che ti ha detto tuo padre?» Mi morsi le lingua non appena lo dissi, una nuvola cupa attraversò il volto di Camilla, appesantendo l’aria tra noi come un macigno. Mi odiai. Ma perché tutte le volte che avevamo un momento tranquillo e sereno, per una ragione o l’altra, lo rovinavamo sempre? Cos’era la nostra, una maledizione lanciata da una qualche divinità?
«Meglio andare, sta iniziando a fare buio.» Tono pesante, esattamente come il macigno.
«Cam, scusa, non volev…» Non riuscii a terminare la frase, che lei si voltò verso di me con un sorrisetto di sfida e sogghignò: «E comunque… eravamo la pittrice, l’attore e il musicista. Vedi di non dimenticare l’ordine giusto dei ruoli.»
Era un trucco, riuscivo benissimo a capirlo. Un trucco per tentare di celare quello che provava in realtà, per non affrontarlo, lo stesso che le avevo visto usare in casa di suo padre. Sapevo benissimo che era un atteggiamento deleterio, che era come una bambina nuda con uno scudo e che, quando quello scudo non ce l’avesse più fatta a reggere i colpi inferti, si sarebbe frantumato sotto i suoi occhi e l’avrebbe lasciata completamente indifesa, alla mercé del mondo. Sapevo che era giusto fare qualcosa per aiutarla a fare affidamento non solo su uno scudo, ma anche un’armatura, capace di proteggerla nei momenti peggiori. “Ma non oggi… Non io… Non accetterebbe di abbassare lo scudo con me, non dovrebbe. Non lo merito.”
Tirai un sorriso e allungai il passo per avvicinarmi a lei. «Da quando in qua i tuoi disegni erano migliori della mia recitazione?»
«Da sempre, sono sempre stata meglio di te. Per questo ero il capo.»
«Sì, il capo che mi fece saltare da un albero con un lenzuolo a mo’ di paracadute e mi fece quasi ammazzare.»
«La vuoi smettere con quella storia? Sei tu che non sei riuscito a centrare il materasso e le foglie, perché sei un incompetente!»
«Brutta…» Le avvolsi il braccio al collo e iniziai a farle la masa sui capelli. «Ti rendi conto che ho ancora la cicatrice in testa?»
«Smettila!»
Non avevo nessuna intenzione di fermarmi finché fossi stato in grado di farla ridere così, ma non appena Cam socchiuse gli occhi, il buonumore svanì improvvisamente: «Cambiamo strada.»
«Perché? Che succede? Non vuoi vedere il tramonto sul fiume? È uno scenario carino. Romantico, perfetto per noi due.» Dissi con con sorriso scherzoso, che però si spense non appena vidi l’espressione cupa di Cam.
«Non voglio guardare il fiume.» Si liberò dalla mia presa, dando le spalle sia a me che all’argine. Il tono era uno che non le avevo mai sentito, persino quello del giorno precedente quando mi aveva parlato di suo padre e del rapporto con la sua casa, se messo a confronto, suonava entusiasta. Vi riconobbi una dose di dolore e rimorso che non avevo mai creduto potesse appartenerle. Quel tipo di dolore emotivo talmente intenso da farti male fisicamente.
«Ho fatto canottaggio per anni.» Si avviò verso la città a passi svelti, la testa bassa, senza guardare mai indietro. «Ne ho abbastanza di tramonti sull’acqua.»
“No, non è vero… Qui c’è dell’altro, che non mi vuoi dire.” Diedi un ultimo sguardo alle mie spalle, un’idea che mi iniziava a balenare nella mente. “Lo so che non dovrebbero essere affari miei, però…”
La raggiunsi con delle falcate veloci e le proposi con tono leggero di rincasare.
Guardai l’orologio al mio polso: 11h47. “Dovrebbe essere aperta… Provar non nuoce.”
Chiusi la portiera della macchina e varcai il cancello aperto color canarino, che dava su uno spiazzo di ghiaia. Non c’era nessuno fuori, ma dai rumori di pesi che venivano staccati da terra e la musica provenire dall’interno, era ovvio che la palestra fosse viva.
Mi avvicinai alla porta d’ingresso, spalancata, e mi affacciai bussando. «Ehm… Buongiorno?»
«Jolly vai te, son nel pieno del circuito!»
«E va bene… ‘Giorno, posso esserle utile?»
«Ehm… Sì… Credo, spero. Volevo chiederle un’informazione, se non le spiace.»
«’io bono, ci mancherebbe. Dica.»
«Non è che conosce una certa Camilla? Dovrebbe aver frequentato questa palestra per diversi anni…»
«Chi, Idra ssj? Certo che la conosco! Ma non viene più ormai.»
«Sì lo so… Io sono venuto per chiedere se sapevate dirmi il perché ha smesso.»
«Chi sei tu? Perché vuoi sapere di Cami?»
«Marta, calma…»
«Io sono un suo vecchio amico… Ci siamo rivisti dopo anni e ieri per caso siamo passati sopra il fiume e ci mancava poco che cominciasse a piangere… L’ho vista particolarmente sconvolta e volevo sapere se sapevate dirmi perché. La voglio aiutare se ne ho la possibilità…»
Le cinque persone all’interno della piccola palestra si guardarono un attimo con esitazione, persino il ragazzo che stava facendo il circuito si era fermato. Non seppi bene perché, ma un brivido mi percorse la schiena.
«Che è successo? Perché Cam ha smesso di allenarsi?»
«Björn?» Una voce familiare mi fece voltare verso l’esterno, dove vidi Aurora con una barca su una spalla e due remi nella mano libera, che probabilmente rientrava dal suo allenamento in acqua. Mi fece un cenno con la testa di seguirla. Ubbidii, mentre lei si rivolgeva con un sorriso alle persone rimaste in palestra: «Tranquilli bimbi, ci penso io a lui.»
«Elsa, di’ al tu omo che c’è da fa’ l’ordine per la braciata!» Rispose Jolly, quando ormai noi due eravamo già nel deposito delle barche. «Sì.» Con un sorriso sulle labbra e la faccia ancora arrossata per lo sforzo dell’allenamento, Aurora mi guardò: «Metto apposto e parliamo un po’.» Io annuii, mettendomi in disparte per lasciarla fare senza essere d'impiccio.
Si chinò a terra per posare i remi, così da avere le mani libere per poggiare l’imbarcazione sugli appositi sostenitori di metallo, rigorosamente imbottiti in modo da non sciuparla. Venne poi a raccogliere i remi da terra e li andò a sistemare nella rastrelliera posizionata in fondo al deposito, assieme a tutti gli altri. Quei movimenti non erano nulla di particolarmente speciale, ma il modo con cui venivano eseguiti rendeva facile intuire quanta premura e orgoglio nascondessero quei piccoli gesti.
Tornò da me, mentre si batteva le mani tra loro con un sorriso soddisfatto, senza però dimenticare una lieve carezza colma d'affetto allo scalmo della barca, quando le passò di fronte. «Allora, che cosa ci fai qui?»
«Sono venuto perché volevo sapere come mai Cam avesse abbandonato il canottaggio.» Lei tirò un sospiro profondo, fermandosi di fronte a me e guardando un attimo per terra. «Beh… È complicato.» Si grattò il sopracciglio, mentre la mano con cui aveva sfiorato il metallo ancora bagnato dall’acqua del fiume andava a poggiarsi sul fianco. Un altro sospiro e tornò a puntare i suoi occhi color miele nei miei. «Non sono certa di poterne parlare con te. Se avesse voluto, te lo avrebbe raccontato lei, non credi?»
«Capisco che puoi non fidarti di me, visto che la prima volta che ci siamo parlati ero a letto con la tua migliore amica con i postumi della sbornia del secolo…» Lei fece cenno con gli occhi come dire “eh, già”. Non mi lasciai distrarre e continuai, cercando di farle capire quanto fossi sincero in quel momento. «Io tengo davvero a Cam. Ci ho passato l’infanzia insieme, eravamo unitissimi. Voglio solo capirla, comprendere le ferite che il suo cuore ha incassato nel periodo in cui siamo stati lontani e aiutarla a guarire. Non puoi davvero aiutarmi?»
Restò in silenzio per qualche secondo abbondante, sicuramente stava valutando se rivelarmi davvero tutto o meno, in quanto era evidente che fosse un argomento sensibile. E, evidentemente, non solo per Camilla.
Alla fine mi guardò negli occhi e disse: «È una storia lunga, ci vorrà tempo per raccontartela dal principio.»
«Ho tutto il tempo del mondo, per Camilla.» Risposi io, senza pensarci un solo istante. Lei sorrise, quasi avessi dato la risposta corretta, facendomi cenno di seguirla. «Vieni, ti mostro il nostro mondo.»
Iniziò a raccontarmi tutto dal principio: da quando Camilla aveva varcato per la prima volta la porta di quella palestra, fino al giorno in cui aveva deciso che non vi avrebbe mai più messo piede.
Allora. Ora mi sfogo su Michelangelo e Leonardo, quindi chi non è interessato, ciao, ci vediamo al prossimo capitolo, se volete. Per tutti gli altri, preparatevi psicologicamente, grazie.
Prime due nozioni fondamentali. Michelangelo Buonarroti è un Genio Divino del Rinascimento. Leonardo Da Vinci è il Rinascimento.
Perché questo?
*elsi che si rende conto che solo per Michelangelo ha scritto più di una pagina di roba* Cazzo.
Okay, sono costretta a fare così. Io qui vi lascio il link e chi vuole se lo legge, non lo posso mettere come note e mi rifiuto di tagliare. È uscito di getto e così resterà. Meglio per voi, peggio per me, ma non posso davvero metterlo come note capitolo, è praticamente un capitolo a sé… 'Fanculo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 8
*** Pagina 7 ***
09/02/2021
Siccome ho notato che questo capitolo è stato... stressante (ma sì, diciamo così) per buona parte che l'ha letto e mi ha recensito in esterna (che ringrazio, tra l'altro, non vogliatemela a male bimbi, era un complimento e vi voglio tanto bene), ora voglio mettere una premessa. A parte che io avevo avvertito sin da subito che non sarebbe stata una storia tutta fiorellini e farfalline, ma comunque. Quanto segue è il capitolo più... traumatizzante (?) per Cam. A me non piace, quindi capisco che possa non piacere, però era un passo necessario che la ragazza doveva e ha dovuto fare, quindi nel racconto ci andava, punto. Avrei potuto trattarlo in maniera diversa, più... serena, se così si vuol dire? Sì. E sarebbe anche stato molto più facile scriverlo, perché sarebbe bastato usare la prospettiva di Arkin. Ma invece no. Questo per più motivi: primo fra tutti, il racconto è principalmente di Cam. Il secondo è che temi del genere hanno bisogno ogni tanto di... un certo evento che dia la "scossa", se così si vuol chiamare, per poterseli mettere una volta per tutte alle spalle e poter andare avanti.
Comunque, accennato quanto sopra, io vi dico che questo capitolo tratta della morte dell'ex allenatore di Cam e Aurora, e del "funerale" che Arkin ha deciso di farle attendere. Se volete, passate al prossimo, senza problemi. Io non me la prendo, giuro. Anche perché, come già detto, nemmeno a me piace quanto segue. E sì, è vero che è un passo necessario per la ragazza, ma non è che sia necessario leggerlo perché altrimenti non si capisce nulla di quel che accade poi... Semplicemente si nota più il cambio del personaggio di Camilla, o almeno spero... E' quello che ho provato a fare lol
Pagina 6.
«Ma tu guarda quei du' 'mbecilli in mezzo al lago. Che so' a fa', 'na gara di nuoto? Ma un lo sanno che tra un'ora s'ha da inizia' le batterie della Nazionale? Che li pigli' un remo, va', coglioni...»
«Sergio... Guarda che quei “du' 'mbecilli”, come li hai chiamati te, sono i tuoi due ragazzi del 2-.»
«...»
A Sergio.
“Un rumore familiare… È quello di… remoergometri?” Sbarrai gli occhi da dietro la benda che il mio amico mi aveva fatto indossare, mentre il cuore accellerava i battiti, terrorizzato. “No… Non è possibile… Lui… Non può conoscere questo posto… Però… Questo suono… Sono sicura…”
Lo presi per una manica con la mano libera e provai a chiedere, con voce tremante: «Arkin… cosa…»
«Aspetta, siamo quasi arrivati.» Mi interruppe lui, stringendo la presa dell'altra mia mano e dicendo, con voce accurata: «Attenta, adesso la discesa si fa ripida.»
Rimasi pietrificata al mio posto, incapace di muovermi di un solo altro passo. Se quelli che sentivo sotto le scarpe erano i sassolini di un ghiaino, se l'odore che sentivo era quella di erba bagnata… “Se c'è una discesa ripida, allora non mi ero sbagliata… Se quel rumore erano davvero remoergometri... Se sono davvero… No. No no no no no no no no…”
«Coraggio, non temere. Non ti lascerò cadere, ci sono io a sostenerti.» La sua voce era rassicurante, ma in quel momento non sarei riuscita a fare un solo passo nemmeno se avessi voluto. Potevo quasi vederlo, davanti a me, che mi offriva la mano con un sorriso in volto. Ma non ce la feci, era troppo per me, semplicemente troppo.
«Riportami a casa…» Il mio fu più un sussurro che altro, ma Arkin riuscì comunque a sentirmi benissimo.
«No.» Rispose lui, in modo secco.
«Non sto scherzando... Il gioco è bello quando dura poco, Arkin. Riportami a casa o ci torno da sola!» Feci per torgliermi la benda, ma le mie mani vennero bloccate a metà strada dalle sue.
«No, devi fare questa cosa. Ne hai bisogno.» Sentii il suo fiato fresco che sapeva di menta sulla pelle del volto, il calore del suo corpo che si era avvicinato. Alzai lo sguardo bendato, come gesto automatico, come potessi puntare i miei occhi nei suoi. Con voce tremante tanto da suonare estranea persino a me stessa, sussurrai: «Non voglio... ti prego... Portami a casa...»
Sarei scoppiata a piangere, se avessi avuto un cuore. Peccato che avessi appreso la verità, due anni prima: io non avevo nessun cuore. Ero una scatola vuota, capace solo di provare emozioni flebili e superficiali, sentimenti per i quali bastava un alito di vento leggero per spazzarli via senza che lasciassero traccia. Un essere incapace di piangere, anche quando aveva il petto trafitto da una lama che affondava sempre più a fondo, lacerando la pelle e i tessuti, tagliando il sangue, ma trovando al posto del cuore solo una pompa meccanica, completamente priva di sentimenti.
Cominciai a non riuscire più a controllare il mio stesso corpo, ritrovandomi a tremare visibilmente da capo a piedi, tanto che restare sulle gambe era diventato quasi impossibile. «Ti prego... Portami via da qui...» Aggiunsi, supplichevole.
Lo sentii sospirare pesantemente e, dopo qualche istante di silenzio, con tono arreso, disse: «E va bene...» Feci appena in tempo a tirare un sospiro di sollievo, che un paio di braccia mi presero per la vita e il secondo dopo mi ritrovai sulla spalla del mio amico, nemmeno fossi stata un sacco di patate. Iniziò poi, con mio sconcerto, a scendere per la ripida discesa asfaltata che conoscevo sin troppo bene. «Visto che tu non hai intenzione di muoverti, ti faccio muovere io.»
Al limite della sopportazione, iniziai a prenderlo a calci e pugni come meglio potevo, gridandogli contro che doveva mettermi a terra.
“Cristo, Dio, Buddha, Babbo Natale, Goku, Satana… Non mi importa chi, ma che qualcuno mi salvi! Vi preg…” Sentii il rumore del legno del pontile muoversi sotto i piedi di Arkin e zittii di colpo perfino i miei pensieri, pietrificandomi.
«Ora ti metto giù e ti tolgo la benda, okay?» Domandò con tono dolce, aspettando immobile per pochi secondi, forse per fare in modo che il piccolo pontile placasse il proprio ondeggiamento leggero.
«No...» Sussurrai appena. L'istante successivo, ero con tutte le mie forze aggrappata a Arkin che gridavo: «No! Non voglio scendere! Non voglio toccare nulla, non voglio vedere nulla! Portami subito via da qui!» Sapevo benissimo di essere ridicola, ma non mi importava. Quel giorno di due anni prima avevo giurato a me stessa che non sarei più andata in quel posto, che non avrei più guardato l'acqua di un fiume o di un lago, che non avrei mai più sfiorato un remo o una barca.
«Mi spiace stjerne, lo faccio per il tuo bene.» Sussurrò dolcemente, ma con tono fermo, facendomi scendere dalla sua spalla.
«Se tu ci tenessi al mio bene, allora mi porteresti via da q...» Non appena le mie scarpe sfiorarono le assi di legno del pontile semimobile, il cuore smise di battere. Non so se fosse possibile, ma tremai ancora più di quanto non avessi fatto fino a quel momento. Incapace di reggermi in piedi, mi aggrappai al mio amico, stringendo la sua maglietta tra le mani in modo insano e nascondendo il volto nel suo petto.
Non riuscivo a pensare nemmeno di voler andare via, in quel momento la mia mente era in totale blackout.
Dopo non so quanto, le dita di Arkin mi sfiorarono la nuca, iniziando a sciogliere il nodo che mi teneva la benda sugli occhi. Strinsi le palpebre prima che potesse liberarmi lo sguardo, in modo da non vedere nulla, tenendo il volto sempre il più nascosto possibile sul suo petto.
«Cam, apri gli occhi...»
Scossi il capo, in segno di negazione, gli occhi strizzati più che potevo e le sopracciglia che facevano male da quanto corrucciate.
«Stjerne, apri gli occhi e dammi le mani. Devo darti una cosa importante.»
Non avevo idea di che cosa stesse parlando, ma non mi importava nemmeno. In quel momento tutto il mio impegno era nell'evitare alla mia memoria di mostrarmi immagini del passato che mi avrebbero solo fatto soffrire, nonché andarmene da quel luogo il prima possibile, il più velocemente possibile; e non tornarci mai più, stavolta per davvero.
Arkin mi prese il volto tra le mani, alzandomelo appena. Si sciolse poi dalla mia presa e andò a posizionarsi dietro di me, parlandomi con tono dolce: «Stjerne, lo so che è difficile... Lo so che vorresti essere in qualunque altro posto che qui... Ma hai davvero bisogno di affrontare questa cosa e io non posso più permetterti di scappare.» Si allontanò un breve istante, per poi avvolgermi in un tenero abbraccio da dietro, poggiando la testa sulla mia spalla. Intrecciò le dita della sua mano destra con quelle tremanti della mia, sussurrandomi all'orecchio: «Sono al tuo fianco, non ti lascio sola. Però adesso, ti prego, apri gli occhi.»
Scossi ancora la testa, tentando di voltarmi dall'altra parte, ma lui me lo impedì. «Ti fidi di me?»
«No.» Risposi seccamente, quasi non riuscendo a credere che avesse avuto davvero la faccia tosta di chiedermelo. Come potevo fidarmi di lui dopo che mi aveva portata in quel posto? Ad affrontare i miei demoni? Era tanto sbagliato non volerli combattere? Ero vissuta tanto convivendo con loro e facendo finta che non esistessero, perché mai avrei dovuto cambiare? Tanto tutti hanno dei problemi, quindi che differenza facevano quelli degli altri dai miei? Loro con i problemi ci campavano, perché io non potevo?
Lo percepii trattenere un moto di stizza, fare un sospiro profondo per calmarsi e, alla fine, sussurrarmi nell'orecchio con tono tranquillo, mentre stringeva la presa sulla mia mano: «Vær så snill, min lille stjerne. For meg også. (Per favore, mia piccola stella. Anche per me.)»
Non so in quel momento cosa mi convinse davvero. Era vero che da quando ero stata a casa sua avevo iniziato a studiare il norvegese, ma in quel momento non capii assolutamente nulla di quello che mi disse. Nemmeno la parola “stella”. Non so perché riuscì a convincermi, forse era semplicemente il tono con cui aveva parlato, fatto sta che aprii gli occhi e, non appena lo vidi, non riuscii più a richiuderli.
Erano anni che non guardavo il mio fiume da quella prospettiva e quella vista mi fece tanto male che non riuscii più a respirare.
Dopo un tempo che potevano essere pochi secondi come interi anni, mi accorsi di ciò che teneva Arkin nella mano libera: una lanterna di carta bianca, di quelle usate durante le feste di capodanno. Il mio amico tirò fuori un accendino e fece prendere fuoco alla candela rossa, per poi posizionarla al suo interno e mettermela tra le mani.
«Devi immaginarti che la fiamma che brucia all’interno di questa lanterna sia la sua anima.» Sussurrò Arkin alle mie spalle, con un sorriso che vidi con la coda dell'occhio. «Quando ti sentirai pronta a separarti da lui, devi lasciarla volare via e dirgli addio.»
Strinsi un poco la presa sulla carta che avevo tra le mani, immaginandomi davvero che nello spazio all’interno di quelle pareti fragili e sottili ci fosse la sua anima.
La candela era arrivata a metà, quando riuscii a lasciar andare la lanterna, osservandola mentre si alzava in cielo e spariva nella volta celeste.
Quando ormai non si vide più nulla, Arkin parlò: «Non avevo davvero idea di come riuscire a fare un saluto del genere... Alla fine mi è venuto in mente che le torce di carta possono essere simili, in qualche strano mondo parallelo, a delle anime che salgono nel cielo... Ho proposto l'idea ai ragazzi della palestra e mi hanno dato il permesso di “noleggiare” pontile e fiume, anche grazie all’aiuto di Aurora, restando ad allenarsi sul remoergometro. Per fortuna che nessun pesce ha rovinato l’atmosfera, visto i mostri che si nascondono in quest'acqua... Ma sul serio voi ci facevate il bagno, spontaneamente, d'est...» Fermò la propria parlantina quando mi girai e gli circondai il dorso con le braccia, sempre in silenzio.
Mentre nascondevo per l'ennesima volta in quella giornata il volto sul suo petto, lo percepii circondarmi la schiena e accarezzarmi i capelli con la mano libera, restando anche lui in silenzio.
Mi diede un bacio leggero sulla nuca, prima di iniziare a parlare con tono basso e serio, quasi preoccupato: «Mi hanno raccontato molto di lui... Ho capito che è stato una persona fenomale. Solo un uomo fenomenale può riuscire a farsi amare tanto da un intero gruppo di ragazze e ragazzi contro le cui schiene ha spaccato più bastoni. Per non parlare di quando ha preso quei due a sassate...»
“Però poi la gara l'hanno vinta...” Mi scappò un sorriso triste, ricordando anche la fine dell'ultima “arma”. «Lo faceva solo per il nostro bene... E in caso estremo... E solo ai ragazzi più grandi e che erano in grado di sopportarlo... A tutti noi è sempre andato più che bene così...»
«Lo so...» Un altro piccolo bacio sulla nuca, appena dopo il passaggio della carezza leggera. «E so anche quanto gli hai voluto bene te, quanto ti ha aiutato e quanto sei stata male. Ma, Cam, sono passati due anni... E tu ti sei privata di ciò che amavi più al mondo... So che ti allenavi minimo due volte al giorno, tutti i giorni. So che davi tutta te stessa sia in allenamento che nelle gare, che sorridevi sempre, che potevi stare ore a parlare di canottaggio e giorni ad ascoltare storie e aneddoti vari dei più grandi. So che saresti dovuta entrare a far parte delle Fiamme Oro, che miravi a gareggiare con Aurora alle prossime Olimpiadi. Come hai potuto permettere che ti portassero via tutto questo? Che ti portassero via la tua stessa gioia? Cos'è successo?»
Silenzio.
Non ebbi il coraggio di rispondere. In realtà, non sapevo proprio cosa rispondere. Quelle che mi stava porgendo Arkin in quel momento erano le stesse domande che mi porgevo io dalla bellezza di tre anni e mezzo. Il fatto era che il mio crollo psicologico era iniziato prima della morte del mio allenatore, pressapoco con la fine delle superiori ad essere onesta, e quest'ultima perdita era stata solo la fantomatica goccia che faceva traboccare il vaso.
Avrei davvero voluto rispondergli, perché avrei davvero voluto avere una risposta a quei quesiti, ma non ce l'avevo. Strinsi allora di più Arkin nel mio abbraccio, nascondendo ancor di più il volto.
Silenzio, per non seppi quanto. Sapevo solo che iniziò a salire l'aria fredda della sera.
«Ho un'altra cosa da chiederti, prima di riportarti a casa.» Disse Arkin, di punto in bianco. Poggiò le labbra per qualche lungo secondo sulla mia nuca un'ultima volta, prima di distanziarsi da me e alzarmi il volto in modo da guardarmi negli occhi. I suoi zaffiri erano profondi, penetranti e, così come la sua voce, terribilmente seri: «Devi dire “Sergio è morto”.»
Carogna.
Era l'unico modo con cui lo potevo descrivere in quel momento. Una carogna della peggior specie. Lui sapeva benissimo che non avevo mai accettato la sua morte, sapeva benissimo che mi ero sempre rifiutata di accettarla e che per questo mi ero categoricamente espulsa definitivamente dal mondo che poteva ricordarmi che non era più in vita.
Non avevo mai detto quella frase, mai una volta. Mi ero persino impedita di pensarla, per timore che potesse in qualche modo diventare realtà. Volevo vivere in un mondo dove quella frase non aveva nessun senso, così come non lo aveva per me dalla prima volta che l'avevo udita. Volevo che continuasse a vivere, che quel dannato animaletto marino color del fuoco non fosse mai riuscito a frantumare con le sue chele quell'impenetrabile scoglio. Il mio era davvero un sentimento così sbagliato?
Scossi la testa, sostenendo a fatica lo sguardo di Arkin, più perché incapace di distogliere gli occhi che non volerlo fare.
«Dillo. Sergio è morto. È la verità e la devi accettare.»
“No, inutile. Puoi ripeterlo all'infinito, tu e chiunque altro. Non ci crederò mai.”
«Sergio è morto.»
“Non è vero. Non può essere morto. È un'assurdità. Non sta né in cielo né in terra.”
«Sergio è morto.»
“È solo una bugia, una bugia cattiva. Non è vero. Si è solo addormentato... Tutti sanno com'è fatto, si addormenta mentre ancora sta parlando. È solo stanco, ma tra poco si sveglia. E allora tu e tutti quelli che hanno insinuato una tale menzogna, dovrete ricredervi.”
«Sergio è morto.»
“No... Non è vero... Devo continuare a credere con tutta me stessa che non sia vero... In questo modo... Forse... Forse se ci credo con tutta me stessa, riesco ancora a cambiare la realtà... Forse...”
«Sergio è morto.»
“Forse proprio nulla... Lui... Lui davvero non c'è più... E io sono un mostro... Solo un mostro...”
«Sergio è morto.»
“Non ho versato nemmeno una lacrima per lui, sono un mostro senza cuore...”
«Ser...gio... è... mor...to...» Dissi alla fine, con voce tremante talmente alienata dal dolore che sembrava non appartenermi nemmeno.
Da quando avevo iniziato a piangere? Non ne avevo idea, nemmeno mi importava. Non riuscii ancora a pensare lucidamente che mi trovai a piangere disperata come una bimba sul petto di Arkin, ridotta in ginocchio sul pontile di legno davanti alla scarpiera vuota e al catamarano. Piansi per non so quanto, piansi lacrime che non sapevo nemmeno di possedere tanto erano dolorose. Esplosi, semplicemente.
Quando riuscii a calmarmi, ormai la Luna era alta nel cielo notturno, circondata dalle sue damigelle brillanti. Arkin era rimasto tutto il tempo ad abbracciarmi, accarezzarmi i capelli e sussurrarmi all'orecchio che andava tutto bene, che potevo finalmente essere libera da quel peso che mi ero portata dentro per anni, che lì non c'era nessuno e che non dovevo nascondere le mie lacrime né la mia sofferenza, perché eravamo solo noi due.
Rientrammo in macchina, restando in silenzio e il mio amico imboccò la strada che portava a casa di mia madre, mentre io non riuscivo a distogliere gli occhi dal cielo notturno.
Quando eravamo ormai a metà strada, la mia voce tremante ruppe il silenzio rispettoso che vi era tra noi: «Sorrideva…»
Percepii lo sguardo confuso di Arkin su di me, feci un profondo respiro e, non distogliendo gli occhi dal cielo stellato che vedevo oltre al finestrino della macchina, spiegai con voce tremante: «L’ultima volta che l’ho visto… È stato alla braciata societaria di due anni fa, pochi giorni prima che morisse… E Sergio stava sorridendo. Rideva e scherzava… Ero felice… Anche se si stava prendendo gioco di me…» Un sorriso, che era da anni che non riuscivo a fare pensando al mio allenatore, si dipinse senza fatica né rimorso sulle mie labbra. «Sono contenta che questo sia l’ultimo ricordo che ho di lui in vita.»
|
Ritorna all'indice
Capitolo 9
*** Pagina 8 ***
Pagina 8.
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'.
E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
Da quando sei partito c'è una grossa novità,
l'anno vecchio è finito ormai
ma qualcosa ancora qui non va.
– L'anno che verrà, Lucio Dalla
«Mmmh… Non sono molto sicuro di questa cosa…»
«Andiamo, Arkin, lo stiamo facendo per Paolo. È importante.»
«Ma proprio stanotte dovevamo venire?»
«Quale notte migliore c’è di Halloween per parlare coi morti, scusa?»
Avevo guardato il mio amico che camminava pochi passi avanti a me. Paolo aveva lo sguardo puntato in avanti e il volto inespressivo, mentre procedeva con sicurezza verso il cimitero, appena fuori dal paese. Aveva da pochi giorni perso sua nonna e, visto la vicinanza con quella festa, avevamo deciso di provare a entrare in contatto con lei. Ci eravamo quindi vestiti per festeggiare halloween e avevamo detto che uscivamo a fare dolcetto e scherzetto.
Eravamo usciti da soli, senza accompagnatori nonostante la nostra età: eravamo stati abbastanza furbi da fare in modo di essere a casa mia e aspettare il momento propizio della serata in cui solo mio padre avrebbe potuto accompagnarci e… Beh, era semplicemente impossibile che accettasse di venire fuori con noi a fare una cosa infantile come dolcetto e scherzetto.
Era stato così che un pirata, un cavaliere medievale e una pellerossa, attraversavano il paese al calar del sole e arrivavano fino al cancello del cimitero.
«Eccoci qui…» Avevo sussurrato all’entrata, osservando il metallo. Un brivido mi aveva attraversato la schiena e avevo stretto istintivamente l’impugnatura dell’arco che avevo a spalla.
«E ora come facciamo a entrare?» Aveva chiesto Arkin, guardandosi scettico intorno. Io avevo storto la bocca, pensierosa: in effetti, era un punto a cui non avevamo pensato. Non avevo fatto in tempo a proporre nessuna idea, che Paolo si era avvicinato al cancello alto poco più di un adulto e aveva messo un piede in uno dei buchi che la struttura arzigogolata offriva, usandolo come appoggio. Si era voltato poi verso di noi e ci aveva detto, semplicemente, con una mano già stretta al ferro: «Lo scavalchiamo.» In silenzio e senza aspettarci, si era poi issato e nel giro di poco era già dall’altra parte. Io e Arkin lo avevamo seguito senza troppi problemi, nonostante la spada di lui e il mio arco e frecce fossero state un po’ di intralcio.
Ci eravamo diretti verso la cappella del mio amico, Paolo aveva tirato fuori le chiavi da una tasca del costume e aveva aperto, permettendoci di entrare nel santuario della sua famiglia. Ci eravamo seduti a terra, il marmo ghiaccio contro le schiene, di fronte alla tomba che portava su di sé la foto dell’anziana signora.
«Questo posto è inquietante…» Aveva sussurrato Arkin, ricevendo un mio scappellotto di conseguenza. «Porta un po’ di rispetto, scemo.» Lo avevo ripreso a bassa voce, mentre lui si massaggiava la nuca scoperta, visto che si era tolto il cappuccio di finta cotta di maglia appena eravamo entrati lì dentro.
Ignorandolo, avevo lanciato uno sguardo alla schiena di Paolo, in piedi di fronte a noi. Si era tolto il cappello da pirata ed era restato immobile a osservare la foto della nonna da quando avevamo varcato la soglia della cappella, in volto una maschera inespressiva che aveva indossato sempre negli ultimi giorni.
Eravamo andati lì perché lui potesse vedere il fantasma della nonna, ma dopo un paio d’ore e l’aumentare del freddo le mie speranze di poter davvero vedere un fantasma si erano andate a far benedire. Rannicchiata al fianco di Arkin per cercare di scaldarmi sfruttando il suo calore, continuavo a fissare con espressione sempre più triste la schiena del mio amico, ancora immobile di fronte a noi.
Di colpo, quando ormai stavo per addormentarmi, avevo visto Paolo sfiorare con una carezza la foto della nonna e rimettersi il cappello del costume. «Addio nonnina…» Aveva sussurrato flebile, voltandosi poi con un sorriso raggiante dei suoi e dire, pieno d’entusiasmo: «Solo io inizio ad avere freddo? Dai, torniamo a casa!» Si era poi diretto all’uscita e aveva riaperto la porta della cappella, aspettandoci con un sorriso. Prima di alzarci, io e Arkin ci eravamo scambiati uno sguardo che valeva più di qualsiasi parola potessimo pronunciare: Paolo aveva le guance percorse da numerose linee di sale, tracce secche delle lacrime che, in silenzio, aveva versato per tutto il tempo. Senza dire nulla, però, ci eravamo alzati dall’angolino di marmo ormai non più così freddo ed eravamo usciti dal cimitero, percorrendo la via di casa in silenzio, con il sorriso di Paolo che era tornato al suo posto sulle piccole labbra.
Durante la marcia però, Arkin si era fermato e ci aveva chiesto se avessimo dei soldi con noi. Ai nostri sguardi confusi, il mezzo norvegese aveva indicato il supermercato alle sue spalle, il quale aveva deciso di fare apertura fino a tardi, affermando: «Io non ho punta voglia di fare dolcetto e scherzetto, ma se rientriamo senza nulla non sarà puzzosa per gli adulti?»
Paolo si era messo a cercare nelle tasche, ma io avevo già tirato fuori cinque fogli da mille lire. «Con queste qualcosa lo ricaviamo, no?» Avevo chiesto, mostrando loro la faccia di Maria Montessori.
«Fisherman’s!» Aveva esclamato Arkin, con gli occhi che già scintillavano. Giusto un istante prima che potesse togliermi le banconote di mano, Paolo lo precedette, mettendole al sicuro nella tasca della sua giacca: «Niente da fare, dobbiamo prendere qualcosa di più piccolo, in modo da prenderne tanti diversi.» Si era diretto poi verso l’interno del negozio e, prima di aprire la porta, si era voltato verso di noi con un sorriso e ci aveva detto: «Haribo e Goleador, che ne dite?»
«Sì! Orsetti! Orsetti!» Avevo trillato io, mentre lo raggiungevo saltellando felice, mentre Arkin già sorrideva per i Goleador.
“Sempre gentile e altruista, il mio Paolo…” Sfiorai con una carezza il freddo del marmo della tomba, accanto alla foto che ritraeva il mio amico. Sorrideva, in foto. Sorrideva sempre, lui.
«La notte prima di sentirsi male… di morire, Paolo mi disse che ti aveva sognata.»
Mi voltai verso Arkin, che si trovava un passo dietro di me, i suoi occhi fissi in quelli della foto del nostro vecchio amico. «Mi disse che voleva ritrovarti, che l’amicizia di noi tre gli mancava… Mi fece promettere che, se avessimo vinto la coppa, allora ti saremo venuti a cercare e saremmo tornati a essere felici come da piccoli.»
Abbassai il capo, le lacrime caddero sulle mie braccia, avvolte attorno al ventre, e sul marmo ai miei piedi. Avrei voluto dire qualcosa, ma il nodo alla gola me lo impedì.
Arkin fece un passo avanti, poggiò la fronte e la mano chiusa a pugno sul marmo gelido della tomba. «Non so nemmeno io quante volte ho preso a pugni questa bara, sperando in una risposta…» Chiuse gli occhi, con rabbia. «Ma è sempre stato zitto.»
L'istinto mi disse di alzare lo sguardo, e le vidi. Quelle gemme, quegli zaffiri, stavano piangendo. Non seppi dire perché, ma quella visione mi si incise nel cuore, la trovavo meravigliosa.
“Sono… un mostro? Il mio amico soffre e io… lo trovo bellissimo…”
«Però.» La sua voce mi distolse dai miei pensieri, facendomi cacciare il senso di colpa. «Ora ti ho ritrovata…» La mano si aprì e il braccio si tese, facendo allontanare il volto dal materiale gelido. Arkin si voltò verso di me, regalandomi un’espressione di pace, di realizzazione, che non credevo potesse esistere. «Sono davvero felice, perché ho realizzato il suo ultimo desiderio.»
Distolse di colpo lo sguardo, si asciugò le lacrime con l’avambraccio e si diresse verso l’uscita. «Andiamo?»
Rimasi un attimo paralizzata al mio posto, incapace di muovermi. “No, non sono un mostro… Io… voglio conoscere di più di questo Arkin… Voglio conoscere di più su di lui, sui suoi sentimenti…” Mi osservai i palmi delle mani, meditabonda. Era strano, avevo voglia di dipingere. Dopo anni, avevo voglia di prendere in mano pennello e colori, trasmettere su tela quelle emozioni che stavo provando. Una parte di me sapeva che non sarebbe riuscita a dormire quella notte, se non avessi tirato fuori il cavalletto e non mi fossi sfogata.
Sentii battere due leggeri colpi sull’inferiata che dava l’accesso alla tomba di Paolo: era Arkin, che mi aspettava sulla soglia. Si voltò appena e mi fece cenno di seguirlo. Mi voltai un’ultima volta verso la foto del mio amico e sussurrai: «Grazie…»
Mi feci il segno della croce, baciando il lato dell’indice a gesto concluso e dirigendomi all’uscita camminando all’indietro; da bambina mi stata insegnato di uscire di Chiesa in quel modo, perché era irrespettoso dare le spalle al crocifisso, io lo pensavo anche per le cappelle.
Una volta fuori dal cancello del cimitero, entrambi ci fermammo dopo pochi passi.
Fui io a rompere il silenzio. «Ti ringrazio.»
Arkin mi guardò interrogativo, io gli sorrisi: «Per avermi portato da Paolo. Non credevo, ma ne avevo bisogno.»
«Sì beh… Era da un po’ che non lo andavo a trovare… Ha fatto bene anche a me.» Sussurrò, dando un calcio al terreno.
«Senti, ti offro un gel…» Mi interruppi, le mani sulle tasche dei jeans stranamente piatte. “Il portafoglio… L'ho lasciato sulla scrivania da mamma! Ma che cavolo!”
«Tutto okay?» Gli occhi interrogativi di Arkin mi scrutano per un attimo, facendo aumentare il rossore sul mio viso in modo esponenziale.
Stavo per aprire bocca per una qualsiasi giustificazione, quando il rumore dell’elicottero che sorvolò le nostre teste ci fece alzare lo sguardo.
«Che succede?» Sussurrai, seguendo il volo del veicolo, che si dirigeva verso il centro del paese.
«Deve aver preso fuoco qualcosa… È un elicottero antincendio.»
«Pensi che abbia preso fuoco qualcosa in paese?» Non riuscii a nascondere il nervosismo nella voce, quando le voci di un paio di signori anziani alle nostre spalle mi fece gelare il sangue nelle vene.
«Di’ono che gl’è esplosa ‘na bombola del gas al barre.»
«Mh. L’esplosione un gl’è stata troppo soda, ma l’ha dato foo alla valle.»
“La valle… Se prende fuoco, casa di mamma rimarrà in un vicolo cieco…” In quel momento, in casa non c'era nessuno. Ma c'era una cosa che dovevo a tutti i costi salvare, che non potevo in alcun modo rischiare di perdere. Non doveva esserci nemmeno lo 0,01% di possibilità che potesse abbracciare le fiamme.
Il mio corpo si mosse prima che la mente potesse ragionare, facendo muovere le gambe come nemmeno se in pericolo ci fosse la mia vita.
Vidi Camilla scattare come un razzo, dirigendosi verso il paese, verso il fuoco. Provai a chiamarla, ma non mi rispose. Probabilmente, non mi aveva nemmeno sentito. Le corsi dietro, ma era troppo veloce per me. E io ero decisamente fuori allenamento. “Dannazione… Ma che le è saltato in mente…”
Mentre cercavo di riprendere fiato, mi si accese una lampadina: casa di sua madre. “È impazzita, se la valle ha preso fuoco, sta andando dentro a una conca di fiamme!” Mi guardai un attimo intorno, e mi venne in mente una scorciatoia. Tagliando per i campi di girasoli, anziché fare il giro lungo per il centro del paese, sicuramente avrei fatto prima.
Quando arrivai all’imbocco della via, la vidi che saliva a corsa le scale esterne di quella che un tempo era stata casa di suo nonno.
“Ma che… Quella non è casa di sua madre.” Le andai dietro, sentendo le grida della gente che se la stava rifacendo con lei per non so quale motivo. Provai a chiamarla, ma non ottenni risposta. Salii le scale e seguii le voci a me estranee, gli insulti che volavano e che mi facevano calare un velo rosso davanti agli occhi, finché non la intravidi: stava sorreggendo una vecchia zoppa, aiutandola a stare in piedi, quando una donna la spinse via, strappandole l’anziana e facendola risedere sul letto.
«La prossima volta, e in cuor mio spero tanto ci sarà, io non muoverò un ciglio per aiutarvi, né tantomeno avvertirvi.» Alzai lo sguardo, guardando negli occhi coloro che consideravo la feccia peggiore della Terra, ma che, nonostante tutto, avevo accettato ad aiutare per il bene di mia madre. Perché lei, nonostante tutto quello che le avevano fatto, li considerava ancora parte della sua famiglia. «Sarò più che felice se le fiamme vi bruceranno anche l’anima che non avete.» Lo schiaffo arrivò quasi atteso, ma non mi importava. Ciò che avevo detto era la pura verità. E quella gente non poteva farmi più male di quel che aveva già fatto.
Ciò che non era atteso, era la reazione di Arkin. Si frappose fra me e l'uomo, stringendo il polso della mano che mi aveva colpita con tanta forza da bloccarne probabilmente la circolazione. «Osa solo avvicinarti a lei a meno di tre metri e giuro su quanto di più caro ho a questo mondo che sei un uomo finito.»
Arkin faceva paura da arrabbiato. Era massiccio, ma non era solo quello. Gli occhi gli diventavano come le acque dei fondali marini, i tendini si gonfiavano tanto che parevano voler esplodere. E, cosa ancora più importante, le sue minacce non erano mai a vuoto.
Mi prese delicatamente per mano e mi accompagnò fuori da quella casa. Appena allontanatici di qualche passo, si voltò verso di me e mi tastò delicatamente la guancia percossa, che riportava il segno evidente della manata. «Andiamo a prendere un po’ di ghiaccio, okay?»
«No.» Risposi, prima ancora di guardarlo negli occhi. Poggiai la mano sulla sua, ancora a sfiorarmi il volto, e lasciai che la determinazione che avevo fosse lampante nella mia voce e nel mio sguardo. «Voglio andare in paese, voglio aiutare la gente a domare le fiamme.»
«Ci sono i pompieri per questo.» Cercò di ribattere lui. Io scossi la testa, decisa: «E sono d'accordo a lasciare il grosso del lavoro a loro, ma ci sono anche piccoli fuochi che si accendono qua e là. Conosci anche tu il paese, è pieno di persone anziane. I pompieri devono fermare l'incendio maggiore, non possono tenere d'occhio anche tutti i fuocherelli più piccoli che scoppiano qua e là, nei giardini della gente, portati da questo vento.»
Rimase un attimo in silenzio, mi scostai dal suo tocco e mi avviai verso il paese, stringendo nella mano il mio portafoglio, ciò che ero tornata a prendere. «Non ti ho chiesto di venire con me. Ti ho solo detto ciò che ho intenzione di fare, tu esci da questa conca, mi basta questo.»
Presi a correre e, tempo zero, me lo ritrovai al fianco. «Te lo scordi che ti lascio andare da sola.»
«Hai detto delle cose parecchio pesanti, lo sai.» Mi disse, passandomi la bottiglietta d'acqua fresca. Era ormai il tramonto, l'incendio era stato quasi completamente domato e la situazione era sotto controllo grazie alle linee tagliafuoco e gli elicotteri. Io e Arkin ci stavamo godendo un poco di riposo, seduti sul muretto dell'ultima casa cui abitanti avevamo dato una mano. Alla fine dei conti non avevamo fatto chissà che, solo aiutato a spegnere un paio di fuocherelli sparsi qua e là e tranquillizzato qualche nonnina. Ciononostante, mi sentivo bene e soddisfatta di aver dato, seppur nel mio piccolo, una mano, per quanto inutile essa potesse essere stata.
Avevo, in fin dei conti passato una bella giornata, soddisfacente. Quindi perché ora Arkin voleva rovinarmela parlandomi di quella gente?
«Non ho detto nulla che non fosse vero.» Mi sfiorai leggermente la guancia, ancora leggermente arrossata e mi parve di sentirla ricominciare a pulsare. «Quella gente merita il peggio che c’è nel mondo.» Sussurrai a denti stretti, sentendo l'ira tornare ad attorcigliarmi lo stomaco. Lui mi guardò con un misto di pietà e sorpresa; percepii che stesse per ribattere, ma il mio sguardo assassino bastò come muto cenno per zittirlo.
Uno dei più grandi difetti di Cam, se non il peggiore, era che era una persona estremamente vendicativa, ma selettiva. La sua ira non era mai infondata e non era mai indirizzata a un torto che aveva subito lei in prima persona. Il peggio di sé lo tirava fuori quando si osava toccare persone a cui lei teneva, valori che le erano cari. C’era poco su questa Terra che potesse farle scattare un rancore tale, la forma di odio per eccellenza: ferire, sia a parole che a gesti, una persona a cui voleva particolarmente bene, distruggere quello che lei chiamava il suo “patrimonio”, ovvero le forme d’arte, storia e la cultura italiana, oppure infrangerle davanti agli occhi uno dei valori nei quali credeva di più, come l’onestà. Erano sempre stati questi i tre pilastri della sua vita e, se qualcuno osava anche solo smuoverli, Cam mostrava il lato peggiore di sé.
Era capace di nutrire rancore per anni e anni, lasciare che l’ira prendesse il controllo di ogni più piccola sua azione o pensiero, ma, almeno questo, non avrebbe mai fatto del male a chi non era l’artefice stesso di quel sentimento. Quella stessa scintilla, però, era anche in grado di tramutarsi e darle una forza e una tenacia fuori dal comune. Se impegnava quel fuoco interiore in qualcosa di positivo, non c’era nulla che non potesse riuscire a fare. Ma, allo stesso tempo, se lo impegnava in qualcosa di negativo, c’era seriamente da preoccuparsi per la vita di chi l’aveva aizzata e alimentata.
Non ho mai creduto sarebbe arrivata ad uccidere in prima persona, quello no. Ma allo stesso tempo non dubitavo che, se si fosse realmente ripresentata la disgrazia di un incendio e quelle persone, che le avevano evidentemente fatto un torto per lei imperdonabile, si fossero ritrovate intrappolate in casa, lei sarebbe stata immobile, senza muovere un dito, a bearsi delle fiamme che facevano il lavoro per lei.
Quel pensiero, quella certezza, mi fece avere paura della mia amica, di ciò che sarebbe potuta diventare. “Non te lo posso permettere.” L'odio e la rabbia erano ancora palpitanti nel suo sguardo, tanto forti che avrebbero potuto incenerire una persona semplicemente con un'occhiata. Non mi piaceva. Quei sentimenti negativi così forti erano pericolosi, deturpavano il multicolor dei suoi magnifici occhi.
«Odio quella gente, vorrei che sparisse da questo mondo, cancellare tutto ciò che sono e hanno fatto. Far dissolvere nel nulla la loro stessa esistenza.» Lo sguardo di Cam si posò sulle mani, intrecciate sulle gambe, le nocche bianche. «Ma non prima di averli fatti soffrire. Devono patire le pene dell'inferno, prima di svanire nel nulla.» Per un istante, ebbi davvero paura che Cam potesse fare qualcosa di orribile.
Posai una mano sulle sue, sentendone la presa alleggerirsi appena. Non sapevo cosa dire, perciò rimasi in silenzio. Le avvolsi un braccio attorno alle spalle e la abbracciai.
Non avevo mai percepito quel corpo così teso. Solo dopo alcuni minuti la sentii iniziare a rilassarsi. Si scostò da me quel tanto che bastava per guardarmi negli occhi e mi sorrise, semplicemente. Le sue iridi erano tornate normali, e ciò era più che sufficiente. Le sfiorai la fronte con la mia, mantenendo il confortevole silenzio e immergendomi in quelle iridi tornate limpide e pure, un braccio sempre a circondarle le spalle.
Cam aprì la bocca per dire qualcosa, ma la nonnina alle nostre spalle la interruppe: «Che begli sposini che siete, bimbi!» Ci allontanammo l'uno dall'altra con quello che pareva un salto, voltandoci verso l’anziana signora. Cam tentò subito di precisare che eravamo solo amici e che lei aveva, evidentemente, frainteso tutto. “Anche se…” Un pensiero poco piacevole tornò a farsi prepotente nella mia mente, facendomi fermare dal terminare la frase nella mia testa.
«Non è vero, Arkin?»
Mi ero un attimo distratto e non ero certo di cosa avesse detto precisamente, ma mi ritrovai comunque a rispondere un pacato: «Mh. Sì.»
Cam sorrise raggiante alla vecchina, che ci guardò borbottando un debole, ma sincero, “che peccato però”.
“Già… Ma è meglio così.” La nonnina ci offrì dei biscotti fatti in casa e della spremuta di arancia per ringraziarci dell'aiuto contro le fiamme, Cam cercò di ribattere, ma… Beh, la vecchina era nonna e ho già esposto come funziona con le nonne, no? Ci invitò in casa, ma almeno quello riuscimmo ad evitarlo. Entrambi eravamo sudati, puzzavamo di fumo come delle ciminiere e le nostre scarpe non erano certo pulite, dopo tutta la cenere e l'acqua che avevano visto quel pomeriggio.
Ci ritrovammo perciò entrambi a mangiare degli ottimi biscotti al cioccolato con spremuta sul muretto di quella casa, chiacchierando di tutto e nulla, come fosse la cosa più spontanea del mondo.
“È il massimo a cui posso aspirare, per noi.”
Una volta finito lo spuntino, ringraziammo ancora la signora per quest'ultimo e tornai con Cam a casa di sua madre.
«Guarda che non c'è bisogno che mi fai da guardiano ora.» Disse lei in un sorriso, varcando il porticato.
«Sono o no il tuo skystangel?» Risposi io, a meno di un passo di distanza. Mentre attraversavamo il viale avevo lanciato occhiate fugaci al piano superiore dell'abitazione e avevo notato la sagoma dietro la finestra appena accostata. La persiana di quest'ultima era stata chiusa con forza non appena avevamo messo piede sul piazzale.
Arrivata davanti la porta di casa, Cam si voltò verso di me con una giravolta e mi mostrò il suo sorriso più sincero. «Sì, lo sei.»
Dio, quanto avrei davvero voluto esserlo.
Poggiai una mano sulla sua nuca e la avvicinai a me, sfiorandole appena la fronte con un lungo bacio. «Vi ser deg, lille stjerne.»
«Vi ser deg, skystangel.» Mi sorrise un'ultima volta ed entrò in casa, allorché mi diressi alla macchina. Durante il tragitto, mi morsi le labbra e vi sentii il sapore del fuoco, ma anche un vago sentore dolce. Mi ricordai del sogno di qualche notte prima e mi maledissi un'ulteriore volta. Con un sospiro frustrato detti una testata al volante, restando con la fronte poggiata su di esso. “Perché non riesco mai ad accontentarmi di quel che ho? Perché devo sempre volere di più da lei, dannazione…” Chiusi le palpebre, stanco. “Sono un completo imbecille.”
Il cellulare sul sedile del passeggero iniziò a squillare. Diedi un'occhiata veloce allo schermo illuminato e vidi il nome di Manuela. Mi venne spontaneo alzare gli occhi al cielo; spensi il telefono e girai le chiavi. Avevo bisogno di una lunga doccia.
Avevo ancora l'asciugamano a tamponarmi i capelli a mo’ di turbante, quando udii squillare il cellulare e vidi il numero di Arkin sullo schermo. Non feci in tempo a rispondere, né a richiamare, che mi arrivò il suo messaggio.



Non fece in tempo ad apparire la spunta blu, che il telefono squillò di nuovo. Prima che potessi anche solo dire “pronto”, la voce eccitata di Arkin arrivò nel mio orecchio: «Hai detto che sei appena uscita di doccia, vero? Quanto ti ci vuole per asciugarti i capelli e sistemarti?»
«Ehm… un… oretta? Più o meno, perché?»
«Tra quaranta minuti sono da te, non ti truccare e metti un bel vestito.»
«Che?»
«Mi piaci di più al naturale.»
«Aspetta un…»
«A tra poco!»
«Arkin!»
“Che hai in mente stavolta…”
Per chi non riuscisse a caricare le foto, la chat tra Cam e Arkin è la seguente:
Ti prego dimmi che non sei corsa di nuovo in mezzo alle fiamme. Non ne hai avuto abbastanza per oggi?
Per tua informazione, ero in doccia.
Mi sono lavata i capelli, e non ho sentito la chiamata
Che odore ha il tuo shampoo?
…?
Rispondi e basta.
Prova a indovinare, ragazzone. Sei tu quello che mi annusa sempre i capelli lol
Forse, ma sei tu il cane da tartufi.
Ah ah ah
Facciamo così: se indovini ti do un premio
Interessante. Che premio?
Esaudirò un tuo desiderio :)
...qualsiasi?
Certo! Se è qualcosa nelle mie possibilità, ovvio.
Oh tranquilla, lo è.
Dammi un minuto solo per pensare.
Hai tre possibilità
Il tempo scorre
tic tac tic tac
Tanto so che non indovinerai mai :3
Lime.
...come cazzo hai fatto.
Semplice. Sei sempre stata attratta dai profumi degli agrumi, anche se non ne mangi uno nemmeno sotto tortura. Ti sanno di freschezza.
._.
Bene, ora. La mia ricompensa 😏
Ti prego sii misericordioso…
|
Ritorna all'indice
Capitolo 10
*** Pagina 9 ***
Pagina 9.
(I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine.
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.)
Ti ho vista piangere, ti ho vista sorridere.
Ti ho vista dormire per un poco.
Sarei stato il padre dei tuoi figli.
Avrei passato una vita assieme a te.
Conosco le tue paure e tu conosci le mie.
Abbiamo avuto i nostri dubbi, ma ormai stiamo bene.
E ti amo, giuro che è vero.
Non posso vivere senza di te.
Addio mio amore.
Addio amica mia.
Sei stata l’unica.
Sei stata l’unica per me.
– Goodbye my lover, James Blunt
“Oh Signore…”
Cam uscì di casa in un vestito estivo, lungo fino alle caviglie color acquamarina, i capelli legati alla nuca, poche ciocche più corte dovute alla scalatura che le incorniciavano il volto e le sfioravano le spalle scoperte. Ero senza parole, era bella da togliere il fiato. Nemmeno Afrodite in persona avrebbe potuto reggere il confronto.
“Col cavolo che ti porto fuori, così…” Mi ero perso un attimo, quando Cam mi mosse la mano aperta davanti agli occhi per farmi tornare presente. «Beh? Che ne pensi, come sto?»
«Onestamente?»
Lei annuì.
«Sei così bella che vorrei chiuderti in una camera da letto e non permettere a nessun altro uomo di potersi rifare gli occhi col tuo splendore.»
Una risata le illuminò il volto. «E questa da dove viene, il manuale del playboy, dopo la tattica dell’usare il francese?» Mi sforzai di sorridere, lei mi superò e si diresse alla macchina.
Rimasi un attimo fermo, sussurrando a me stesso: «Io ero serio…» Mi portai una mano all’altezza del cuore, stringendo la maglietta, come se avessi così potuto farlo smettere di battere con tanta irruenza. “Vedi di darti una calmata, bimbo… Torna lucido, non puoi mandare tutto a puttane.”
«Arkin, allora andiamo?»
Riaprii gli occhi, voltandomi verso di lei e raggiungendola alla macchina. “È già il 18, vedi di darti una svegliata e godertela.”
«Sai, non mi hai ancora detto dove stiamo andando.» Dissi in un sorriso emozionato, mentre dondolavo appena le spalle, le ciocche dei capelli mossi che mi facevano piacevolmente un leggero solletico sulla pelle.
Arkin cambiò marcia senza staccare gli occhi dalla strada. «Un mio amico da una festicciola a casa sua stasera, volevo passare una serata con te e l’ho usata come scusa.»
“Mi vuoi presentare ai tuoi amici?” Non seppi perché, ma il pensiero mi riempì di gioia. Finché un altro non si fece spazio nella mia mente: «Ma, aspetta… e Manuela? Non dovresti andarci con lei a questa festa anziché con un’amica?»
Arkin si morse un attimo le labbra, imboccò la rotonda e non parlò finché non ne uscì. «Ci sarà anche Manu, ma lei ha la macchina e può andarci da sola.» Inspirò ed espirò a fondo, prima di continuare. «Tu no, quindi ti porto io.»
«Sei… sicuro che vada bene?»
Semaforo, arancione. La macchina si fermò e Arkin si voltò verso di me, senza guardarmi negli occhi. «Te l’ho detto…» Mi prese la mano nella sua e intrecciò le nostre dita. «Voglio passare la serata con te.»
«Arkin…» Strinse la presa delle nostre mani, non distogliendo gli occhi dalla nostra unione. «Sei sicuro di stare bene? Sei strano…»
Aveva uno sguardo turbato, sembrava si stesse trattenendo da qualcosa e che facesse una fatica immensa nel farlo. “Se non fosse già fidanzato, o non lo conoscessi… Potrei quasi pensare che…”
Arkin lasciò la presa della mia mano, tornando a guardare la strada. «Tranquilla, sto bene. Scusami.»
«Non devi scusarti…» Borbottai.
“Stai calmo, stai calmo, stai calmo, stai calmo, stai calmo, stai calmo… Più me lo ripeto e più mi agito, dannazione!”
«Arrivati.» Imboccai l’ultima curva e parcheggiai davanti casa di Francesco, già si sentiva la musica provenire dal giardino. «Vieni.» Porsi la mano verso Cam con un sorriso, lei la prese contraccambiando e ci dirigemmo verso il cancello dell’abitazione. Non feci in tempo ad arrivare a cinque passi, che Mirko ed Emanuele erano già all’entrata, per aprirmi.
«Che tempismo…» Sussurrai. «Mi avete sentito arrivare?»
«Abbiamo sentito le grida di guerra vichinghe.» Scherzò Ema, mentre apriva.
«Che ‘mbecille che tu’ sei…» Dissi, soffocando una risata. «Mi pare che le casse funzionino alla grande, Jack sarà entusiasta.»
«Già, si è messo alla console e non se ne stacca più.» Mi rispose Mirko. Mi voltai verso Cam, sorridendole: «Vieni, ti presento tutti. Andiamo in giardino, almeno non dovrò ripetere il tuo nome trenta volte.»
«Non ti piace il mio nome?» Un finto broncetto apparve sul volto della mia amica, mentre ci dirigevamo dal gruppo. La presi sottobraccio, per avere l’illusione che in quel modo avrei potuto tenermela vicina. «Io adoro il tuo nome, ma non mi piace che gli altri ti ronzino troppo intorno. Quindi ti presento una volta sola e poi tutti se ne tornano ai fatti loro e io ti ho tutta per me senza altre interruzioni.»
Non appena Giacomo mi vide, esclamò da dietro la stazione musicale: «Oh bimbi! È arrivato l’ospite d’onore! Un applauso!»
Mi si gelò il sangue nelle vene.
«Ospite d’onore? Non mi avevi detto che la festa era per te.» Mi chiese Cam, in un mezzo sorriso. Feci un gesto come per minimizzare la cosa. «Non ascoltarlo, è un imbecille. Sta solo scherzando.»
Presentai la mia amica alle venti e più persone che erano radunate nel giardino, senza perderla d’occhio mezzo secondo. In un angolo vidi che c’era anche Tommaso, seduto vicino a Manuela; furono gli unici che non si alzarono per venirci a salutare. “Poco importa. Anzi, meglio così.”
«Hey Camilla, che musica ti piace? Ti faccio scegliere la prossima canzone.» Chiese Giacomo, sempre da dietro la postazione. «Non credo davvero che tu abbia le mie canzoni preferite lì dentro.» Rispose lei, in un sorriso di sfida. Sfida che lui accettò al volo, facendole cenno di andare a vedere coi suoi occhi i titoli sul monitor.
La lasciai andare, sentendo per un breve istante una stretta al cuore. Abbassai lo sguardo, trattenendomi dal portare la mano al petto e limitandomi a stringere i pugni. “Va tutto bene…”
«Arkin, puoi venire un momento con me?» La voce glaciale di Manuela mi fece riaprire gli occhi. “No, non va affatto tutto bene.” Tirai un sospiro, senza staccare gli occhi da Camilla, la quale era evidentemente sorpresa di ciò che stava leggendo. «Quello che vuoi dirmi, puoi farlo anche qui.»
La sentii sbuffare, ma non mi importava proprio nulla. «E sia. Perché hai portato anche lei?»
«È una cena tra amici, più siamo, più ci si diverte.»
«Non prendermi per il culo, Arkin.» Manuela mi si parò davanti, riuscii a vedere sul suo volto, attraverso il trucco, tutto il suo disappunto. «Cosa provi in realtà per quella ragazza?»
Sentii l’eccitazione di Camilla mentre indicava il titolo che aveva scelto sul monitor e pregava Jack di riprodurlo, gli occhi che le brillavano come fosse una bimba di cinque anni davanti a un negozio di caramelle.
«Già. Lo immaginavo.» Manuela sbuffò, ma non la degnai di un ulteriore sguardo. Appena partì la musica, ero già di fronte a Cam che le offrivo la mano: «Mi concedi questo ballo?»
«Questa canzone non è ballabile.» Ribatté lei, divertita.
«Vuoi vedere che ti smentisco?» Risposi io in un sorriso, tendendo la mano verso di lei. Cam la prese e si lasciò condurre sul prato. Me la portai vicina, sfiorandole i fianchi con le mani, mentre lei poggiava le sue sulle mie spalle.
«Perché hai scelto una canzone d’addio?»
Lei alzò le spalle. «Mi andava di ascoltarla. E poi non è una canzone d'addio, è una che racconta di un amore immenso.»
Tirai un sorriso, le feci fare una giravolta e intrecciai le nostre mani, non riuscendo a staccare lo sguardo da quell’infinità di colori che erano le sue iridi.
Sentivo gli occhi di tutti addosso, ma non mi importava nulla. In quel momento, per la durata di quella canzone, eravamo solo noi due.
«Non ti piace?»
«Affatto, anzi… Penso sia adatta a noi…» Le parole uscirono senza che riuscissi a fermarle. Quando mi accorsi di cosa avevo detto, la stretta al cuore si fece più forte.
«Che intendi?» Lo sguardo confuso di Cam era più che giustificato, ma non volevo rispondere. Nessuna fibra del mio corpo, voleva rispondere. E allo stesso tempo, volevo gridare ciò che provavo per lei al mondo intero.
L’ultima nota del pianoforte riecheggiò dalle casse, e in quel momento Francesco uscì di casa per chiamare tutti a tavola: «Movetevi che chi prima arriva, meglio mangia!»
«Beh, per me e Arkin è arrivato il momento di andare. Domani parte e devo salutarlo come si deve, non è vero amorino?»
Manuela, che non mi aveva rivolto parola per l’intera serata - cafona -, si era avvicinata non appena finita la pizza, poggiando le mani sulle spalle di Arkin.
«Parti?» Chiesi al mio amico, confusa. Notai che fosse rimasto di sasso, e non ne compresi il motivo. Finché Manuela, vedendo il mio sguardo, non venne in “aiuto” di entrambi: «Non lo sai, Camilla? Domattina Arkin deve tornare a casa sua, in Norvegia. Non te lo ha raccontato? Lavora come pizzaiolo da suo zio, torna in Italia per le ferie per un paio di settimane l'anno, solo che questa volta ha deciso di prolungare la sua vacanza qui… Chissà perché, Cam, non è vero?»
Il cuore mi mancò un colpo.
«Manuela, sta’ zitta…»
«Tu... vivi in Norvegia?» Fu tutto quello che riuscii a dire, senza però ottenere risposta dal diretto interessato.
«Sì, ha l’aereo domattina presto, perciò ci siamo trattenuti anche troppo.»
“Non l’ho chiesto a te!” Avrei voluto urlarlo, ma il nodo alla gola me lo impedì. Nella mia testa mi sfondai i polmoni, però.
«Ma davvero non sapevi nulla Camilla? Strano, dato che io lo so da quando ho iniziato a frequentarlo… Pensavo che, vista la vostra profonda amicizia, te lo avesse detto subito.»
“Okay, ora se non si zittisce giuro che le spacco la faccia.”
«Oh, piccola stella… qui tutti lo sappiamo, abbiamo fatto questa cena apposta per dirgli "ciao, all'anno prossimo".»
Ma non dovetti preoccuparmi, perché Arkin scattò in piedi, una mano sempre poggiata al tavolo. «Manuela, ora basta, finiscila!»
Lei gli girò intorno con occhi socchiusi e sopracciglia alzate, le mani a sfiorargli le larghe spalle, un sorriso sarcastico dipinto sul volto. «Eh, perché ti arrabbi con me così, bambolotto? Non dirmi che glielo volevi tenere segreto, che senso aveva? Partire senza dirle nulla… non è maleducato? Non è forse una tua carissima amica di infanzia?»
«Sta’ zitta…» Mormorò lui tra i denti, chinando la testa.
«Oppure, è qualcosa di più?» Gli sussurrò all’orecchio lei, ma a voce abbastanza alta da farsi sentire da tutti i presenti. Attese qualche istante, forse per avere una risposta che però non arrivò, dopodiché prese e uscì di casa, congedandosi con un secco: «Divertiti in Norvegia, Arkin.» Pochi istanti, e Tommaso le andò dietro, lasciandosi alle spalle una risata saccente.
Calò un silenzio assoluto, nel quale io cercavo solo di metabolizzare il fatto che da quella sera non avrei più rivisto Arkin.
«Wow… Che uscita di classe…» Commentò ironico Francesco, cercando di smorzare la tensione e invitando tutti quanti a fare una partita al biliardo che aveva nella stanza accanto. A dire il vero, ce li trascinò praticamente a forza…
Si avviarono tutti, tranne me e Arkin. Francesco ebbe il buon senso e il tatto di non richiamarci, ma spingere con più enfasi gli altri lontani, in modo da permettere a noi due di restare soli nel salone.
Passarono i minuti, riempiti solo dal suono ovattato delle sfere che correvano sul tappeto verde e che schioccavano tra di loro, nella stanza accanto.
Dopo un tempo infinito, Arkin fece per pronunciare il mio nome, ma lo interruppi ancora prima che potesse dire la seconda sillaba, con un grido che penso mi abbiano sentito dall’altra parte del mondo: «Come cazzo sarebbe a dire che tu vivi in Norvegia?»
Si voltò verso di me, una mano a tapparmi la bocca, dicendo con tono pacato, ma che sapevo perfettamente nascondere tutta la sua rabbia e il suo nervosismo: «Punto primo, non ti azzardare mai più ad attaccarmi in questo modo, non ne hai il diritto. Secondo, non ti devo nessuna spiegazione. Terzo, non è questo il luogo per discutere, quindi prendi la tua roba e andiamo a salutare tutti che ti riporto a casa, non abbiamo più niente da fare qui dato che la serata è stata rovinata a tutti e due.» Andò nella stanza accanto ad avvisare che stavamo andando via, dopodiché tornò da me e mi superò senza degnarmi di uno sguardo né di una parola, dirigendosi direttamente alla porta.
Presi la borsa e lo seguii, senza alcuna intenzione di lasciar correre quella storia e pretendendo delle spiegazioni più che esaurienti per il suo comportamento.
«Scendi.» Esordì secco, fermando la macchina su uno spiazzo di ghiaia. Guardai appena fuori dal finestrino, con ancora il volto furioso e le braccia incrociate sotto il seno. La luce era poca, ma riconobbi che non ero assolutamente a casa mia, ma al parco vicino a dove facevamo catechismo da bambini.
Mi voltai verso di lui, che aveva gli occhi puntati in avanti. Strizzai i miei, proclamando: «Te lo scordi di lasciarmi qui, di notte. Tu mi porti a casa adesso, o quanto meno in un posto dal quale non mi ci vogliano due ore e mezza a piedi in mezzo ai boschi per raggiungerla!»
Lo vidi stringere le mani sul volante, il volto storpiato in un ghigno furioso. In quel momento, ebbi davvero paura di lui. Chiuse gli occhi con forza, probabilmente in un ultimo tentativo di calmarsi, sibilando a denti stretti: «Non ho intenzione di guidare in queste condizioni, potrei andare ad abbracciare un pino volontariamente a causa della rabbia, quindi ora scendiamo tutti e due e concludiamo questa storia una volta per tutte.»
Non risposi, scesi dalla macchina e mi diressi in automatico all’altalena. Vederla lì, immobile e per nulla cambiata in tutti quegli anni mi fece stringere il cuore. Avevo sempre adorato quell'altalena, avevo sempre creduto fosse fatta apposta per noi tre. Non era a coppia come la maggior parte di quelle che si trovano nei parchetti, aveva quattro sedute ma, una di esse noi non l'avevamo conosciuta, probabilmente si era rotta prima che vi approdassimo.
Ne accarezzai appena il legno delle gambe, mentre nelle orecchie mi risuonavano le risate di quei tre bambini che giocavano allegri. Quanto avrei voluto tornare indietro a quei momenti. Chissà se Arkin si era reso conto di aver guidato fin lì.
«Si può sapere cosa avevi da incazzarti tanto?» Mi chiese in un grido, sbattendo la porta della macchina e venendomi incontro a passi furiosi.
Accigliai lo sguardo, tornata al presente, per voltarmi verso di lui e gridargli contro: «Hai davvero il coraggio di chiedermelo? Domani tu parti, te ne vai in un altro Stato, dove c’è casa tua e io lo vengo a sapere per puro caso da una che conosci solo perché te la scopi! Lo hai detto a lei e non lo hai detto a me, che mi conosci da una vita!» Gli puntai il dito al petto, con la rabbia che mi traboccava dagli occhi e che non riuscivo più a trattenere. «Ecco perché sono arrabbiata! Perché non mi hai mai detto nulla? Come pensavi di fare? Sparire nel nulla, da un giorno all’altro? Aspettare che ti chiedessi di uscire a prendere una coca cola al bar? E magari rispondermi con un messaggino che non potevi, perché eri tornato a casa tua, a più di duemila fottuttissimi chilometri di distanza!»
Lo vidi abbassare lo sguardo, portare le braccia lungo i fianchi e serrare i pugni fino a far diventare bianche le nocche. Riuscivo a intravedere i tendini sui polsi e sul collo, parevano star per esplodere. «Io… con te è difficile.»
«Perché?» Chiesi esasperata.
«Perché…» Diede un potente pugno al pino che aveva al fianco, facendomi fare un piccolo salto e con tanta forza che avrei giurato di veder tremare l’albero, per poi rialzare orgoglioso lo sguardo e accanirsi: «Senti, tu non hai alcun diritto di attaccarmi in questo modo! Sei stata tu la prima ad andartene e io sono venuto a saperlo a cose già fatte, all’ultimo minuto. Sei l’ultima persona sulla faccia della Terra a potermi rinfacciare il mio atteggiamento! Te ne sei andata senza dire nulla, adesso ti senti come mi sono sentito io in quel momento!»
Aprii la bocca, sorpresa e incredula, per poi rispondergli per le rime: non riuscivo a credere che tutto quello che stava accadendo fosse una ripicca. «Ma ti ascolti quando parli? Ti rendi conto di quanto sei assurdo? Quindi questa sarebbe la tua vendetta per quel che è successo quando eravamo bambini? Avevamo 8 anni, adesso ne abbiamo 23! Ci sono 15 anni di differenza in cui si dovrebbe essere maturati! Maturati, cazzo! Sai cosa significa questa parola, eh Arkin?»
«Maturati? Proprio tu mi vieni a dire una cosa del genere, Camilla? Tu che sei venuta al funerale di Paolo e te ne sei stata tutto il tempo in un angolino della chiesa!» In quel momento, il tempo mi parve fermarsi. “Allora mi aveva riconosciuta…” Il ricordo di quella giornata mi riempì la mente e le lacrime iniziarono a farsi prepotenti dietro gli occhi, mentre lui continuava a gridarmi contro: «Non hai nemmeno detto una parola ai suoi genitori, sei sparita non appena lo abbiamo sotterrato senza dire una parola a nessuno! Nemmeno a me, cazzo! E adesso mi vieni a rinfacciare qualcosa sulla maturità?»
«Io…» Alzai le spalle, nel vano tentativo di nascondermici in mezzo, abbassando il volto e facendo una fatica immane a trattenere le lacrime, mentre serravo i pugni per farmi forza. «Beh, mi spiace di non esserci stata, okay? È ancora una cosa che mi fa stare male, nonostante siano passati anni! Hai idea di come mi sia sentita io, in quel momento? Ho scoperto che è morto per un articolo sul giornale! E sono scappata, in tutti i sensi, nemmeno i miei sanno che sono venuta alla funzione, ma non riuscivo a credere che fosse morto! Anche oggi ho fatto una fatica immane a credere che fosse dietro quella parete di marmo!» Mi voltai, per non fargli vedere che le lacrime avevano vinto. «Però… ora non sto più scappando… E io non voglio che tu te ne vada… Non voglio perderti di nuovo… Perché è così che finirà, se parti. Lo sappiamo entrambi!»
Mi superò, con la mano sana nella tasca dei jeans e quella dalle nocche insanguinate, a causa del pugno al pino, ad accarezzare la catena dell’altalena. Quella di Paolo, quella dove si sedeva sempre il nostro amico. Andò poi a raggiungere la propria, per sedercisi e iniziare a dondolare appena, senza staccare mai i piedi da terra.
«Cosa devo fare con te?» Sospirò, cacciando indietro la testa rassegnato, dopo un tempo che non seppi quantificare.
Lo guardai asciugandomi gli occhi con il dorso della mano, dopodiché, a vederlo così, mi scappò un sorriso che non riuscii a trattenere.
«Che c’è da ridire?» Chiese lui, guardandomi confuso e con il broncio che aveva sempre da bambino dopo un litigio.
Risi ancora per un istante, dopodiché iniziai a canticchiare.
Qui nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi
che trattan gli insegnanti come fossero pupazzi...
Lo vidi iniziare a ridere di gusto, sereno. Bastò per farmi tornare definitivamente il sorriso. In effetti, quella canzone doveva aver riportato anche lui un poco indietro nel tempo, a quando veniva a casa mia e costringevo lui e Paolo a vedere l’anime di Kodomo no omocha. Mi era sempre piaciuto, ma vederlo assieme a loro era qualcosa di speciale.
«Forza! Lo so che te la ricordi!»
Lui mi guardò con un sopracciglio alzato, ancora senza riuscire a smettere di ridere: «Cosa? No, no, no… Scordatelo! Non ho la minima intenzione di mettermi a cantare qui fuori come un ubriaco! Sei impazzita per caso? E se ci sentisse qualcuno?»
«Eddai! Ma chi vuoi che ci senta, siamo in mezzo ai lupi. E poi chissenefrega!» Gli feci gli occhi dolci, andandogli di fronte, per poi poggiare le mani sulle sue ginocchia, sorridere raggiante e ricominciare:
Qui nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi
che trattan gli insegnanti come fossero pupazzi...
Lui mi guardò cercando di trattenere le risate, così io alzai un sopracciglio e sogghignai: «Posso continuare tutta la notte, lo sai.»
Qui nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi
che trattan gli insegnanti come fossero pupazzi...
Feci cenno di proseguire, mentre lui si passò una mano sul volto, dopodiché si arrese e, sorridendo, iniziò a venirmi dietro:
Ragazze state buone, altrimenti la pagate.
Perché a noi piace far così, perciò non vi impiccate.
No, noi non stiamo zitte
e prendiamo la parola,
per dire a tutti quanti
che non vi vogliamo a scuola.
Potete dirlo e poi ridirlo
ma noi continuiamo,
sì continuiamo a fare in classe
quello che vogliamo.
Ci allontanammo dalle altalene e iniziammo a girovagare, a pochi passi di distanza l’uno dall’altra, intorno ai diversi giochi del piccolo parco che ci aveva visto divertirci tanto da bambini, con solo le stelle e lo spicchio di Luna alto in cielo a fornirci la luce.
Ogni giorno è sempre peggio con quei ragazzacci,
che durante le lezioni ci disturbano.
Sono rozzi, impertinenti,
proprio dei maschiacci.
Ma cosa possiamo fare se non cambiano?
Rossana dai pensaci un po' tu,
perché così non se ne può più.
Sappiamo che non ti arrendi mai
e provi e riprovi finché ce la fai.
Rossana il tuo cuore palpita,
ma la tua pazienza scalpita.
Con tutta la tua vitalità,
Rossana sei proprio una piccola star!
Salii sulla spalliera a pioli della palestrina unita allo scivolo, per poi mettermi a cavalcioni sulla trave della cima e guardarlo dall’alto.
Quante volte il nostro cuore va per la sua strada…
Incurante dei problemi e delle priorità.
Se c'è confusione o no, l'amore non ci bada
e Rossana ha già scoperto questa verità.
Lui mi guardò sorridendo, mostrandomi quel blu intenso dei suoi occhi che non ho mai dimenticato in tutti quegli anni. Lo vedevo perfettamente, nonostante fosse buio: era come se per quei due zaffiri non esistesse luce esterna, se la creavano da soli, in base allo stato d’animo che aveva il loro padrone. Non cambiava nulla che ci fosse un sole abbagliante o si trovassero nel buio più scuro: Arkin con quegli occhi poteva illuminare qualsiasi cosa, se solo lo voleva.
Salì facilmente, anche perché alto com’era gli bastava salire due pioli per raggiungere la cima, di fronte a me. Si mise anche lui a cavalcioni, mostrandomi il sorriso più bello che avessi mai visto.
Rossana dai pensaci un po' tu,
perché così non se ne può più.
Sappiamo che non ti arrendi mai
e provi e riprovi finché ce la fai.
Rossana il tuo cuore palpita,
ma la tua pazienza scalpita.
Con tutta la tua vitalità,
Rossana sei proprio una piccola star.
Scese dalla trave con un salto, per poi voltarsi nuovamente verso di me e porgermi la mano. Gliela strinsi, sorridendo, per poi saltare giù e appoggiarmi a lui, che mi fece fare un giro sostenendomi sotto le braccia prima di farmi ritoccare terra.
Con il cuore in gola, continuai la canzone, alzando lo sguardo e immergendolo in quelle gemme.
Se guardo gli occhi tuoi…
Nei quali poi si specchiano i miei...
La mia mano destra e la sua sinistra si cercarono, intrecciando le dita delicatamente.
Vuoi dirmi quel che vuoi?
Sei magica così come sei...
Le nostre fronti si unirono, sfiorandosi l’un l’altra, mentre sentivo il cuore che sembrava volermi uscire dal petto.
Non ce la potevo fare, stavo per cedere. Perciò chiusi gli occhi, perché sapevo che se lo avessi guardato anche solo un altro secondo non avrei resistito al desiderio di baciarlo.
Se chiudo gli occhi penso a te,
perciò vorrei sapere se pensi a me…
Perché sei tu la cosa più importante,
la più importante che per me adesso c'è
Feci per cantare la strofa seguente, ma mi trovai le labbra di Arkin sulle mie.
Mi portò la mano libera al volto, una leggera carezza sulla guancia, mentre l’altra si sciolse dalla presa con la mia e si posò sulla base della schiena, tirandomi a lui, probabilmente perché si era accorto che se non mi avesse sorretta, mi sarei sciolta a terra come nulla.
La sentii tremare tra le mie braccia, trattenere il respiro come se credesse che così sarebbe stata in grado di fermare il tempo in quell’istante.
Stavo per allontanarmi, ma Camilla dischiuse le labbra. E allora anch’io trattenni il fiato. Perché anch’io avrei voluto che il tempo si fermasse. Anch’io avrei voluto poter rimanere così per sempre. Anch’io avrei desiderato con tutto me stesso non doverla lasciare mai, poterla tenere fra le mie braccia e non dirle mai più addio.
Ma il tempo non si ferma per nessuno, perciò mi feci coraggio e mi separai da quelle labbra così dannatamente morbide.
Ricordo ancora benissimo il dolore, fisico, che provai in quel momento. «Questo è… stato un errore.» Scostai il volto, incapace di sopportare quegli occhi meravigliosi, preferendo guardare a terra. Non la vedevo, ma la percepii comunque sgranare lo sguardo che era sul punto di riempirsi di lacrime, mentre mi davo del vigliacco e la lasciavo andare. «Io sto per ripartire, una relazione a distanza sarebbe impossibile. Io per primo non sarei mai in grado di gestirla.»
Decisi che, a quel punto, tanto valeva finirla da stronzo, almeno lei avrebbe fatto prima a dimenticarsi di tutto. Le sorrisi e mi portai la mano ai capelli: «Per un attimo, pensavo tu fossi Manu e quindi mi è venuto spontaneo baciarti. Mi dispiace, dev’essere l’alcool di stasera che ha fatto effetto a scoppio ritardato, che vuoi farci… Sono un po’ brillo, meglio rientrare.» Lo dissi divertito, con il tono di un pagliaccio. Uno stronzissimo pagliaccio che aveva appena ferito la persona a cui teneva di più sulla faccia della Terra.
Mi diressi alla macchina, il falso sorriso che si spense non appena superai Cam.
«Bugiardo…» La sentii sussurrare singhiozzando, nel tentativo estenuante di trattenere le lacrime. Sempre orgogliosa e fragile, la mia Camilla.
E come darle torto, eravamo stati vicini tutta la sera, sapeva benissimo che non avevo bevuto un goccio. Anche perché era stata lei a fulminarmi non appena Daniele mi aveva offerto la birra con la pizza, costringendomi a farmi optare per la coca cola…
Tirai un respiro, raccolsi tutte le mie forze e, atono, dissi senza voltarmi e riprendendo a camminare verso la macchina: «Vieni, ti riporto a casa.»
Inutile dire che il viaggio sia stato nel più assoluto silenzio, c’era una tensione tra noi come non mai. Le lanciai ogni tanto qualche occhiata, vedendola sempre con la fronte poggiata al finestrino e gli occhi spenti. Mi faceva male vederla così, ma ciò che faceva ancora più male era sapere che stava così per colpa mia.
«Lasciami qui.» La sentii dire, quando arrivammo all’inizio del viale che conduceva poi a casa di sua madre.
«Sicura? Non è un problema portarti almeno davanti casa.»
«No, lasciami qui. Non voglio che mi vedano arrivare con te.»
«Sono le due di notte passate, chi vuoi che…»
«La vuoi smettere di fare lo stronzo? Ti ho rotto così tanto mezz’ora fa, quando ti sei fermato al parco? No, quindi adesso lasciami all’inizio del viale e basta!» Mi rimbeccò lei, con la voce tremante che ne tradiva il dolore.
La guardai, fermando la macchina all’imbocco della via. Non perse tempo e scese ancora prima che la vettura si arrestasse completamente, per poi chiudere la portiera e dirigersi a casa. Senza una parola, senza un gesto.
Strinsi le mani sul volante, il cuore a mille, aprii la portiera e mi appoggiai al tettuccio: «Stjerne!»
Lei si fermò, si voltò dopo qualche secondo, salutandomi con la mano, le guance rigate dalle lacrime e mi sorrise. Un sorriso triste, ma pieno d’affetto. Il cuore si frantumò a quella vista.
«Farvel, beste venn! (Addio, amico mio!)» La vidi voltarsi e proseguire verso casa, allontanarsi nella notte, da me e da tutto ciò che rappresentavo. Quell’ultima frase che mi aveva detto, significava tutto. Ero solo un amico, per lei, non più il suo angelo. E quello era un addio, non un arrivederci. Era meglio così, per entrambi.
Rimasi immobile con mezzo corpo fuori dalla macchina ben oltre il tempo che le ci volle per venir inghiottita dalle tenebre, incapace di rientrare e con un disperato desiderio di andarle dietro, abbracciarla, baciarla, dirle che non volevo andarmene, che volevo stare con lei. Solo con lei.
Ma non feci niente.
Alzai appena la mano in un cenno di saluto e sussurrai: «Farvel… Min kjærlighet… (Addio… Amore mio…)» Rientrai in macchina, il cuore assente, e tornai a casa dei miei genitori, dove mi aspettavano ancora le valige da fare prima di prendere l’aereo l’indomani mattina, per tornare a casa mia.
Stetti tutta la notte con la spalla poggiata alla finestra della mia stanza, guardando fuori il cielo scuro, in attesa dell’alba. Non volevo più dipingere, e mi sentii una stupida per averlo desiderato così intensamente solo qualche ora prima.
Non sapevo a che ora fosse il volo di Arkin, sentivo di volerlo e non volerlo sapere allo stesso tempo. Tanto, anche se lo avessi saputo, cosa sarebbe cambiato? Sarei comunque rimasta tutta la notte a osservare il cielo, sarei rimasta comunque con il biglietto a forma di cuore in mano. "E io che son pure tornata a corsa a casa per salvarlo da delle ipotetiche fiamme… Che imbecille che sono…"
Una parte di me avrebbe voluto piangere, mentre l’altra si stava ancora maledicendo per essere scoppiata in lacrime quando lo avevo salutato, ma al suo richiamo non ero più riuscita a trattenerle. Perché lo sapevo, che mi aveva vista, che aveva visto le mie lacrime. Le aveva viste… e non si era mosso di un passo.
Fino a che non ero entrata in casa, avevo sperato che mi avrebbe seguita, che mi avrebbe abbracciata e sorriso, guardata con quelle due gemme blu e detto che, anche se partiva, avremmo trovato il modo per restare in contatto. Avevo sperato, ma lui non mi era venuto dietro e io avevo chiuso la porta alle mie spalle.
Un sorriso amaro mi si dipinse in volto: ero una cretina, speravo in qualcosa che accade solo nei film.
La gatta mi venne a grattare sulla finestra, così le aprii e Grugra non perse tempo, saltandomi sulle gambe e mettendosi comoda, acciambellandosi. Pochi secondi e la sentivo già russare.
Dovevo dimenticarlo, dovevo assolutamente togliermi quegli zaffiri e quel sorriso da schiaffi dalla testa. E sapevo bene come fare: dovevo buttarmi anima e corpo in qualcosa, qualsiasi cosa. Lo studio universitario era un'ottima idea, ma avrei finito per non uscire più di casa e impazzire. “Ho bisogno di qualcosa di più leggero e più… pratico.”
Mi guardai un attimo attorno e vidi la costola del libro per la patente. “Ma sì, in fondo perché no.” Allungai la mano quel tanto che bastava per prenderlo. “Ma prima…” Tirai fuori il cellulare e mandai un singolo messaggio, prima di aprire il libro di testo e iniziare a studiare.
Ci tenevo a precisare una cosa. Siccome ho notato uno… strano, diciamo così, aumento delle visualizzazioni del racconto durante i giorni di martedì e giovedì (ovviamente intendo prima dell’effettiva aggiunta del nuovo capitolo), volevo solo precisare che prima dell’ora di pranzo non esce nulla. Quindi state tranquilli e ci si vede nel primo pomeriggio, okay? Per l’amor del cielo, non è assolutamente una colpa, ci mancherebbe anche. Anzi come autrice fa pure piacere, da un certo punto di vista. Uno è liberissimo di andarsi a vedere tutti i capitoli che vuole, quando vuole, quante volte vuole. Solo che… Non mi fate smattare il contatore delle visualizzazioni per favore, perché davvero… mi fare credere che siate davvero tanti a leggere. E non è carino.
E poi boh, io reputo un atteggiamento del genere un po’ ansioso (perché lo facevo anch’io, a suo tempo, lo ammetto) e so cosa si prova a non vedere l’aggiornamento quando ti aspetti che ci sia. Sfava. E tanto, anche. Quindi, vogliamoci bene a vicenda, okay che ho detto che pubblico il martedì e il venerdì, però sappiate che tanto prima dell’ora di pranzo solitamente non c’è nulla. Grazie dell’attenzione, e alla prossima!
No, ‘sto capitolo non lo commento. Si commenta da solo. E poi al prossimo c’è Aurora che ci pensa lei a commentare, quindi io non ho altro da dire lol

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 11
*** Pagina 10 ***
Pagina 10.
(I saw an angel
of that I’m sure)
Ho visto un angelo
di questo sono sicuro.
– You’re beautiful, James Blunt
«Io lo ammazzo.»
I lunghi capelli biondi di Aurora parvero alzarsi sopra la sua testa, manco stesse diventando super sayan. Con il suo sguardo di fuoco, la muscolatura che pareva tremare e i tendini tesi, in effetti, avrebbe potuto benissimo essere paragonata a Goku durante la prima trasformazione.
Da una parte pensai fosse meglio la versione ssj, visto che l'altra probabile opzione sarebbe stata quella albica. Non volevo che Elsa uccidesse un unicorno per farne un destriero della notte, per quanto cazzuti potessero essere quegli animali, solo per arrivare in Norvegia e torturare Arkin fino a che non l'avesse pregata di ucciderlo.
Per un attimo mi lasciai accarezzare dal pensiero di dar via libera alla mia migliore amica, e con mia sorpresa, già solo quello bastò per farmi sentire molto meglio.
Liberai le mie labbra dalla cannuccia della coca cola, mostrando alla ragazza di fronte a me un sorriso sincero di gratitudine. Elsa si tranquillizzò pian piano, facendo tornare le sue iridi il loro solito, dolce e tosto, color miele.
Feci un respiro per trovare le parole giuste e, solo quando seppi cosa dire, aprii bocca. «Io voglio una relazione come la tua. Tu conosci tutto di Leo, e lui di te. Siete perfetti insieme, anche chi non vi conosce lo può affermare con certezza.»
«Beh, noi siamo stati predetti.» Sogghignò lei, dando un morso al panino e facendomi scappare un sorriso. Le sue guance vennero attraversate per un attimo da un leggero rossore; nonostante potesse non sembrare, e lei facesse di tutto per nasconderlo, Aurora era una ragazza che arrossiva molto facilmente, quando si parlava dei suoi affetti o le si faceva un complimento particolarmente sincero. Questa cosa l'aveva sempre resa super dolcissima ai miei occhi.
«Appunto!» Esclamai, con un sorriso quasi divertito. Loro due erano davvero il tipo di coppia cui anch'io avevo sempre aspirato. E il fatto che fossero stati predetti non era uno scherzo o un’esagerazione, ma la pura verità.
Era l'inizio dei nostri allenamenti di canottaggio, otto anni prima, quando durante l'allungamento Jolly era rientrato dalla corsa e, osservandoci per meno di cinque secondi, si era rivolto ad Aurora con un sorriso e aveva decretato: «Tu saresti perfetta per Leonardo.» Al tempo, nessuna delle due aveva la più pallida idea di chi fosse questo Leonardo, e anche quando lo avevamo incontrato per la prima volta non avevamo fatto nessun collegamento. Poi, alla prima braciata societaria, avevamo fatto gruppo con altri della nostra categoria d'età ed eravamo stati a parlare per buona parte della notte di canottaggio.
Da quella sera, Leo aveva iniziato a venire più spesso in palestra, a baccagliare un po’ Elsa. Lei era stata fenomenale, all'inizio del rapporto, perché non si era sinceramente accorta di nulla, lo vedeva come un compagno di palestra, nulla di meno e nulla di più. Ciò significava che chiunque osasse prenderlo in giro, che non facesse parte della nostra cerchia, avrebbe dovuto affrontare la sua ira e, allo stesso tempo, Leo avrebbe potuto avere un bambino da un’altra e lei sarebbe stata la prima a fargli le congratulazioni. Il poverino - mi faceva davvero pena al tempo, mista a tenerezza - era riuscito a strapparle il primo appuntamento senza nessuna fatica, solo perché Elsa era certa che fosse un'uscita di gruppo e aveva accettato all’istante.
Come avrei voluto esserci quando, una volta resasi conto di essere al suo primo vero appuntamento romantico con un ragazzo, aveva avuto tanta paura di essere un fiasco totale che si era persino lasciata baciare e toccare il fondoschiena senza dire nulla.
Ovviamente poi lo aveva scaricato, giorni dopo, con la terribile frase “restiamo solo amici”, dandosi la ridicola scusa che il loro primo bacio aveva fatto iniziare a piovere, che quelli successivi non le avevano detto nulla e, la migliore fra tutte, che era già sposata con il remoergometro e non aveva nessuna intenzione di tradirlo così presto.
Eppure, da quel disastro di primo appuntamento, quei due avevano iniziato a provare qualcosa l’uno per l’altra di più profondo della semplice attrazione. E un giorno primaverile di quasi un anno dopo quando, senza nessuna forzatura ma solo spinti da ciò che provavano, si erano ritrovati quasi a baciarsi prima di venire agli allenamenti, Elsa aveva capito di essere completamente cotta di lui.
Tempo nemmeno due mesi, Leo era arrivato agli allenamenti con il parabrezza della macchina incrinato, da dentro. Inutile tentare di dire che non era come potevamo pensare, i due sono diventati leggenda. Tempo un anno, lui le aveva chiesto la mano e lei aveva accettato. Non si erano ancora sposati, ma era solo questione di mettersi dei soldi da parte ormai, per poter cominciare con qualcosa che non fossero subito debiti. Elsa aveva sempre sognato il matrimonio in grande, ma avevano preferito dare la priorità alla casa, che avevano acquistato da poco e vi sarebbero entrati entro l'estate successiva, giusto il tempo di fare qualche lavoretto di ristrutturazione.
I sentimenti e le intenzioni di vivere insieme, di creare una famiglia e passare il resto della vita assieme, c’erano già tutte.
Elsa si asciugò la salsa che le era colata durante il morso con l’angolo del pollice, per poi portarlo alle labbra. Rimase un attimo assorta nei propri pensieri, dopodiché le vidi l’espressione da ragazza innamorata persa che tanto amavo di lei: «Beh… Sì, è vero. Io conosco tutto di Leo, del suo corpo… Potrei elencarti tutte le cicatrici del suo corpo e dirti come se le è fatte. Tipo quelle sulle spalle, o quelle delle cisti tendinee ai polsi, o quella al ginocchio di quando è caduto con il 4x sulla discesa per scendere in barca, o quella sulla nuca di quando gli è caduto il quarto di vitello in testa… E tutti i vari tagli sulle mani dovuti al coltello e agli ossi!» Alzò lo sguardo, mostrandomi un sorriso di pura gioia: «Conosco tutto di lui e allo stesso tempo non lo conosco affatto, perché ogni volta riesce sempre a farmi provare qualcosa di nuovo!»
«Ecco vedi… Tu ami tutto di lui!» Esclamai quasi con esasperazione, lasciando cadere le braccia sul tavolo di plastica. «Lo si capisce anche solo guardandoti che sei cotta come il primo giorno…» Elsa mi lanciò un’occhiata più che chiara, facendomi correggere: «Anzi, decisamente di più del primo giorno.»
«Tu non conosci tutto di Björn?»
Diedi un morso all’hamburger prima di rispondere, mogia. «Conosco il lui bambino… Ma il ragazzo di adesso… No, non lo conosco.» Una smorfia mi prese il possesso del volto, mentre le braccia andavano a stendersi nuovamente sul tavolo e la testa si inclinava all'indietro. «Non sapevo nemmeno che abitasse in Norvegia!»
Elsa prese un sorso di coca cola, come se la bevanda l’aiutasse a riflettere meglio - e conoscendola, poteva anche essere vero -, dopodiché mi chiese: «E quando stavi con lui?» Il mio sguardo interrogativo la esortò a spiegarsi meglio: «Che sensazioni avevi quando eravate insieme?»
«Non saprei.» Scostai lo sguardo, mettendomi una patatina in bocca, per poi lasciarmi andare a un sospiro confuso. «È complicato. Quel che so per certo è che non sapevo mai cosa gli passasse per la testa, sia nel bene che nel male…» Mi misi tra le labbra un altro bastoncino salato, senza davvero assaporarlo. “È vero… Ora che ci penso bene, non sono mai riuscita a leggere veramente quegli zaffiri e ciò che celano.”
«Non è che, forse, eravate entrambi così presi dai voi bambini che non avete fatto troppo caso ai voi adulti?»
Quella frase mi colpì come un cavallone che si infrange sugli scogli. Guardai la mia migliore amica come se fosse la risposta a tutte le mie domande, gli occhi sbarrati, mentre lei proseguiva con il maggior tatto di cui era capace: «Se fosse così… Se l'interesse che provavate era riguardo ai voi di un tempo, il voler ricostruire a tutti i costi quel rapporto… Cami, io non credo sia una cosa buona, sana. Credo che, presto o tardi, se anche lui fosse rimasto, avreste finito per separarvi di nuovo. Pieni di rancore, completamente stremati dal tentativo di ritrovare quella persona che non esiste più. Perché siete cresciuti, siete cambiati… Non si può tornare indietro nel tempo.»
Aurora aprì il coperchio della sua bibita e iniziò a muovervi la cannuccia all’interno, facendola scavare tra i cubetti di ghiaccio nel tentativo non troppo serio di trovare le ultime gocce di coca. «Sai quando… Quando Björn è venuto alla Canottieri e gli ho raccontato di noi, l'ho visto molto preso. Aveva davvero intenzione di farti salutare Sergio come si deve. E di questo io non posso che essergli grata, perché in effetti è riuscito a fare qualcosa che io non sono mai stata in grado di fare. E, ti dirò, penso anche che fosse l'unico che potesse riuscire nell'impresa. E quando me lo hai presentato, che ti ho vista sorridere tranquilla tutto il pomeriggio, libera di poter parlare dei tuoi Miti… Me ne sono accorta, sai? Non avevi mai parlato a nessuno della tua passione per Michelangelo e Leonardo, e quel giorno eri così… animata… Serena, mentre lo facevi. Tuttavia», le palpebre si chiusero, le sopracciglia chiare si avvicinarono, la presa sulla cannuccia si strinse e la deformò, facendole formare un angolo di 10 gradi: «Te lo dico con il cuore: il fatto che ti abbia mollata così, non mi è piaciuto per nulla. E non mi sembra nemmeno possibile… Sto davvero facendo fatica a credere che quei due ragazzi siano la stessa persona.» Mollò la presa sulla cannuccia e mi guardò dritta negli occhi, risoluta. «Ciononostante non puoi continuare a sognarlo. Per quanto possa essere difficile, devi voltare di nuovo pagina e andare avanti.» Allungò la mano e strinse la mia, ancora poggiata sul piano di plastica color crema, gli occhi color miele colmi di affetto. «E per quanto io possa darti una mano, è una cosa che devi fare da sola, perché solo tu puoi, e devi, volerlo.»
«Arkin!» La mano di Svein venne a contatto con la mia faccia senza che io me ne accorgessi. Il mio amico mi spinse allegramente all’indietro, facendo quella poca forza giusto per farmi riconnettere con il mondo reale.
Sorrisi, togliendomi le cuffie con un unico gesto e un poco di dispiacere. Svein era arrivato nel momento più bello della canzone.
Il suo braccio scivolò sulle mie spalle, il sorriso raggiante sul volto, mentre gli occhi andavano a scrutare lo schermo del mio cellulare. «Oh... Dette er musikk fra huset ditt, ikke sant? (Oh… Questa è musica di casa tua, vero?)»
«Mitt hus er her, soldat. (Casa mia è qui, soldato.)» Gli risposi io, sereno. “Già… Casa mia è qui…” Lui mi scrutò per un attimo solo con quegli occhi color ghiaccio. «Den lille halvbredden føles nostalgisk for Italia mer enn normalt på denne turen, ikke sant? (Il piccolo mezzosangue sente nostalgia dell’Italia più del normale a questo giro, o sbaglio?)»
Tirai un sorriso, abbassando lo sguardo. Non aveva senso mentirgli, era mio cugino, il mio coinquilino - quel poco tempo che stava a casa -, il mio migliore amico… Era come un fratello per me. Un fratello che stava a casa nemmeno sei mesi all’anno.
Svein era pilota, come suo padre e suo nonno, militari di alto rango: aveva le ali mimetiche sulla schiena da generazioni. Amava il suo lavoro, e quando non volava per lavoro lo faceva per “sport”. Lui non aveva un’auto, una bicicletta, una moto; aveva un jet. Non era nuovo, ma per poterselo mantenere era perfettamente capace di restare a digiuno per giorni; non aveva vizi di alcun tipo, indossava praticamente sempre la sua uniforme per risparmiare nei vestiti. Rinunciava a tutto pur di poter volare. Tarpargli le ali equivaleva a volerlo far morire.
«Kom igjen (Dai dai)», esordì, prendendomi una cuffia di mano: «La meg høre litt hva du hører under Middelhavssolen. (Fammi sentire un po’ cosa si ascolta sotto il sole mediterraneo.)»
Il mio sorriso si allargò impercettibilmente, mentre sfioravo il tasto play. «Poesi. (Poesia.)»
“4 marzo 1943” iniziò a suonare nelle nostre orecchie.
Quella mattina c’era il pienone sul bus, per essere appena le sei del mattino. Una volta salita, mi sporsi mentre timbravo il biglietto per vedere se ci fosse un posto a sedere libero. Ne intravidi due: uno al finestrino, uno centrale. Non c’era bisogno di chiedere a quale volessi andare. Raccolsi tutto il coraggio di cui avevo bisogno per parlare ad uno sconosciuto e mi diressi verso il primo, sussurrando appena: «È libero?»
Il ragazzo, che conoscevo di vista dato che l’avevo incrociato spesso sul bus, annuì in silenzio, per poi alzarsi in modo da farmi entrare meglio. Ricambiai con un piccolo sorriso, indossai le cuffie e mi misi ad osservare il paesaggio extraurbano scorrere fuori dal vetro.
Era ottobre inoltrato, le poche foglie che erano ancora sui rami parevano reggersi con tutta la loro forza agli alberi, cercando di combattere la forte tramontana. Il bus si fermò e io mi alzai un poco la sciarpa, in modo da riparare le labbra e il naso dalla folata gelida che spirava dalle porte, apertesi per far salire gente.
Durante l’estate avevo preso la patente, ma per andare all’Università continuavo a preferire il bus. Gli orari alle volte non erano dei più comodi, specialmente quando gli autisti si svegliavano con il piede sbagliato e decidevano di fare sciopero o ritardi di quasi mezz'ora, per non parlare di quando non si fermavano proprio, facendomi perdere la coincidenza, ma almeno non dovevo guidare e parcheggiare. E soprattutto, a lungo andare era molto più economico visto che la mia era una macchina che adorava bere.
Non avevo preso la patente per una reale necessità pratica, quanto psicologica: mi aveva impedito di concentrarmi troppo su Arkin e, ormai, sentivo di aver completamente chiuso quell’argomento. D’altronde, era inutile tenerlo aperto: era lui ad avermi mollata, alla fin fine me ne ero fatta una ragione. Lo stesso non si poteva dire di Aurora, la quale, avesse saputo l’indirizzo in cui abitava o anche uno straccio di modo per poterlo trovare, non avrebbe perso tempo ad andare a fargli una “visitina amichevole”. Peccato - ma nemmeno poi troppo - che queste ultime non finivamo mai in modo molto… pacifico.
«Scusa… Sai che ore sono?» La voce del ragazzo accanto a me mi fece distogliere gli occhi dall’esterno e voltare. La musica nelle cuffie era bassa, appena di sottofondo visto che era mattina, perciò non avevo avuto problemi a sentire la sua domanda.
Sbloccai il cellulare e gli risposi con un sorriso appena accennato, per poi tornare a guardare dall’altra parte: «Le sei e venti.»
«Grazie…»
Cadde di nuovo il silenzio, che venne nuovamente interrotto da lui, quando l’autobus era quasi a metà strada: «Ehm… Scusa è che…» Si passò una mano sui ricci, un sorriso imbarazzato sul volto. Lo guardai un poco stranita, non certa di dove volesse andare a parare. «È un po’ banale per iniziare una conversazione, eh? Sono un po’ una frana a rompere il ghiaccio…» Lui mi porse la mano, il volto completamente in fiamme e la voce ancora un poco tremante: «Mi chiamo Mattia. Non ci conosciamo, ma mi piacerebbe conoscerti. Ti ho vista spesso sull’autobus, anche l’anno passato e mi ispiri simpatia e penso che potremmo andare d'accordo e vorrei conoscerti meglio.» Lo disse tutto d'un fiato, come avesse paura di dimenticarsi qualcosa o di bloccarsi a metà frase. O che la paura di passare per uno stalker lo fermasse prima di poter finire di parlare, forse.
Sbattei un paio di volte le palpebre, dopodiché gli sorrisi e gli strinsi la mano, una parte di me contenta di aver trovato qualcuno al mio stesso imbarazzante livello di interazione sociale: «Io sono Camilla.» Arrossii appena, affermando: «Sarò sincera. È un piacere sapere che non sono l’unica ad avere il terrore di rompere il ghiaccio.» Lui mi guardò con gli occhi verdi sgranati, ancora incredulo di non so cosa. «Non hai idea della dose di coraggio che ho dovuto racimolare per chiederti se il posto era libero…»
Le sue labbra si distesero in un sorriso che gli arrivava alle orecchie, incorniciato da un lieve accenno di barba, il rossore ancora prepotente sulle guance. «A te piace sedere vicino al finestrino, vero? Io salgo alla prima fermata, se vuoi d’ora in poi ti posso tenere il posto.»
«Volentieri!»
Ci scambiammo dei sorrisi, ancora un poco imbarazzati, dopodiché iniziammo a chiacchierare del più e del meno, e ben prima di arrivare alla nostra fermata l’imbarazzo era completamente svanito. Durante il viaggio, venni a sapere che aveva un anno più di me ed era uno studente di ingegneria biomedica.
Da quella mattina, per quattro volte a settimana, ci vedevamo sul bus per andare all’università. Sedevamo su quei due posti e iniziavamo a chiacchierare di tutto e nulla, approfondendo la conoscenza l’uno dell’altra ad ogni incontro. Nessuno dei due aveva il cellulare dell’altro, non avevamo modo di parlare all’infuori di quegli appuntamenti, e a nessuno dei due era venuto in mente di cambiare. In un mondo in cui tutto andava programmato, in cui tutti erano rintracciabili all’istante, quei rendez-vous avevano la piacevole atmosfera di un altro tempo. Non prendevamo mai un vero e proprio impegno ma, allo stesso tempo, quelli erano diventati degli appuntamenti inderogabili della durata di un’ora e mezza cui nessuno dei due voleva rinunciare.
Mattia era un ragazzo a primo impatto timido, alle volte impacciava un po’ nelle parole, altre era talmente preso che parlava così velocemente da dimenticarsi di respirare. La sua voce era dolce e sapeva ascoltare. Ma la cosa che mi aveva colpita di più di lui, sin dai primi momenti, era la calma che riusciva a trasmettere. Aveva un’aura che non avevo mai incontrato in nessun altro prima: tutte le persone importanti con cui avevo avuto a che fare fino a quel momento avevano come un uragano dentro di loro, un’energia che pareva poter spostare le montagne. Mattia no, lui era quel tipo di persona che avrebbe potuto placare un oceano in tempesta.
Senza rendermene conto, quegli incontri erano diventati nel giro di appena un mese la ragione per la quale mi alzavo dal letto la mattina.
Probabilmente avrei dovuto trovare un modo migliore di dividere quel momento in cui passano qualcosa come... 7 mesi (?) dalla chiacchiera con Elsa, all'ora di pranzo (giusto perché fare colazione al MC sarebbe stato troppo da reggere per lo stomaco di un corpo non più allenato come quello di Cam, mentre il pranzo è anche accettabile) dopo il misfatto accaduto la sera prima, all'incontro con Mattia. Ci tenevo a precisare una cosa di linea temporale che, mi sono accorta adesso, nella narrazione potrebbe non essere chiara. La storia inizia alla fine di Marzo 2018, Arkin se ne torna in Norvegia all'incirca verso la seconda settimana di Aprile, quindi tutto quello che è successo tra i due dall'inizio del racconto fino allo scorso capitolo è accaduto in, relativamente, poco tempo. Meno di 3 settimane. Arkin sarebbe dovuto rientrare nella prima settimana di Aprile, è restato una decina di giorni in più per organizzare con Aurora il "funerale" di Sergio per Cam e la sua festa di "ciao amico, ci rivediamo alle tue prossime ferie dell'anno prossimo, quasi sicuramente sempre verso Marzo-Aprile perché è stato così negli ultimi 4/5 anni".
Cam incontra Mattia che è ottobre, quasi novembre, quindi, il fatto di essersi "dimenticata" di Arkin è... normale (?) Non so se è la parola corretta.
Io ho appena fatto la figura di bip della mia vita no non mi voglio soffermare a pensare se ce ne sono state di peggio perché la risposta potrebbe solo deprimermi ulteriorimente che mi fa veramente pensare che i semini che Goten aveva piantato nel mio cervello anni fa stiano iniziando a sbocciare. E questa cosa, onestamente, mi fa molta paura.
So che tipo il 98% di voi non capirà cosa ci incastri Son Goten in questa storia (ed è meglio così, credetemi), e probabilmente c'è anche qualcuno che non ha la più pallida idea di chi sia, e io vi dico che va benissimo così. Fate finta di non aver letto quanto sopra. Era uno sfogo personale che non il racconto di Cam e Arkin non c'entra assolutamente nulla, quindi andate avanti con le vostre vite in maniera molto tranquilla, e ricordatevi di stare idratati e di dormire.
E pregate per me, perché un ritorno di Goten in questo periodo della mia vita sarebbe una rovina. Non sarei davvero in grado di reggerlo.

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 12
*** Pagina 11 ***
Pagina 11.
(How would you feel, if I told you I loved you?
It's just something that I want to do
I'll be taking my time, spending my life
Falling deeper in love with you
So tell me that you love me too)
Come ti sentiresti, se ti dicessi che ti amo?
È solo una cosa che voglio fare
Mi prenderò il mio tempo, passando la vita
a innamorarmi sempre più di te
Quindi dimmi che mi ami anche tu
– How would you feel, Ed Sheeran
«Stamani ho una magnifica sorpresa!» Esclamò entusiasto Mattia appena mi vide, alzandosi per farmi andare al mio posto al finestrino. Lo guardai interrogativa, non nascondendo un piccolo sorriso.
Lui tornò al mio fianco, un sorriso a trentadue denti a illuminargli il volto: «Chiudi gli occhi.» Ubbidii e lo sentii armeggiare allo zaino, come alla ricerca di qualcosa.
«Apri!» Non feci in tempo a sollevare le palpebre che i miei occhi si illuminarono all’istante, nel vedere i due pezzi di carta che teneva in mano. «Tadaaan! I biglietti per “Chi è di scena”! Firenze, questo sabato alle 21h00.» Distolsi lo sguardo dai biglietti e lo posai sui suoi occhi verdi. Un sorriso mi prese il possesso del volto, mentre un’ondata di gioia mi invadeva il petto tanto da farmi sembrare che esplodesse. Colma di euforia, non potei controllarmi e gli avvolsi il collo in un abbraccio, ringraziandolo mille volte per il meraviglioso regalo.
Esitò un attimo, forse colto di sorpresa da quel mio scatto di affetto, dopodiché cinse la mia schiena. «Figurati, grazie a te per aver accettato.»
Potei percepire il suo rossore anche se non lo vedevo.
«Però adesso mi devi dare il tuo numero.»
«Prossimo!»
«Uffa!» Sbuffai con le braccia al cielo, dopo il quinto outfit che Aurora mi bocciava. La mia amica era seduta sulla poltrona all’interno della cabina armadio che avevo a casa di mio padre, le gambe incrociate e il volto poggiato sul palmo della mano. «Non è mica colpa mia se non hai nulla da metterti.»
Mi misi le mani sui fianchi, esclamando: «Si può sapere cosa avresti in mente te, come abito idoneo? Altrimenti non usciamo più dall’ampass.»
Vidi gli occhi di Aurora stringersi appena, segno che la sua mente diabolica era al lavoro a pieno regime. Alzò un attimo l’indice, muto cenno di attendere, dopodiché si alzò e andò a mettere le mani tra i miei vestiti.
Tempo due minuti, me la ritrovai davanti con l’abito che mio padre mi aveva comprato per il diciottesimo. «Elsa.»
«Sì?»
«Sto andando a teatro a vedere uno spettacolo del Benvenuti, non in discoteca a ballare sul cubo.»
Alla mia amica cedettero le braccia. «Beh, di certo non puoi andarci vestita come tu andassi al bowling!» Esclamò, indicando ciò che indossavo.
«E allora che dovrei…», mi interruppi, a causa degli occhi di Elsa che brillavano in maniera inquietante. «Sho…»
«No.»
«...pping!» Trillò tutta entusiasta lei, aggrappandosi al mio braccio come avesse ricevuto la notizia più bella del mondo.
Fu così che mi ritrovai scarrozzata in tutti i negozi del corso, a meno di otto ore dall’appuntamento. Elsa mise sottosopra nove negozi, fece venire una crisi isterica a dodici commesse e mi fece provare un centinaio di abiti, finché, a meno di tre ore dall’ora x, fu soddisfatta di ciò che mi vedeva addosso. Un abito abbastanza semplice, color smeraldo: la gonna arrivava appena sopra il ginocchio, il bustino dotato di scollatura a cuore aveva un tocco di luce, dovuto ai brillanti che splendevano sui fianchi.
Io, sinceramente, a quel punto ero talmente stanca che volevo solo che quella tortura finisse. Ero pronta ad andare all’appuntamento anche in mutande, ma provate a dirlo voi alla ragazza che avevo di fronte, la quale aveva gli occhi che le brillavano come diamanti e un’espressione di pura estasi in volto che nemmeno una principessa Disney.
Per pagare usammo la carta che mi aveva dato mio padre tempo addietro e, finalmente, riuscii a tornare a casa per finire di prepararmi.
«Ti vuoi muovere?» La voce di Elsa mi arrivò che ero ancora in doccia, sotto l’acqua tiepida, leggermente scocciata. Mi scappò un sorriso divertito. Vidi l’adorabile broncetto indispettito che aveva in volto ancora prima di averla nel mio campo visivo. Era palese la sua voglia di giocare, e litigare amorevolmente un po’ come me. Stetti al gioco, ovviamente. Quale miglior modo di allentare la tensione prima di un appuntamento a teatro, se non discutere un po’ con la tua migliore amica?
«Sei tu che mi hai trascinato per tutti i negozi del corso. Preferivi che non mi facessi proprio la doccia e andassi all’appuntamento che puzzavo come dopo un allenamento?»
«Esagerata! Addirittura un allenamento! Siamo solo andate a fare un po’ di shopping. Ne avevi bisogno.»
«Eh sì, certo. Perché infatti io non ho niente da mettermi…» Risi, indossando il vestito nuovo e indicando la cabina armadio che ci circondava grande quanto una sala, mentre lei mi spingeva per mettermi a sedere alla stazione di trucco.
Storse la bocca nel tentativo di non ridere e non darmela vinta. «Lo sai, ci sono paesi in cui ci si sveglia alle 4 del mattino per andare a scuola e si pelano patate.»
«Sì certo… e i buchi alle orecchie portano a top e minigonne, che portano alla biancheria sexy, che porta a sesso selvaggio. Quindi perché vorresti farmi indossare questi?» Mi voltai appena verso di lei, mostrandole nel palmo della mano gli orecchini a ciondolo che aveva scelto come match per l’outfit di quella sera.
Elsa rimase in silenzio qualche secondo, poi mi rispose con sogghigno malizioso: «Perché tu hai bisogno della biancheria sexy, visto che stai andando ad un appuntamento.»
Mi caddero le spalle, ma aveva acceso il phon e quindi dovetti aspettare che finisse di asciugarmi i capelli per poter ribattere. «Elsa. È solo un’uscita a teatro, non ci sto andando a letto.»
«Idra.» Mi mise entrambe le mani nei capelli per aumentare un poco il volume, mi forzò a guardarmi allo specchio e mi osservò attraverso il riflesso dello stesso, con un sorriso cosciente in volto. «È un appuntamente a teatro.»
«E quindi?»
«E quindi chi cavolo va a teatro come primo appuntamento? È ovvio che questo ragazzo è cotto di te.»
«Oppure magari è solo un buon amico a cui piace il teatro e la recitazione del Benvenuti e Marchino, e vuole passare una serata con una persona che non gli da del vecchio noioso solo perché vuole andare a vedere uno spettacolo.»
«Non si chiamava Paolo Cioni?»
«Vabbe’, ormai per me è Marchino.»
«Seh, okay…» Prese un po’ di forcine che si mise tra le labbra per tirarmi su i capelli. Il fatto di avere la bocca per metà bloccata non le impedì comunque di dire la sua. «Comunque per me, questo qui vuole qualcosa di più dell’amicizia. E da come me lo hai presentato si dir…»
«Ahio!»
«Sssh, successo nulla.»
«Ma come successo nulla? Mi hai infilzato la forcina nel cervello!»
«Hanno le punte arrotondate, smetti di lamentarti.»
«Anche le forbici hanno le punte arrotondate, ma non significa che non possano essere armi letali!» Feci per portarmi le mani alla nuca, non riuscendo a trattenere le risate.
«Finito!» Alzò le mani al cielo, per poi riappoggiarle sullo schienale della sedia, un sorriso che le attraversava il volto da parte a parte. «Contenta?»
Alzai lo sguardo verso il mio riflesso sullo specchio. Sì, stavo bene, ma quello che mi faceva davvero sentire bene era il sorriso pieno di soddisfazione e affetto che Aurora aveva sul volto. Mi guardava come fossi la sua creatura più bella, lo sguardo di un artista a lavoro completato.
Sorrisi, sentendomi amata tanto come poche volte in vita mia, anche se mi rendevo conto essere un sentimento estremamente stupido da provare. Ciononostante, non lo volli ricacciare indietro e mi ci aggrappai con forza, quasi per paura che svanisse nel nulla.
La ringraziai con un bacio sulla guancia leggero e indossai la giacchetta a metà busto di finta pelliccia nera. In quel preciso momento, manco a farlo apposta, il telefono iniziò a squillare. Il nome sullo schermo era quello di Mattia e, con gli occhi a cuoricino, Elsa mi porse il cellulare. Tirai un lieve sorriso e risposi, dandogli le ultime indicazioni per arrivare all’entrata principale e dicendogli che scendevo subito.
«Vuoi seriamente accompagnarmi fino alla porta?» Chiesi in un sorriso, mentre scendevamo le scale.
«Ti aspetti seriamente che io non veda che tipo è questo Mattia dal vero? In che mani ti sto lasciando?» Rispose lei, come fosse la cosa più ovvia del mondo. Non sapevo se adorare o detestare quel suo lato da mamma super appiccicosa, ma visto che mi stava aiutando ad attraversare i corridoi di casa di mio padre senza avere l'impellente bisogno di scappare e nascondermi, l'ago puntava decisamente in posizione positiva.
Quel filone di pensieri mi fece di colpo venire in mente che Mattia non era mai stato a casa di mio padre e non aveva idea del quasi castello - praticamente l'unica cosa che mancava per definirlo tale erano fossato, ponte levatoio e una torre con una principessa imprigionata dentro - che si sarebbe trovato di fronte. D'altra parte, invitarlo a casa di mia madre avrebbe allungato il viaggio verso il teatro di più di quaranta minuti, rendendo il carburante utilizzato inutile, oltretutto visto che lui abitava a due minuti da casa di mio padre.
Aprii la porta con il terrore di trovare nei suoi occhi lo sguardo che avevo visto in - quasi - tutti coloro che avevano messo piede in quella proprietà, ma quelli che trovai furono due occhi che avevano in loro la meraviglia per tutt'altro.
«Sei… uno splendore.» Disse, in tutta sincerità, quasi senza parole. Si fosse trattato di qualche d'un altro, avrei subito pensato a un'esagerazione voluta, uno di quei complimenti che si fanno giusto per fare colpo e aiutarti ad arrivare all'obiettivo di portarti a letto la ragazza. Ma con lui no. Non lo pensai nemmeno per un attimo e, a giudicare dalla leggera gomitata incoraggiatrice tra i miei polmoni da parte di Elsa, anche lei era dello stesso parere.
«Stai benissimo anche tu.» Ed era vero. Indossava una camicia bianca con le clip al posto dei classici bottoni e dei jeans scuri, sopra la giacchetta di un completo con tanto di orologio al polso destro, visto che era mancino. Si era pettinato i ricci castani e si era curato anche la leggera barba. Stava benissimo, davvero.
Si portò una mano ai capelli e scostò lo sguardo, rosso in volto, sussurrando un flebile ringraziamento. Poi, come se lo fosse ricordato di punto in bianco, mi porse una rosa bianca che aveva tenuto fino a quel momento dietro la schiena. Stava per dire qualcosa, ma venne interrotto dal trillio di euforia alle mie spalle, proveniente da Elsa. Mi schiarii la gola, feci un passo di lato e presentai la mia amica: «Mattia, questa è Aurora. Lei è l'incarnazione dell'entusiasmo.» Elsa salutò velocemente con la manina, prima di riportarla vicino all'altra, intenta a tapparsi la bocca per evitare che ne uscissero altri gridolini. Fece un respiro profondo per ricomporsi, dopodiché iniziò a spingermi verso Mattia e l'esterno. «Okay, ora dovete andare, altrimenti farete tardi.» Prima di darmi l'ultima spintarella, facendomi finire addosso a lui, la sentii sussurrarmi nell'orecchio: «Mi piace, avete la mia benedizione.»
Feci appena in tempo a voltarmi giusto per vedere la mia amica che si sbracciava e, prima di chiudere il portone di casa, esclamava: «Divertitevi! Buona serata!»
“Caspiterina Elsa, non starai esagerando? È solo una serata a teatro…”
«Allora…» Alzai lo sguardo e i miei occhi si incontrarono con quelli color smeraldo di Mattia. Un sorriso morbido come il burro si distese sul suo volto. «Andiamo?»
Riuscii solo ad annuire, come ipnotizzata. Mattia doveva essersene accorto, mi prese delicatamente per mano e ci dirigemmo verso la sua macchina, a pochi passi da noi. Mi aprì la portiera del passeggero e mi invitò all'interno della vettura con gesto elegante, degno del gentleman che era. «Milady.»
Riuscì a strapparmi un sorriso timido, mentre salivo sulla Yaris nera. Sorridevo, eppure dentro sentivo che c'era qualcosa che non andava. Stavo bene, ma avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di irrevocabilmente sbagliato in quello scenario.
Ma non mi venne in mente nulla, perciò cercai di annullare quella spiacevole sensazione e concentrarmi sul resto della serata, sul resto delle magnifiche emozioni che mi stava invece offrendo.
«E chi se lo aspettava un finale del genere?» Uscita dal teatro, avevo ancora gli occhi che brillavano. «Mi sono chiesta per tutto il tempo che caspita ci facesse quella donna dormiente lì in fondo.»
«Ti sei divertita?» Mi chiese Mattia, un paio di passi dietro a me, che sembravo avere le ali ai piedi dal livello di buonumore che avevo. «Tantissimo! Il Benvenuti è il migliore!»
«Sono felice.»
Mi fermai e feci una giravolta, per guardarlo meglio. «Tu sei stato bene?»
«Decisamente.» Il sorriso sul suo volto si distese ancor di più, mostrando appena i denti bianchi. Quella visione mi fece sciogliere qualcosa nel petto. “È bellissimo”, feci appena in tempo a pensare, mentre Mattia riapriva lo sguardo e mi chiedeva a cosa stessi pensando con uno sguardo che trasudava affetto. Per togliermi dall'imbarazzo, dissi la prima cosa che mi venne in mente: «Davvero però, secondo te Gesù si depilava?»
La risata cristallina del mio accompagnatore mi riempì piacevolmente le orecchie, facendomi ridere di risposta, mentre una delle scene d'apertura dello spettacolo si riproduceva dietro ai miei occhi.
Dopo qualche istante, Mattia mi offrì il braccio. «Sei pro a una tazza di cioccolata calda after teather?»
«Super pro!»
L’iniziale rivolo di fumo si disperse in piccole volute nell’aria. Inspirai, tenendo il filtro tra le dita, riempiendomi i polmoni di nebbia calda, prima di espirare con un lungo soffio nel cielo color ossidiana di Arendal.
Da quando ero tornato a casa, avevo preso l'abitudine di fumarmi una sigaretta ogni volta che uscivo da lavoro. Non avevo mai fumato prima, non regolarmente almeno, perché sapevo che faceva male e non avevo mai avuto intenzione di morire di cancro ai polmoni all'età di trent'anni. Ma le cose erano cambiate. In tutta sincerità, non me ne poteva fregare di meno di come sarei arrivato a trent'anni, o oltre. Se il destino avesse voluto che non ci arrivassi proprio, avrebbe trovato il modo, che io mi fumassi quella sigaretta o meno. Quindi perché privarmi di quella piccola piacevole compagnia di pochi minuti.
Un nuova voluta di fumo uscì dalle mie labbra, spaccate dal freddo. Novembre era quasi al termine, Dicembre era alle porte e con lui il freddo del nord iniziava a farsi sentire seriamente. Non ho mai temuto il freddo, anzi, l'ho sempre sentito far parte di me. L'ho sempre accolto a braccia aperte, anche letteralmente. Come in quel momento, appena uscito di doccia, seduto sul terrazzo ad osservare la quiete delle acque del mare del Nord, con il vento gelido che mi dava lievi schiaffi sulla pelle. E solo. Beh, non proprio solo: avevo la sigaretta con me.
Ma in fondo, che avevo da lamentarmi? Avevo un lavoro che non mi dispiaceva affatto, una bella casa in un posto che adoravo, vivevo l'età più bella della mia vita e potevo fare quello che più desideravo, senza legami che mi bloccassero. Vent'anni capitano una volta sola, perché avrei dovuto spenderli dietro a una fantasia? Perché ne ero conscio, lo ero sempre stato, che un rapporto con Cam sarebbe stato solo una fantasia.
Mi scappò un sorriso amaro, mi portai la mano libera ai capelli. Ecco, c'ero ricascato. Un momento di libertà e pensavo a lei. Che imbecille.
Un ultimo elegante passo di danza da parte della densa nebbia e finì, la canula tra le mie labbra giunse al termine. E mi ritrovai di nuovo solo.
Forse non sarebbe stato male accendersene un'altra.
«A che pensi?» La domanda mi venne spontanea, forse un tono un poco più preoccupato di quello che avrei voluto usare, vedendolo con espressione un poco cupa bere dalla tazza di ceramica. Infondo, come si può essere cupi mentre si beve cioccolata calda? Non è tipo… impossibile?
«È che… sono in un gran casino…» Mattia tirò un sospiro preoccupato, cercando di celarlo con una risata forzata, senza successo. Scostò gli occhi dal liquido scuro e lo puntò nei miei, per dire, quasi disperato: «Credo di essermi davvero innamorato di te.»
Silenzio. Interrotto dal tintinnio del cucchiaino che mi scivolò di mano e andò ad impattare con il bordo della tazza, cadendo poi rovinosamente a terra, il tutto macchiando, nel suo percorso, tovaglia, il mio vestito e il pavimento.
Ma non me ne importava nulla. Non me ne accorsi neanche. Tutto quello che c'era nella mia testa era il vuoto più assoluto.
Quella era una dichiarazione, vero? Che avrei dovuto rispondere? Che anch'io ero innamorata? Ma che lo ero? Di certo mi piaceva, ma… amore? Non era una parola un po' grossa da spendere con qualcuno che conosci da poco più di un mese? Alla prima uscita poi? Non dovevamo almeno prima baciarci per capire se ci fosse stata chimica tra noi, prima di parlare di amore?
Ma poi, lui che intendeva per amore? Quello del colpo di fulmine? Dell'attrazione fisica? O del "per sempre felici e contenti" delle fiabe?
E soprattutto, il quesito più importante di tutti: ma perché cazzo mi stavo facendo tutte queste domande?
Ripresi coscienza di ciò che mi accadeva attorno quando con la coda dell'occhio mi accorsi di Mattia ai miei piedi, che stava pulendo il cioccolato a terra con dei tovagliolini di carta. Mi riscossi quel tanto che bastava per poggiargli le mani sulle spalle e fare per spostarlo: «Faccio io…» Ma lui mi guardò con quegli smeraldi sinceri e mi sorrise semplicemente: «Figurati, ho già fatto.»
Rimasi inchiodata al mio posto, mentre andava a buttare i tovagliolini sporchi e a pagare senza che nemmeno me ne accorgessi.
«Ti riporto a casa?»
Gli occhi mi scivolarono sulla sua mano tesa, la presi senza riflettere e non risposi, ancora incapace di formulare frasi più complesse di monosillabi. Quasi senza accorgermene, nel tragitto per arrivare alla macchina, strinsi la sua mano nella mia, come se ne dipendesse la mia salute mentale. Mattia doveva essersi accorto dello sballamento emotivo che mi aveva procurato, non era scemo, e non ne approfittò in nessun modo. Quando sentì la mia stretta farsi più forte, rigirò la mano nella mia per intrecciare le nostre dita e la accolse. Senza dire nulla, senza chiedere nulla.
A un certo punto mi venne spontaneo di guardarlo e la sua espressione mi sorprese: sorrideva, mentre guardava avanti a sé. Era quel tipo di sorriso di qualcuno che si era tolto un peso dalle spalle, di chi era pienamente soddisfatto di sé. Di chi era pronto a prendersi cura di un'altra persona, aspettarla se ce ne fosse stato bisogno, farla andare avanti e osservarla per tenerla con premura sott'occhio all'occorrenza. Il sorriso di qualcuno il cui più grande desiderio era quello di far star bene l'altro, anche a discapito di se stessi. Pareva quasi il sorriso di un genitore e, dovetti ammettere con amarezza a me stessa, che in quel momento mi sentivo veramente come una bambina indifesa al suo fianco.
Ma, stranamente, non avevo paura.
Era come se avessi la certezza di poter contare su di lui, che potevo fare completamente affidamento su Mattia. Lui era il giusto capitano in grado di far attraversare alla mia nave il mare in tempesta che erano state fino a quel giorno le mie emozioni, portandola dritta in porto, sana e salva.
Mi arrestai che eravamo quasi arrivati alla macchina, fermando anche lui mediante il collegamento delle nostre mani. Mi guardò un attimo interrogativo, io feci un passo in avanti, il corpo che si muoveva come fosse già Mattia ad avere il timone in mano, e lo baciai.
Questo capitolo non lo commento, non ora. Voglio parlare del rapporto tra Cam e Mattia ma non ne sono in grado senza spoilerare quel che accadrà (che poi che spoiler saranno mai, è palese come andrà a finire 'sta storia) quindiiii… le lascio in bianco a tempo determinato. Tornate una volta letto il capitolo 15.
Credo sia il 15… devo ancora dividerli in modo definitivo gli ultimi… ma penso proprio sarà il 15. Tanto ve lo scriverò poi alle note di quando sarà il momento di tornare (se vorrete, ovvio, non vi punto mica una lama al collo) a dare un’occhio qua.
Le scriverò qua perché all’adesso cap 15 ci sarà altro di cui vorrò parlare e soffermarmi, e rischierei di far diventare le note troppo lunghe e dovermi ritrovare a fare lo stesso lavoro fatto con Michelangelo e Leonardo e non ne ho davvero voglia lol
E non guardate lo schermo con quello sguardo confuso, tanto ve l’avevo già detto no? Autrice io, regole mie.
Bacini <3

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 13
*** Pagina 12 ***
Questo capitolo è un po' più lungo dei precedenti.
Sì, avrei potuto tagliarlo in modo differente e rendere tutto un po' più omogeneo.
No, non ho intenzione di farlo.
Però è molto... discorsivo, quindi non dovrebbe essere una palla totale da leggere.
Il fatto è che l'ultimo pezzo è stato praticamente il primo che ho scritto e mi rifiuto di cambiargli capitolo solo per un fattore di lunghezza. E' colpa di Aurora, che è arrivata decisamente dopo, che mi ha mandato tutto a bip. E poi ci sono un sacco di doppi-dialoghi a causa delle traduzioni... Sì. In realtà il chappy ha una lunghezza ragionevolissima, non fosse per questi due piccoli e insignificanti dettagli.
... Lasciatemici credere, vi prego. Ne ho bisogno.
Un'altra nota che tengo a fare è che da qui in avanti ci saranno pezzetti di Arkin dove il ragazzo e chi lo circonda parla in norvegese e, quindi come avvertito dall'inizio, ci saranno "doppi-dialoghi". Se non vi piace, vi attaccate amorevolmente <3
No dai scherzo, ho messo di grandezza diversa le traduzioni perché almeno sono più facilmente individuabili e, chi vuole, si salta la parte in lingua e si legge direttamente la parte in italiano.
PS: No, non sarebbe stato meglio mettere la parte in lingua con la riduzione, perché quella è quella effettiva e quindi ssssh, cuccia.
E anticipo scuse forse dovute, perché diventa anche un po' volgare, quantomeno rispetto a come io sono abituata a scrivere, però... Oh bimbi, quando ce vo', ce vo', eh!
E dopo questo ultimo avvertimento, buon proseguimento cari!
Pagina 12.
Tell me why are we wasting time
On all your wasted crying
When you should be with me instead?
I know I can treat you better
Better than he can
(Dimmi perché stiamo perdendo tempo
Su queste tue lacrime sprecate
Quando invece dovresti stare con me?
So che posso trattarti meglio
Meglio di lui)
– Treat you better, Shawn Mendes
“È stato tutto solo una splendida bugia...”
«Vi sees i morgen. (A domani.)»
«Vær mer forsiktig med takeaway-bestillinger! (Stai più attento agli ordini da asporto!)»
«Ja sir! (Sìssignore!)»
«Hei gutt, hvor er du? (Hey ragazzo, a che punto sei?)»
Alzai il capo a sentire la voce di mio zio che si rivolgeva, evidentemente, a me. Mi guardai un attimo spaesato intorno, il panno per pulire il banco ancora in mano, ma la mano immobile, accorgendomi solo in quel momento che i miei collaboratori erano già andati tutti via. «Har du det bra? Det er siden du kom tilbake at du virker rart for meg. (Stai bene? È da quando sei tornato che mi sembri strano.)»
Mio zio mi guardò perplesso, un'espressione quasi paterna. Non avevo da meravigliarmi, era da quando mi ero trasferito che quell'uomo si prendeva cura di me come fossi suo figlio.
Il più grande errore dei miei genitori era stato quello di regalarmi un viaggio di andata e ritorno per Arendal come regalo del 18esimo; peccato che il biglietto di ritorno io lo avessi fatto finire nel fuoco. Mi ero innamorato, non c'era molto da spiegare. Arendal mi aveva catturato il cuore e non aveva intenzione di lasciarlo andare. Appena avevo messo piede nella cittadina norvegese, mi ero sentito a casa; quando sentivo chiamare il mio nome nella sua lingua madre, era una delle sensazioni più belle del mondo.
Casa mia era la Norvegia, non potevo negarlo a nessuno, tanto meno a me stesso. Non era stato affatto arduo decidere di venire a vivere qui in pianta stabile, la parte difficile era stata convincere i miei. Ma appena finite le superiori, non avevano avuto molta scelta se non assecondare la mia. Tanto sarei partito comunque, con o senza il loro consenso.
Mentirei se dicessi che un poco di nostalgia per “mamma Italia” non si faceva sentire ogni tanto, ma più che per l'Italia in sé, se ci ragionavo a mente lucida, era per le persone e i legami che lì avevo. Per questo tutti gli anni tornavo da lei, un paio di settimane di ferie, non di più. Non me ne servivano di più. Eccetto quest'anno, per lei, per il passato che era tornato a fare capolino... Per tutte quelle questioni irrisolte che mi ero lasciato dietro, che avevo lasciato in Italia.
«Arkin!»
Mi riscossi e sbattei gli occhi più volte per tornare presente a me stesso, dopodiché guardai mio zio e cercai di fargli il sorriso migliore del mio repertorio. «Alt er bra. (Tutto benissimo.)»
«Er du distrahert, sikker på at du har det bra? (Sei distratto, sicuro di star bene?)»
«Helt sikkert, onkel. (Sicurissimo, zio.)» Oltrepassai il muretto basso che divideva la zona del forno a legna dalla sala con un salto e gli mostrai le braccia aperte e un sorriso. «Ser du? I god form! (Visto? In formissima!)»
Lui rispose storgendo le labbra. «Begynte du å røyke ved en tilfeldighet? (Hai iniziato a fumare per caso?)»
Scrollai le spalle. «Bare noen ganger, så mye for. Det er egentlig ikke noe alvorlig. (Solo qualche volta, così tanto per. Non è niente di serio, davvero.)»
«Stopp mens du fortsatt har tid til å redde deg fra vanen, gutt. Ikke gjør feilen til mange. Røyking er dårlig. Og så ødelegger det luktesansen og smaken din, du vil ikke lenger kunne smake på pizzaen. (Smetti finché sei ancora in tempo da salvarti dal vizio, ragazzo. Non fare l'errore di molti. Fumare fa male. E poi ti rovina olfatto e gusto, non sarai più in grado di assaporare la pizza.)»
«Ikke bekymre deg, jeg sa deg. Det er en triviell sak. (Stai tranquillo, te l'ho detto. È una cosa da nulla.)» Mi avviai verso l'uscita con passo svelto, camminando all'indietro e voltandomi solo arrivato alla porta.
Una volta fuori, mi affrettai a svoltare l'angolo e lì mi fermai. Chiusi gli occhi e inspirai a fondo per qualche secondo prima di riaprirli, concentrandomi solo sull'aria gelida di dicembre che mi riempiva i polmoni. “Sono distratto... Beh, in effetti sì... Non so come ho fatto a non bruciare ancora nulla...” Mi avviai verso casa, restando con lo sguardo sulla punta delle scarpe. “Sono distratto perché non riesco a non pensare a lei... A ciò che avrei voluto creare con lei...” Le mani si mossero in automatico, andando a cercare, trovare e accendere la sigaretta. Quasi non me ne accorsi di star assaporando la sua nebbia bianca. “Non è niente di che... solo un vizio temporaneo... Appena mi sarò dimenticato di Cam, smetterò anche di fumare. Già, dimenticarmi di lei… Ci riuscirò mai…”
Guardai in alto, il cielo notturno invernale di Arendal che mi aveva sempre un poco confortato quando la nostalgia di mamma Italia si faceva sentire. Ma non quella volta. Quella volta ebbi come la sensazione che le stelle mi stessero prendendo in giro, che la Luna fosse un sorriso malefico, divertito dai miei sentimenti a pezzi.
“Sono distratto un cazzo... Devo togliermi di testa questa bugia assurda di cui mi sono convinto.” Finii la sigaretta e la buttai fuori con un ultimo sospiro colmo di frustrazione, irritato dal sorriso doppiogiochista della Luna di quella sera.
«Al retone? A Febbraio?»
Inclinai la testa, confusa. Aurora mi rispose attraverso il cellulare con un sorriso che probabilmente le attraversava la faccia da orecchio a orecchio. «Sì, dai! È un’occasione per stare tutti insieme! Nella giornata vengono i parenti di Leo e i loro amici, ma dopo cena abbiamo la casa tutta per noi. Non sarebbe bello fare una bella pescata notturna a quattro?»
«Non sarebbe meglio se tu e Leo ne approfittaste per stare un po’ da soli, una volta tanto…» Chiesi, titubante.
«Ma no, figurati! Non ne abbiamo bisogno, il tempo per noi lo troviamo sempre in un modo o nell’altro, e poi a Marzo casa sarà pronta, passeremo tanto di quel tempo insieme che lo sveglierò alle 3 del mattino per farlo andare a pescare e togliermelo di torno per qualche ora. Mentre io e te ultimamente non riusciamo più a passare del tempo di qualità assieme.»
«Beh, quello è vero…» Mi grattai la testa, ancora indecisa. «Sento Mattia che ne pensa e ti richiamo, okay?»
«Ti ho dato due mesi di anticipo apposta. E semmai dovesse dire di no, convincilo con tutte le armi che hai!» Lo schiocco di un bacio mi arrivò dall’altra parte del microfono, prima che la chiamata terminasse. Appoggiai il telefono sul comodino accanto al letto e mi stirai, ancora leggermente indolenzita, quando Mattia rientrò in camera con due tazze di cioccolata in mano.
Si mise a sedere sul letto accanto a me e mi porse una mug, mentre sorridevo godendomi il profumo della bevanda.
«Mh… scotta!» Feci uscire la punta della lingua dalla bocca, cercando di farla freddare, facendole vento con la mano, quando sentii la risatina del ragazzo al mio fianco. «Guarda che brucia davvero!» Risi. Lui, per tutta risposta, portò le labbra a sfiorare la mia lingua e vi soffiò cauto. La sensazione del suo respiro fresco sulla lingua rovente mi fece attraversare il corpo da un’ondata di calore, e quegli occhi verdi mi incatenarono per un istante a loro. «Meglio ora?»
“Dio, quanto è sexy quando fa così.”
Annuì, chiudendo la bocca e distendendo le labbra in un piccolo sorriso. «Di un po’, ma sarà sempre così?»
«Così come?»
Alzai lo sguardo per riposarlo nei suoi occhi sinceri, la tazza ancora stretta tra le mani che tremavano appena. «Tutte le volte che abbiamo finito di fare sesso, mi porterai una cioccolata calda a letto?»
“Nemmeno quella istantanea, ma fatta sul momento da te… Sei troppo perfetto, dovresti essere illegale.”
Lui storse un attimo le labbra, facendo finta di riflettere: «Beh, dopo il sesso no. Però…» Bevve un sorso, posò la tazza sul comodino al mio fianco e unì le sue labbra cioccolatose alle mie. «Dopo aver fatto l’amore… in una fredda giornata di dicembre… perché no?»
“Confermo. Sei illegale.”
«Ah, prima che mi dimentichi... Ti va di andare a passare una notte al retone a pescare con Elsa e Leo l'8 Febbraio?»
«Certamente, volentieri.»
Lo guardai, non poco stupita della velocità con cui mi aveva risposto. «Davvero?»
«Ovvio. Mi piace un sacco passare il tempo con loro e, se a loro non da noia avermi tra i piedi per una nottata di pesca, io vengo più che volentieri.»
“Ma sei reale o un sogno?” Ebbi quasi voglia di piangere dalla gioia che provavo nel sentirgli dire che stava bene coi quelli che per me erano una sorella e un fratello. “Dio, se questo è un sogno, ti prego… Non farmi più svegliare.”
«Perché mi guardi così sorpresa?» Mi chiese, con un sorriso divertito.
«Io...» Posai la mug sul comodino, accanto la sua, non trattenendo un sorriso. «Elsa aveva detto di convincerti con tutte le armi che avevo in caso tu non fossi voluto venire.»
La sua espressione mutò per un attimo, guardò in basso, una mezza imprecazione sulle labbra che mi strappò una risata. Si buttò sul letto, mise un cuscino a coprirgli gli occhi e allargò le braccia.
«Che stai facendo?»
«Non voglio venire al retone. Nulla che tu possa dire o fare potrà farmi cambiare idea.» Esclamò, quasi offeso. Alzò il cuscino con una mano quel tanto che bastava per mostrarmi l'occhio e il sorriso giocoso che lo accompagnava: «Fai del tuo meglio per convincermi.»
Non potei fare a meno di ridere. Buttai il cuscino dall'altra parte della stanza e mi chinai su di lui, che sorrideva felice sotto di me.
Continuammo a baciarci, le nostre lingue che parevano non averne abbastanza dell’altro e continuavano a cercarlo, come fosse una gara ad acchiapparella.
La cioccolata freddò all’interno della tazza ma, per quanto potesse essere confortevole la sua dolcezza, non mi importava. La dolcezza che mi offrivano le braccia di Mattia, era mille volte superiore.
Inclinai svogliato la testa e lo sguardo mi cadde sul calendario che avevo alla parete.
Giovedì, 8 Febbraio 2019.
E io ero a letto che non avevo nemmeno voglia di farmi una sega. Il mio pensiero più impellente al momento era che quello fosse il mio primo giorno libero da non sapevo quanto e non avevo la più pallida idea di come passarlo. Ironia del cazzo.
Presi annoiato la sigaretta dal comodino e mi avviai alla finestra aperta, accendendola nel breve percorso. E la vista di Arendal innevata per un attimo mi fece sentire in pace con il mondo.
A quel punto dell’anno, solitamente, avevo già acquistato il biglietto per tornare da mamma Italia. D’altronde, da me le ferie si decidono nel mese di Gennaio.
Giusto qualche giorno prima avevo segnato due settimane solo perché mi ero ritrovato praticamente costretto a farlo, o mio zio mi avrebbe troncato il mattarello in testa. Diceva che da quando ero tornato stavo lavorando troppo. Non che avesse torto, ma non era colpa mia; il lavoro mi aiutava a non pensare.
E in quel momento, se c’era una cosa a cui non volevo pensare, era proprio il tornare in Italia.
Avevo segnato i giorni, più o meno sempre i soliti, ultima settimana di Marzo e prima di Aprile, ma non avevo davvero idea se sarei partito nel 2019.
Probabilmente li avrei spesi a sonnecchiare a letto, fumare un po’, bere un goccio o due… Visto dall’esterno, il programma che mi si prospettava era davvero triste. Ma non avevo né la voglia né le energie di divertirmi. Sarei potuto uscire, vedere di conoscere gente nuova, ma i fantasmi che mi venivano a trovare la notte non mi avrebbero più dato pace.
«Arkin, frokosten er klar! Beveg deg rumpa og gå av! (Arkin, la colazione è pronta! Muovi il culo e scendi!)»
Mi scappò un sorriso a sentire la voce di Svein salire per le scale. Era raro che fosse lui a preparare la colazione, evidentemente era di buon umore. “Ah già… Oggi è l’anniversario con Gersemi” Gersemi era il nome del suo jet.
Entrai in cucina e, ancora prima che potessi dire buongiorno, Svein storse la bocca. «Du har røkt. (Hai fumato.)»
«En. (Una sola.)» Gli rubai la mela di mano. Lui sospirò, accigliandosi e mormorando cupo: «Rommet ditt blir en skorstein… Kan du ikke virkelig kontrollere deg selv? Bytt i det minste til den elektroniske sigaretten. (Camera tua sta diventando una ciminiera… Non riesci davvero a controllarti? Quantomeno passa alla sigaretta elettronica.)»
«Jeg trenger ikke den elektroniske sigaretten, jeg stopper når jeg vil. (Non ho bisogno dell'elettronica, smetto quando voglio.)»
Un altro sospiro, sguardo truce. «Stopp så nå. (Allora smetti adesso.)»
«Jeg sa “når jeg vil”. (Ho detto “quando voglio”.)»
«Gjør det vondt. (Ti fa male.)»
«Gud hva en bummer… Hva gjør du, klarer dere alle den vanlige ødelagte rekorden? Jeg bryr meg ikke, ok? Drikke er også ille. (Dio che palle… Ma che fate, vi passate il solito disco rotto tutti quanti? Non mi interessa, okay? Anche bere fa male.)»
«Ja, snakker om å drikke… Vi må ha en tale om det også. (Sì, a proposito di bere… Abbiamo bisogno di fare un discorso anche su quello.)»
«Alvor? Når ble du mamma? (Seriamente? Da quand’è che sei diventato mia madre?)» Sbottai, a quel punto davvero stufo di quella storia. Non ero il primo ventenne a cui piaceva fumare una sigaretta ogni tanto e bere un goccio dopo il lavoro. «Pokker, alle behandler meg som om jeg stadig røyker, eller jeg er så full at jeg ikke kan jobbe. Eller narkotika. Jeg er helt klar, ok? (Diamine, mi trattate tutti come se fumassi costantemente, o fossi tanto ubriaco da essere incapace di lavorare. O drogassi. Io sono perfettamente lucido, okay?)»
«Nei, det er ikke "ok". Kanskje du ikke skjønner det, men bare fordi du takler alkohol, betyr ikke det at du må tømme en flaske vodka hver natt. Og lungene dine er lei av røyk. Og hvis vi alle forteller deg det samme, tror du ikke det er en god grunn? Jeg bor sammen med deg, jeg ser deg ødelegge helsen din den ene dagen etter den andre. Og ansiktet ditt har en dritfarge! Du har mistet 10 kg på mindre enn et år. Men sover du i det minste? (No, non è “okay”. Forse te non te ne rendi conto, ma solo perché sei in grado di reggere l’alcool non significa che devi svuotare una bottiglia di vodka tutte le sere. E i tuoi polmoni non ne possono più del tuo fumo. E se tutti ti diciamo la stessa cosa, non pensi ci sia un buon motivo? Io vivo con te, ti sto vedendo rovinarti la salute un giorno dopo l’altro. E la tua faccia ha un colorito di merda! Avrai perso 10kg in meno di un anno. Ma stai quantomeno dormendo?)» Ribatté lui, del tutto serio, incastrando la punta del coltello nel tagliere.
«Se, gjør det begge ødelegger seg selv. (Guarda che a fare così si rovinano entrambi.)» Mugolai io, ma lui non mi ascoltò nemmeno. Si appoggiò sul tavolo davanti a me, ma io scostai lo sguardo di lato per non vederlo. «Når vil du godta vår hjelp, Arkin? Det er tydelig at du har noe galt siden du kom tilbake. Det har gått måneder, vil du bestemme deg for å snakke, eller må jeg slå ham ut? (Quand’è che accetterai il nostro aiuto, Arkin? È palese che hai qualcosa che non va da quando sei tornato. Sono passati mesi, ti vuoi decidere a parlare o te lo devo tirare fuori a pugni?)»
Silenzio, pesante.
Mi alzai senza dire niente, lasciando il caffè non toccato freddare nella tazza.
Mormorai qualcosa quando ero già sulla porta. «Jeg går ut. (Io esco.)»
«Hey… Cami…»
«Mh? Ti sei svegliata?» Distolsi lo sguardo dal castello di carte di fronte a me, il lavoro della mia ultima ora e mezza abbondante, e lo posai sulla mia amica. «Secondo te…» Strinsi gli occhi, nella luce fioca della stanza, notando la voce spezzata e l’espressione di profonda tristezza dipinta sul suo viso. «I genitori di Leo sono tanto delusi?»
«Delusi?»
“O questa? Da dove viene?”
«Dal fatto che lui stia con me, e non con Giulia…»
«Ma di che diamine stai parlando?» Quasi saltai dalla sedia, ma la sua domanda mi aveva presa talmente di sorpresa che non riuscii a controllarmi. «Elsa, che ti passa per la testa?»
«È che… Leo e Giulia si conoscono sin da bambini, sono cresciuti insieme… Anche se poi si son persi di vista alle medie… Loro l’hanno vista crescere, la reputano come una figlia, dicono sempre che brava ragazza sia, di quanto sia bella… Dovevi vederli oggi… Mentre io sono un’estranea che è piombata in casa loro, così, dal nulla…»
La mia amica aveva la voce ferita, gli occhi colmi di lacrime, anche se queste ultime non avevano ancora cominciato a bagnarle le guance. Lasciò cadere il volto tra le braccia poggiate sul tavolo. «Forse… anche Leonardo sarebbe più felice con Giulia…»
«Aurora, ma che stai dicendo?»
“Tesoro mio, okay che hai bevuto una birra stasera, ma non è abbastanza per ridurti in queste condizioni.”
«Da dove vengono improvvisamente tutti questi dubbi? Ti hanno detto per caso qualcosa? Chi è stato?»
«Io… Non lo so… Nessuno mi ha detto nulla, è un’idea che mi sono fatta io… Riflettendoci…» Ed eccole, le lacrime. «I suoi genitori sono sempre stati angeli con me… Lo sai, li adoro… Però non riesco a fare a meno di pensare che avrebbero preferito che ci fosse Giulia al mio posto...» Aurora si portò i polsi ad asciugarsi gli occhi, tremante, quasi con rabbia. «Non lo so perché… Ma ho paura…»
Le gambe finalmente mi ubbidirono, facendomi alzare e trovarmi ad abbracciarla. «Paura di perdere Leonardo…»
La osservai lasciarsi andare a un pianto silenzioso e sofferto tra le mie braccia, incapace di trovare le parole per consolarla. “È assurdo… Che tu abbia questi dubbi, è assurdo… Ma da dove saltano fuori? Chi te le ha messe queste idee in testa… Davvero ci hai pensato da sola?”
Non mi era mai sembrata così fragile come in quel momento. Avevo la sensazione che si sarebbe spezzata se solo avessi provato ad accarezzarla. Persino uno sguardo sarebbe riuscito a mandarla in frantumi, in quel momento, perciò lo distolsi subito.
“Questa non è Elsa… Elsa è sempre solare, sorridente, ha un’energia capace di muovere le montagne… Questa ragazza, invece… Potrebbe rompersi con un semplice soffio di vento…”
E in quel momento, realizzai qualcosa che mi colpì come uno schiaffo in piena faccia: quella era Aurora. La ragazza che stava piangendo tra le mie braccia, quella persona così fragile e bisognosa di sicurezze… era la stessa che si alzava prima del sole per andare ad allenarsi, la stessa che si emozionava per un’immagine di un coniglietto random su internet, la stessa che a fine di una gara aveva l’energia di gridare al cielo e ridere ma non quella di riuscire a reggersi in piedi durante la premiazione. La stessa che viveva da anni una relazione che era il sogno di molti nostri coetanei e non.
Ed ebbi paura. Una paura folle che idee cretine come quella che mi aveva appena raccontato potessero davvero minare alla felicità che provava insieme alla sua anima gemella.
Aprii la bocca, per dire qualcosa, ma fui costretta a richiuderla subito, incapace di andare avanti.
«Se lo lasciassi e passassero del tempo insieme, allora col tempo lui potrebbe innamorarsi di lei e stare bene… Però…»
“Questo è autosabotaggio in piena regola…”
«Cami, devo essere una persona orribile, lo voglio per me… Io non lo voglio perdere…»
Mi morsi con forza il labbro, mentre sentivo qualcosa dentro crescere. Non riuscii a dargli un nome, era una sensazione che mi fece tendere i muscoli, desiderare disperatamente di riuscire a far passare quelle paure assurde alla mia migliore amica.
“Egoismo?”
Il suo dolore, quello che la stava tormentando in quel momento, lo volevo io. Volevo provarlo io, solo io, volevo che la lasciasse in pace e non le si avvicinasse mai più. Volevo che non la sfiorasse nemmeno.
“Forse avarizia…”
Non potevo permetterle di farsi questo. Non me lo sarei mai perdonato. Utilizzai quell’emozione senza nome per darmi la forza di far uscire la voce: «Sai, un tempo gli uomini credevano che l’essere umano fosse un essere perfetto e, soprattutto, completo. Era formato da quattro braccia, quattro gambe, due volti. Ma un giorno, Zeus, temendo la perfezione umana, lo divise in due, rendendolo così imperfetto… Incompleto. Da quel momento, l’uomo cerca disperatamente la sua metà, per tentare di ritornare al suo stato originario. Per tornare a essere completo.»
Aurora aveva smesso di piangere, ascoltando la mia storia. Strinsi un altro poco l’abbraccio, ora sicura che non l’avrei fatta andare in frantumi. «Non dirò a Leo quello che mi dai detto stanotte, ma tu credi davvero che lui possa voler stare con un'altra donna? Con un'altra persona? Leo?» Le sfiorai i capelli con un bacio leggero. «Leonardo darebbe qualsiasi cosa per te, e so benissimo che tu faresti altrettanto. Io credo davvero che voi siate due di quegli essere umani un tempo completi che sono riusciti a ritrovarsi, mettendola in tasca persino a Zeus.»
La percepii sorridere, e non potei che sorridere di rimando. Aurora si scostò leggermente e mi guardò negli occhi, con quelle sue due gemme color miele che scintillavano ancora a causa delle lacrime versate. «Grazie…»
In quel momento la porta della casetta si aprì, facendoci voltare entrambe. Era Leonardo, una mano dentro la tasca dei jeans, l’altra ancora poggiata sulla maniglia della porta. L’espressione non lasciava dubbi: aveva sentito. Non sapevo quanto, ma lessi nei suoi occhi la richiesta di lasciarli soli.
Lanciai un breve sorriso a Elsa e mi alzai, dirigendomi all’uscita. «Beh, io vado a vedere se abbiamo preso qualcosa.» Arrivata al fianco del mio “cognatino preferito”, gli diedi un piccolo pugno sul petto: «Non farla mai più piangere così, chiaro?» Non avevo bisogno che rispondesse, davvero, ma mentirei se dicessi che il suo sguardo tenero e il sorriso colmo d’affetto che mi regalò non mi fecero sentire più sicura.
Mi chiusi la porta alle spalle e feci per dirigermi al piccolo pontile, ma una forza invisibile mi inchiodò al mio posto, impedendomi di muovermi. “Diamine… Davvero, Idra? Vuoi seriamente essere così impicciona?” Senza rendermene pienamente, quasi, conto, mi ritrovai a nascondermi sotto la finestra aperta della casetta sul mare, a origliare i due piccioncini.
«Allora? Niente da dirmi?»
«È... Quanto hai sentito?»
«Abbastanza, direi… Più o meno da quando hai detto che se mi avresti lasciato, avrei vissuto una vita migliore con un'altra.»
«Quindi anche la storia di Zeus…»
«Pensi davvero che starei meglio con Giulia? Con una qualsiasi altra donna?»
«Oggi sì… poco fa l'ho pensato…»
«Lo sai che, se io e te ci lasciassimo, rischierei di diventare pazzo e mi metterei a tagliare ad accettate ogni albero del monte dietro casa mia per cercare di sfogarmi?»
«Mi dicesti che avevi fatto una cosa del genere una volta che eri stato mollato, prima di conoscere me…»
«Non è paragonabile a quello che potrei fare se fossi tu a lasciarmi. Aurora, mi dici chi ti ha messo quest’idea in testa? Sono stati i miei genitori? Mia madre? Mia sorella? Chi?»
«Nessuno, sono stata io.»
«Smetto di frequentare Giulia se ti fa creare tutti questi filmini mentali.»
«Cosa? No! No, non voglio! Adoro Giuli, mi piacciono le nostre uscite a tre! Mi piace andare a prendere il gelato in piazza e passare un po’ di tempo tutti e tre insieme.»
«Allora… cercherò di essere più freddo nei suoi confr… E non farmi quel broncino! Dimmi cosa devo fare per farti stare tranquilla, dico davvero.»
«Io… Tu non devi fare nulla, non voglio assolutamente che cambi, ti amo così come sei… Sono io che devo correggermi, questi sentimenti sbagliati sono i miei.»
«Okay… Sono i tuoi sentimenti e io non posso, e non devo voler, controllarli. E fin qui siamo d’accordo. Però ci deve pur essere qualcosa che posso fare per dimostrarti che sei tu la donna della mia vita… Che non voglio nessuna, ma te. Cazzo amore mio, stiamo per andare a vivere insieme, non posso permettere che tu entri in casina nostra con questi pensieri in testa. Dovrebbe essere uno dei momenti più belli della nostra vita, non posso lasciare che tu te lo rovini così, lo capisci, vero?»
Silenzio.
“Non promette bene, perché c’è silenzio? Perché Elsa non gli dice nulla?”
Attesi un’altra manciata di secondi, poi la situazione si fece davvero troppo pesante e mi feci coraggio per alzarmi quel tanto che bastava per spiare all’interno. Feci appena in tempo a intravedere con la coda dell'occhio il castello di carte, ancora eretto in tutta la sua magnificenza sul tavolo di legno, manco fosse fatto di pietra. Per fortuna, poco prima di avere i due nel campo visivo, riuscii a sentire la voce colma d’amore di Elsa: «Fammi sentire completa…»
“Completa? Intende per la storia di Zeus?” Strizzai gli occhi per impedirmi di vedere ancor prima di voltarmi, dando le spalle ai due. “Ooookay, questo è il segnale per darmela a gambe.” Mi mossi il più silenziosamente e velocemente possibile, dando ai due la privacy di cui avevano bisogno, e mi diressi alla cima del retone.
“Certo che Elsa non perde tempo…”
Lo scricchiolio delle assi del pontile sotto i miei piedi era l’unico suono che si udiva nella notte, accompagnata dalla melodia malinconica delle onde che accarezzavano gli scogli.
Sorrisi.
«Siete davvero fortunati ad esservi incontrati, bimbi…»
Alzai lo sguardo, ricordandomi solo in quel momento di Mattia. Era seduto al buio, rivolto verso il mare, la Luna pareva accarezzare i suoi ricci con la sua luce argentea. Non l’avevo mai visto così bello, ebbi improvvisamente voglia di dipingerlo.
Scossi la testa, rifiutando quel pensiero e ricacciandolo lontano ad ogni passo che mi avvicinavo a Mattia. Quando gli fui al fianco, mi accorsi che stava dormendo.
Inclinai la testa e avvicinai le labbra alle sue, sfiorandogliele appena.
«Non era il principe che svegliava la bella addormentata con un bacio?» Mi chiese in un sorriso, ancor prima di aprire gli occhi.
«Non sai che chi dorme non piglia pesci?» Risposi io, sorridendo e voltandomi verso l’acqua, verso la rete. Mi avvicinai al limite del pontile e mi appoggiai coi gomiti al recinto. «Letteralmente, in questo caso.»
Per un attimo, tutto quello che riuscivo a vedere e sentire era il rumore delle onde che si rifrangevano sugli scogli. “Nonostante sia pieno inverno, non fa troppo freddo per essere al mare… Stanotte anche il vento è calmo.”
Sarei potuta restare ad ammirare il movimento delle onde per ore. Amavo il mare d'inverno, ancor più che d'estate, quando era pieno di gente. E amavo il fatto che distanziava meno di un'ora da casa mia, così come la montagna, e le mie città d'arte Rinascimentali preferite. “Vivo davvero nel posto più bello del mondo…”
Una stretta mi attorcigliò lo stomaco. “Dannazione… ancora?” Mi portai la mano tra il giacchetto e la maglia, stringendo la stoffa. “Ho… voglia di dipingere…” Non sapevo bene perché, ma temevo il momento in cui avrei preso il pennello in mano, di vedere quello che mi avrebbe mostrato la tela. C’era una parte di me, cui mi rifiutavo con tutte le mie forze di dar spago, che voleva tornare ad emergere e prendere il possesso della mia vita da quando avevo rincontrato quel coglione di mezzosangue di vichingo. E io non gliela volevo dare vinta, cascasse il mondo. Forse perché avrebbe significato che non potevo essere felice con nessuno che non fosse lui, e mi rifiutavo di accettarlo.
Strinsi i denti, nel tentativo di convincermi ancora che non volevo, che dovevo farmi passare quel desiderio di intingere le dita nei colori, quando percepii le braccia di Mattia cingermi da dietro. “Se Zeus ha davvero diviso l’essere umano in due, la mia metà deve essere una persona che sappia come gestire le sue e le mie emozioni, mantenere sempre la calma e farmi stare bene… e far mantenere la calma a me… Qualcuno capace di regalarmi una vita in dolci tonalità pastello.” Chiusi gli occhi un istante, il nodo allo stomaco si sciolse pian piano e portai le mani alla sua nuca, come fosse la cosa più naturale del mondo. “E quella persona è ora al mio fianco.” Le sue labbra si intrufolarono nell’incavo tra il mio collo e la spalla, sfiorando appena la pelle.
«Sei stanco?»
«No, affatto. Potrei stare sveglio tutta la notte.» Sussurrò, lasciandomi una scia di baci leggeri sulla spalla. Sorrisi, godendomi i brividi che le sue labbra e il suo respiro mi procuravano, finché non si arrestò. Alzò una mano e la portò sulla mia guancia, facendomi voltare verso di lui, verso la Luna. «Sei bellissima. Non te lo dico abbastanza, ma è vero.»
Distolsi lo sguardo, imbarazzata, ma lui mi costrinse a riposarli nei suoi, prima di azzerare la distanza tra le nostre labbra.
Il turno quella sera era stato sfibrante, aumentato dal fatto che la notte precedente l’avevo passata in bianco a camminare per Arendal senza meta. Ero tornato a casa solo per farmi una doccia prima di attaccare a lavoro, stando attento a far coincidere il momento con il turno di lavoro di Svein, per evitare di incrociarlo.
Mi chiusi la porta alle spalle, lasciai cadere con noncuranza il giacchetto a terra e andai a buttarmi a peso morto sul letto, chiudendo gli occhi ancor prima di affondare nel materasso. Ero talmente distrutto che non ce la feci nemmeno a spogliarmi, addormentandomi in una manciata di secondi.
Il suono del telefono mi destò dal mio sonno affatto ristoratore, facendomi mugolare imprecazioni metà in italiano e metà in norvegese prima ancora di aprire gli occhi. Persi la chiamata 4 volte, prima di portare malvolentieri la mano alla tasca dei jeans e sollevare il cellulare fino all’orecchio, biascicando assonnato, con il volto sempre immerso nel materasso: «Hallo… (Pronto…)»
«Arkin, porca miseria sarà la decima volta che ti chiamo! Lo so che è presto e tu sei stanco, ma è importante. Lavati la faccia, svegliati e ascoltami!» Dall’altro capo del telefono, riconobbi a stento la voce di mia sorella maggiore, ma ero troppo sfatto per comprenderne al volo la sua preoccupazione.
Rotolai sul letto, mettendomi a pancia in su e lasciandomi andare in uno sbadiglio stanco e annoiato, mentre mi passavo la mano libera sullo stomaco. «Gemma… Ma che cazzo c’è… Sono stanco, non entro in casa da due giorni… Non ho voglia di stronz…»
«Si tratta di Camilla.»
Gelo.
D’improvviso, tutta la stanchezza svanì nel nulla e fui completamente sveglio. Mi tirai su a sedere con un colpo di reni, ma non feci in tempo a chiedere nulla che Gemma mi precedette: «È stata coinvolta in un incidente d’auto questa notte. È all’ospedale di suo pad…» Non la lasciai concludere, chiusi la chiamata; presi chiavi, portafoglio e uscii di casa a corsa. Non appena aprii la porta, mi ritrovai Svein davanti agli occhi, che rientrava da un turno notturno.
«Du er endelig tilb… vel? Hva er ansiktet? Ser ut som du så et spøkelse. (Finalmente sei torn… beh? Che è quella faccia? Sembra tu abbia visto un fantasma.)»
«Jeg må gå til henne. (Devo andare da lei.)»
Allora, un paio di appunti.
Il retone è questo:

Oltre che sugli scogli, la casina può benissimo essere sulla terra ferma, in riva al mare, e il retone è una decina di metri più in la su un pontile per essere usato. Praticamente uno lo affitta per un giorno o mezza giornata e, con un limite di persone che possono entrare nella piccola proprietà, tutto quel che vien fuori dalla rete è suo. E si mangia lì sul posto, o si porta a casa... indifferrente. Quel che pigli è tuo. Ovviamente ci sono di diverse tipologie, esempio con o senza giardino, il prezzo varia anche a seconda di quanto sia pescoso quel partiolare punto (ex. quelli in mezzo al mare come in foto costano MOLTO di più rispetto a quelli a riva, ma perché lì pigli roba seria, però solitamente non hai nemmeno il wc e devi arrivarci in barca, che non sempre è compresa nel prezzo... dipende uno che vuole fare).
Solitamente, almeno per come sono abituati nel mio nucleo di amici, il retone si prende più come scusa per passare una giornata al mare una volta l'anno con amici e parenti, con il pro di avere i bimbi piccoli divertirsi come matti a premere il bottone per tirarlo su e vedere i pesci che saltano. Ovviamente anche la stagione ne compromette il prezzo, d'estate hanno cifre assurdamente alte, legge domanda-offerta.
Gersemi (il nome che Svein ha dato al suo jet) deriva dalla mitologia norrena. Era la figlia di Freia e Óðr, e sorella di Hnoss. Come la sorella, era nota per la sua incredibile bellezza, che ricordava quella della madre, tant'è che tutte le cose preziose venivano chiamate con il suo nome. Svein ha un attacamento (giustamente) morboso per il suo jet e il suo paese (un po' in effetti, ora che ci penso, come tutti i pg di questa storia... forse li ho resi troppo patriottici), perciò gli ha dato il nome della divinità.
Un ultimo lo giuro appunto sullo "scoppio" di Elsa.
Quando una persona vive tutte le proprie emozioni in modo autentico e al 100% come la ragazza in questione, c'è il "rischio" che ogni tanto queste vadano fuori controllo e abbiano bisogno di "essere rimesse in bolla". Non è colpa di nessuno, il fatto che per un istante abbia avuto qualche dubbio sulla sua relazione non significa che volesse troncarla. Aveva solo bisogno di ritrovare il giusto equilibrio e dare il giusto peso alle cose, è questo il "compito" di Leonardo e, nel suo piccolo, anche di Camilla. Perché sono le due persone che la ragazza si è scelta da avere più vicino, che hanno accettato di starle accanto, anche se in modi differenti.
Se vi state chiedendo se allora non sia meglio non provare nulla, o far finta che i propri sentimenti siano inesistenti (come ad esempio Cam), allora... beh, qui non posso che dire la mia opinione super personale. Le emozioni devono essere vissute, non si può far finta che non esistano o non riconoscerle, perché tanto prima o poi queste saltano fuori. Ed è bene saperle riconoscerle e trattarle quando sono ancora "piccole" o comunque di una giusta intensità, anziché aspettare di... beh, esplodere, letteralmente. Io sono dell'idea che sia meglio aver provato e aver perso, piuttosto che non aver provato (o essersi convinti di non averlo fatto) per nulla. Come tutto, c'è solo bisogno di equilibrio. E quest'equilibrio è davvero difficile da trovare, sono super d'accordo, però... Poi la vita è fantastica, finalmente piena.
Aaah.... Era da Tra le belve che non facevo più così tante note... Sarò sincera, un po' mi era mancato.
Bella sensazione, liberato

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 14
*** Pagina 13 ***
Pagina 13.
(Ain't nobody hurt you like I hurt you
But ain't nobody love you like I do)
Non c'è nessuno a farti del male come te ne ho fatto io
Ma non c’è nessuno ad amarti più di quanto abbia fatto io
– Happier, Ed Sheeran
Uscii dalla macchina non ancora completamente arrestatasi e mi fiondai in ospedale alla velocità della luce, attraversando a corsa corridoi su corridoi.
Cercai di orientarmi con le indicazioni dei cartelli che vedevo di sfuggita, ma avevo il cervello completamente in blackout, perciò dopo poco fermai la prima infermiera che vidi. Le dissi nome e cognome di Camilla, quando era stata ricoverata e perché, stringendo la presa su quelle spalline esili che sembravano essere sul punto di spezzarsi nelle mie mani da un momento all’altro.
La giovane, probabilmente ancora studentessa universitaria e tirocinante, mi indicò esitante le scale, quasi terrorizzata dal mio tono e dal mio comportamento irrequieto, dicendomi di dirigermi al terzo piano e chiedere allo staff della desk. E se, per cortesia, potevo farlo camminando.
Non fece in tempo a finire di parlare, che avevo già imboccato la tromba delle scale e le stavo salendo quattro a quattro.
Arrivato in cima, feci come indicatomi e scoprii la camera della mia amica: la 14. “Assurdo, pare che la nostra vita ruoti attorno a 'sto numero.” Scossi la testa per scacciare quel pensiero: non era il momento.
Mi fiondai nella stanza, incurante dell’infermiera dietro di me che stava riprendendomi irritata, ordinando di attendere l’orario di visita; la ignorai, semplicemente.
Aprii la porta impulsivo, gridando il nome di Camilla, ma la voce mi morì in gola: «Ca…» Le mie sopracciglia quasi si unirono, da quanto corrucciate, nel vedere il ragazzo al bordo del letto dove si trovava la mia stella. Non potei fare a meno di guardarlo male, ancora bloccato sulla porta. «E tu chi cazzo saresti?»
Lui si accigliò, guardandomi male ma rispondendo con tono calmo e composto: «Chi sei tu, piuttosto.»
Non risposi, chinai appena la testa e la voltai verso il viso dormiente della mia amica, avvicinandomi a lei con passi lenti, mentre l'adrenalina cominciava a scemare. Anche lui seguì il mio sguardo, aggiungendo pacato: «A ogni modo, fa' silenzio per favore. Camilla deve riposare.»
Attraversando la stanza, con la coda dell’occhio notai la fasciatura al polso sinistro del tizio e il cerotto sulla fronte. Con una punta di nervosismo, aprii bocca e chiesi con il tono più tranquillo che riuscii a fare: «Com’è successo? Tu lo sai, vero?» Mi rispose senza distogliere lo sguardo da Camilla: «FIPILI, era tardi. Siamo entrati troppo piano e nel tentare di accelerare, la quinta non entrava. Ha guardato il cambio per mezzo secondo e abbiamo strusciato sul guardrail. Presa dalla paura, ha inchiodato… la macchina ha girato su stessa, attraversando la carreggiata, picchiato ancora.»
«Che cosa si è fatta lei?» Feci per allungare la mano e sfiorare la pelle di Cam, ma mi arrestai; con la coda dell’occhio vidi lui precedermi e accarezzarle la guancia, mentre sussurrava: «Solo, se così si può dire, colpo di frusta e due costole rotte… Ringrazio solo che non sia andata peggio, altrimenti non so cosa avrei fatto.»
Quella vista mi fece andare il sangue al cervello, sensazione negativa che venne solo alimentata ulteriormente dal nervosismo che avevo provato da quando Gemma mi aveva chiamato quella notte.
Per fortuna, in parte, venni distratto dalla vibrazione del mio cellulare. Guardai lo schermo e lessi il nome del mittente, il quale mi fece storcere la bocca e serrare con forza gli occhi. Prima di rispondere, guardai brevemente il volto di Cam e uscii dalla stanza.
Nemmeno il tempo di portarmi il telefono all’orecchio, che dall’altro capo udii la voce di Svein: «Arkin, tid utløpt, må vi gå. (Arkin, tempo scaduto, dobbiamo andare.)» Non risposi, premetti semplicemente le labbra tra loro, come per trattenere ciò che avrei voluto dire. Un sospiro dall’altra parte della cornetta e mio cugino aggiunse, con voce più calma e comprensiva: «Jeg beklager mannen, men jeg advarte deg. Du vil kunne holde bare noen få minutter. (Mi dispiace, ma ti avevo avvertito. Saresti potuto stare solo una manciata di minuti.)»
«Ja… Jeg kommer… (Sì… Arrivo…)» Sussurrai, abbassando la testa scoraggiato e terminando la chiamata.
Prima di chiudere completamente la porta della stanza d’ospedale alle mie spalle, rimasta socchiusa, lanciai un’ultima breve occhiata a Camilla e al ragazzo al suo fianco. Si era portato la mano di lei al volto e ne stava baciando delicatamente il dorso, come stesse cercando di risvegliarla dolcemente dal suo sonno. “Tanto non hai bisogno di me.” Pensai, chiudendo la porta con una morsa al petto e dirigendomi verso l’uscita dell’edificio.
“Questo odore…” Non appena aprii gli occhi, vidi Mattia al mio fianco che mi sorrideva dolce, la mia mano stretta delicatamente nella sua a pochi centimetri dalle labbra gentili.
«Ben svegliata tesoro mio.» Mi disse con un sorriso dei suoi, donandomi un altro bacio leggero sul dorso della mano. Non potei fare a meno di contraccambiare la sua espressione.
Tentai di alzarmi, ma un forte dolore al torace mi spezzò il fiato, facendomi nuovamente poggiare sul cuscino con una smorfia in volto.
Percepii la mano di Mattia accarezzarmi la guancia, mentre mi parlava con tono preoccupato: «Non muoverti, devi stare a letto finché le costole non ti si rimettono in sesto.»
Annuii brevemente, in modo distratto, ricordandomi in maniera molto vaga solo in quel momento del perché fossi in ospedale. Dopodiché, quando riuscii a respirare regolarmente, lo guardai meglio, notando il cerotto sulla fronte e la fasciatura al braccio: «Tu come stai?»
Lui mi sorrise gentile: «Non preoccuparti per me, sto benissimo. Sono già clinicamente dimesso, io.»
«Lasceranno andar via in fretta anche me, vero?» Sussurrai, un poco preoccupata, passandomi una mano sul volto. «Dove devo firmare?»
«Tu devi aspettare le lastre e il responso del medico, tesoro.» Mi sorrise dolcemente lui, facendomi imprecare tra i denti. Non vedevo l'ora di andarmene da lì, l'ospedale non faceva per me. E odiavo l'odore del disinfettante. Pregai solo che ci fosse Alberto di turno, almeno mi avrebbe dato una mano ad andare via da lì più in fretta possibile.
“Sono ancora qui solo per via di mio padre, altrimenti mi avrebbero dimessa già stanotte.” Tirai un sospiro infastidito, ma venni presto strappata via da quei pensieri. “Questo non è disinfettante.”
«Mattia... Non lo senti anche tu questo profumo?» Lui mi guardò con occhi interrogativi, inclinando appena la testa di lato. «Di che profumo parli?»
«Non so… È debole ma…» Chiusi gli occhi, per concentrarmi meglio sul senso dell’olfatto. «Sento un odore frizzante e fresco… come quello delle foreste di abete…» Un’improvvisa realizzazione mi fece aprire gli occhi di scatto. L’immagine di Arkin mi aveva appena sfiorato la mente. “No, non è possibile che sia il profumo di Arkin… Lui è in Norvegia adesso…”
«Camilla? Che hai?»
“Ma allora… Perché sento il suo profumo… Trauma cranico?”
«Camilla, ehi!»
“Come mai io…”
«Camilla!» Sentii il calore della mano di Mattia sulla guancia e quel contatto dolce mi riportò alla realtà. Alzai lo sguardo e lo incrociai con il suo, tanto vicino da poter vedere il mio riflesso nei suoi occhi. «Perché piangi?»
“Io… sto piangendo?” Non me ne ero nemmeno accorta. Il suo pollice andò a interrompere il percorso di una lacrima sulla guancia. Mi scostai, asciugai con il dorso della mano gli occhi, per poi tirare un sorriso e dirgli con il tono più tranquillo di cui ero capace, per evitare che si preoccupasse ulteriormente per me: «Sto bene, è solo il dolore delle costole per essermi alzata prima… Tutto qui...»
«Senti davvero così tanto dolore? Vuoi che ti chiami l’infermiera?» Mi chiese, seriamente preoccupato e con occhi da cane bastonato. Si era già alzato, ma lo fermai trattenendolo per la manica della camicia. «Per carità!» Gli risposi con un sorriso, stavolta sincero: «Nah, non importa tranquillo! Sono abituata a farmi male, questa è una cosa da nulla! Sono una pellaccia, io.» Mattia si sedette sul bordo del letto e io potei perdermi in quegli smeraldi, sentendomi subito meglio. Gli accarezzai una guancia e gli lasciai un bacio leggero sulla fronte, per poi guardarlo negli occhi con sicurezza: «Sto benissimo ora.»
«Idra!»
Aurora entrò in casa di mia madre con la forza di un uragano. Un uragano biondo pronto a spazzare via qualunque cosa si fosse frapposta tra lei e il suo obiettivo, ovvero io. Tutto, tranne Leo, il quale l’afferrò per il collo della maglia e la tirò indietro, permettendomi così di respirare.
«Ehi Cami, come và?» Mi chiese con uno dei suoi sorrisi speciali.
Adoravo Leonardo. Era un bravissimo ragazzo e se c'era una cosa che avevo sempre apprezzato di lui era la sua capacità di far sentire le persone a proprio agio, chiunque esse fossero. Un sorriso, una parola o un semplice gesto al momento giusto, nel modo giusto. Anche per questo era una delle poche persone che riusciva a bilanciare l'entusiasmo di Elsa, alle volte esagerato, ad aiutarla a tenere in check le sue emozioni.
Avevamo un rapporto strano, io e lui, cui non ero mai riuscita a dare un nome. Se avessi dovuto classificarlo in qualche modo, poteva essere un incrocio tra quello di un migliore amico e un fratello maggiore. Era un tipo di amicizia speciale, quella particolare tipologia che poteva nascere tra due persone che non provavano nessun tipo di attazione l’uno per l’altra, ma che si volevano comunque un mondo di bene, senza legami di parentela di mezzo. Avevo avuto tante amicizie maschili, soprattutto durante il periodo di canottaggio, ma con Leo c’era sempre stata questa sensazione diversa, quasi fosse qualcosa a pelle, anche prima che si mettesse con Elsa.
«Va’.» Risposi io in sorriso di rimando, risistemando la borsa dell'acqua calda sul collo, che l'abbraccio stritola ossa della mia amica aveva inevitabilmente spostato.
La nostra scimmietta bionda si espresse in una serie di mugolii rivolti al suo futuro consorte, che stavano a significare di lasciarla andare, dato che stava ancora venendo trattenuta a un passo di distanza. Leo acconsentì solo dopo essersi scambiato uno sguardo significativo con me e aver avuto la mia approvazione.
Elsa iniziò a invadermi di domande su cosa fosse accaduto, su come mi sentissi e cosa mi avessero prescritto i medici, come se non le avessi già raccontato tutto per telefono quello stesso pomeriggio. Il tutto intervallato da ringraziamenti a tutte le divinità che conoscevamo, al fatto che Mattia fosse con me e a insulti molto poco velati verso i costruttori di macchine, aggiungendo poi che non ce l'aveva con loro, ma che se fosse successo qualcosa lei per prima non avrebbe più guidato un'auto in vita sua.
Stava giusto iniziando a paragonare i cambi manuali ad altro di ben poco carino e inerente, quando il suono del campanello di casa ci fece voltare verso l'entrata di camera.
«È permesso? C'era la porta aperta…» Sulla soglia apparve Mattia, in mano un mazzo di girasoli, tulipani e papaveri, in volto un'espressione che avrebbe fatto innamorare chiunque. «Come ti senti?» Chiese titubante, fermo sulla soglia. Io, Elsa e Leo eravamo ancora a bocca aperta e con gli occhi sbarrati, quando aggiunse: «Posso… avvicinarmi?»
«Ma ci mancherebbe pure!» Rispose la mia amica per me, facendo tornare anche noi due alla realtà. Ancora colta dalla sorpresa dei fiori, notai Elsa dare una patta sul pettorale di Leo e la udii bisbigliare: «Com'è che te non mi fai mai regali del genere?»
Il suo compagno non fece in tempo a ribattere però, che le squillò il cellulare. Elsa non rispose, probabilmente era un numero sconosciuto. Intanto, Mattia si era avvicinato a me e mi aveva sfiorato la fronte con un bacio leggero, porgendomi il mazzo di fiori. «Come ti senti?»
«Devi stare tranquillo, sto bene.» Sorrisi, sinceramente felice delle sue attenzioni e dell'affetto con cui mi ricopriva. Mi faceva sentire al sicuro, oltre che un po' in imbarazzo. Ma avevo la sensazione che finché ci fosse stato lui al mio fianco, avrei potuto superare tutto con serenità, senza scenate madri di alcun genere. Era presto per pensieri del genere, stavamo insieme da pochi mesi, ma una piccola parte di me era sempre più convinta che al suo fianco avrei avuto una vita serena e tranquilla, stabile.
E quella tranquillità emotiva era una cosa che anelavo da sempre. “Chi non lo farebbe? Solo un pazzo…”
«Le costole come stanno? I medicinali funzionano?» Chiese, mentre gli facevo spazio per sedersi sul bordo del letto. E scostavo lo sguardo.
Sentii Leo soffocare una risata e lo guardai di sbieco, mentre l'espressione di Mattia diventava confusa. Il fidanzato della mia amica alzò lo sguardo e chiarì la situazione: «Deformazione sportiva.» Fece un gesto per indicare Elsa e me. «Queste due non prendono nemmeno il Polase, né bevono cose come il Gatorade. Non vogliono roba chimica che scorra loro nel corpo.»
«Io ogni tanto una birra posso anche farmela se sono con gli amici e il giorno dopo non ho gare o allenamenti mattutini pesanti, Idra nemmeno quello. Ma per entrambe l'uso di antidolorifici e antibiotici è ridotto per quando ci troviamo veramente in fin di vita.» Aggiunse Elsa, in tutta naturalezza.
Incrociai lo sguardo con Mattia. «Io e Elsa abbiamo avuto delle esperienze… particolari, e abbiamo convinzioni un po’ ortodosse su certi argomenti. Fuori dall'ideologia comune.»
Leo cinse le spalle della sua ragazza, mentre il sorriso di lutto le appariva sul volto.“In un certo senso… è come non fossimo ancora pronti a lasciarlo del tutto andare.” Sentii il nodo alla bocca dello stomaco stringersi, mi voltai verso il cielo oltre la finestra della mia stanza. “Non mi scorderò mai la visione di lui che ci manda a fare in culo, quando abbiamo cercato di fermarlo dallo spalare la mota dal pontile portata dal fiume, durante il ciclo di chemio… Mantenere vivo ciò che mi ha insegnato, è il mio modo di farlo continuare a vivere.”
Fuori il cielo era limpido, non vi era nemmeno una nuvola. Era lo stesso cielo di due anni prima. Io sapevo benissimo di essere stata graziata, salvata da un angelo in quell'incidente, forse anche due, e nessuno al mondo mi avrebbe tolto dalla testa che c'era anche il suo zampino in quel miracolo.
«Che palle!» Mi voltai verso la mia amica, la quale ributtava giù al cellulare per la terza volta.
«Sempre quel numero sconosciuto? Non puoi bloccarlo?» Le chiesi.
«Vuoi che risponda io?» Si offrì Leo, ma Elsa scosse la testa: «Se richiama un'altra volta rispondo e lo mando al diavolo.»
«Non potrebbe essere qualcuno che conosci che magari ha perso il telefono?» Chiese Mattia.
«Sì, con un numero extracomunitario? +47, ma che cavolo di posto è?» Esclamò lei in risposta. “Pubblicità internazionale?” Noi non avemmo la possibilità di aggiungere nulla, che il telefono riprese a suonare.
«Ah no, ora basta!» Elsa si alzò di scatto e andò alla porta, portandosi il telefono all'orecchio ed esclamando un seccato: «Pronto? Ma si può sapere chi cazzo sei?»
«La delicatezza…» Commentai ironica, ricevendo la risposta da Leo: «È comprensibile… È da questa mattina che riceve le chiamate dal solito numero.»
«Tutto il giorno?» Chiedemmo io e Mattia, in coro. “Certo che è strano…”
Lanciai un'occhiata alla mia amica, notando l'abbassamento innaturale delle spalle, i muscoli del trapezio quasi tremare da quanto tesi, la mano libera stretta a pugno tanto da far sbiancare le nocche. “Qualcosa non và, Elsa è furiosa.” Una breve occhiata a Leo mi fece intuire che anche lui aveva visto ciò che avevo avvertito io.
La seguii con lo sguardo mentre usciva dalla porta senza dire nulla, né voltarsi, il telefono sempre all'orecchio.
«Stai tranquilla.» Mi voltai verso Leo, che mi sorrideva rassicurante. «Fosse successo qualcosa di grave, saresti la prima a saperlo, sai che Aurora non ti terrebbe nulla nascosto.»
Tentai di sorridere, sapendo che diceva il vero, e lo sguardo mi cadde sui fiori che aveva portato Mattia. «Hey! Dobbiamo trovare un vaso in cui metterli! Subito!»
Passando davanti la porta finestra per andare in sala a prendere un contenitore adatto, incrociai lo sguardo con quello di Elsa, fuori sotto il porticato. Le sorrisi contenta, alzando le mani per mostrarle il vaso che eravamo andate a comprare insieme qualche tempo prima, colmo di colore e profumo grazie ai fiori di Mattia. Vidi le sue labbra distendersi in un sorriso colmo d'affetto, quasi materno, dire qualcosa al microfono del telefono e riagganciare.
Quando varcò la soglia per tornare da me, non ebbi bisogno di chiederle nulla: i suoi occhi color miele erano sereni, e questo mi bastava.
«Pronto? Ma si può sapere chi cazzo sei?»
«Björn.» Dall’altro capo del telefono calò il silenzio. Ma non era affatto un buon silenzio: quasi mi pareva di sentire i denti di Aurora scricchiolare per l’ira. Nel poco tempo che avevo avuto per conoscerla, avevo ben compreso che fosse un carattere abbastanza simile al mio: molto fumino, che basta un nonnulla per far accendere la fiamma e farla incazzare. Peccato che, in quella situazione, io rappresentavo una gettata di benzina del calibro da far scatenare un vero e proprio incendio.
Ne ero perfettamente consapevole, ma d’altronde non avevo potuto resistere: dovevo sapere come stava Camilla, altrimenti sarei impazzito. E Aurora era il mio unico tramite.
Feci un respiro profondo e cercai le parole più giuste per non far scatenare l’incendio: «Immagino che mi odi e non posso darti torto per questo. Io stesso mi odio per come ho trattato Cam e…»
«Che cosa vuoi, Arkin.»
Un altro sospiro, dovevo riuscire in tutti i modi a controllare la voce. Non potevo permettere che ne percepisse il tremore. «Voglio solo sapere come sta Cam… Tutto qui…»
«Hai saputo? Come hai fatto?»
«Mia sorella è volontaria della misericordia. C'era lei in ambulanza quando l'hanno portata in ospedale l’altra notte.»
Dovetti attendere un po’ la risposta. «Camilla sta bene. Adesso è a casa e non appena le costole si saranno rimesse, sarà come non fosse successo nulla.»
La tensione parve scorrere via dal mio corpo tutta insieme, lasciandomi uno strano senso di leggerezza addosso. Parvi come sciogliermi sulla sedia. Mi passai una mano sul volto e ringraziai il cielo e tutte le divinità, passate, presenti e anche quelle future.
Raccolsi tutto il coraggio che avevo e, con il nodo alla gola tornato a farsi prepotente, chiesi: «È felice?»
Quei secondi che attesi la sua risposta mi parvero non finire più. E forse non avrebbe potuto dire altro per farmi stare peggio: «Sì, lo è. È circondata da persone che le vogliono bene e che non la farebbero mai soffrire.»
Lei chiuse la chiamata, io affondai il volto nelle mani. Le lacrime si riunirono sui palmi. Le dita si chiusero in un moto di rabbia e il braccio si mosse da solo, andando a buttare a terra tutte le bottiglie di alcool che avevo sull'isola della cucina, il frastuono di vetri rotti venne accompagnato dal mio grido.
Iniziai a prendere a pugni il pavimento, nel vano tentativo di sfogarmi, la vista annebbiata dalle lacrime e la testa completamente in tilt dal dolore e l'alcool che mi scorreva in corpo.
Mi accorsi di Svein solo quando mi trovai le sue mani a stringermi i polsi, tenendoli lontani dalle mattonelle ormai a chiazze color cremisi.
«Rolig, Arkin! Hva faen skjedde? (Datti una calmata, Arkin! Che cazzo è successo?)» La sua voce mi pareva distante anni luce, percepivo tutto in modo troppo ovattato. “Dimenticare... La devo dimenticare...” L'unica cosa che mi diceva la testa era di sfogarmi, in qualsiasi modo, per cercare di far tacere il cuore una volta per tutte.
Svein alleggerì appena la presa sui miei polsi quel tanto che bastò per farmi voltare verso di lui. Gli strinsi la maglia dell'uniforme al petto, guardandolo disperato, senza sapere cosa dire.
«Ta ut øynene mine… (Cavami gli occhi…)»
“Non voglio più vedere niente... Non voglio più avere a che fare con niente... Liberami dai miei occhi...”
«Hva… (Cosa…)»
«Du kan gjøre det... Du vet gjøre det! Ta ut disse forbannede øynene! (Tu puoi farlo... Tu sai farlo! Cavami questi maledetti occhi!)»
“Liberami da questi zaffiri che mi ricordano lei, di Paolo... Che mi sbattono in faccia il mio passato e quel maledetto dolore...”
Chinai il capo, ancora in ginocchio. «Hver gang… hver gang jeg ser i speilet, ser jeg de tre barna leke lykkelig sammen ... Jeg ser Paolo livløs i armene mine… Jeg ser Camilla gråte og gå bort fra meg… (Ogni volta... ogni volta che mi guardo allo specchio, vedo quei tre bambini che giocano felici assieme... vedo Paolo senza vita tra le mie braccia...vedo Camilla che piange e se ne va da me…)»
“Liberami dalla loro maledizione.”
«Jeg ser dem nedsenket i de hvite sykehus- og likhusteppene... hånden min prøver å berøre dem… men… kan ikke klare det… (Li vedo immersi in quelle coperte bianche d’ospedale e d’obitorio… la mia mano che cerca di sfiorarli… ma... non ci riesco…)»
“Perché non li posso raggiungere?”
Mi portai le mani sanguinanti al volto, a coprirlo. «Det er deres feil hvis jeg ser alt jeg elsker å forlate meg… Jeg tåler dem ikke lenger… (È colpa loro se vedo tutto ciò che amo andarsene da me... Non li sopporto più…)» Infilai le unghie nella pelle, come per lacerarla, ma Svein mi fermò, prendendomi nuovamente i polsi e allontanandomi le mani dalla faccia. Mi guardò e, con tono fermo, affermò: «Du er full, Arkin. Skaff deg bakrus, så kan vi snakke om hvorfor du ødela hele dette alkoholkammeret i dette huset (Tu sei ubriaco, Arkin. Fatti passare la sbronza e poi possiamo parlare del motivo che ti ha fatto distruggere l'intera dispensa di alcool di questa casa.)»
“Sì... È vero, sono ubriaco... Ma non è colpa dell'alcool.”
Mi mossi con un moto di stizza per cercare di liberarmi dalla sua presa, senza avere successo. «Ikke gjør det, lille kusine. Du kan ikke slå meg mot meg, det vet du veldig godt. (Non farlo, cuginetto. Non puoi vincere contro di me a botte, lo sai benissimo.)»
Con un velo rosso dovuto nemmeno io so a cosa, gli assestai una ginocchiata all'addome, nel tentativo di liberarmi. «Jeg vil at du skal bringe disse jævla øynene til meg! (Voglio che mi cavi questi maledetti occhi!)»
Lo sguardo di ghiaccio di Svein si incrociò con il mio, troppo ubriaco per accorgermi che mio cugino fosse entrato in modalità militare d'élite.
Un pugno.
Un suo solo pugno. Bastò per stendermi, e farmi perdere i sensi.
Devo essere una persona davvero sadica, mi è piaciuto un mondo scrivere queste scene di Arkin, soprattutto quelle che vengono da qui in poi.
In effetti, ci sono già stati molti indizi passati che avrebbero dovuto farmi arrivare a questa conclusione.
Una volta un'amica mi disse che, più un autore tende a far soffrire un suo personaggio, più significa che gli vuole bene. Secondo questa teoria, io dovrei essere follemente innamorata di un sacco di miei pg.... il che non è propriamente falso, ma comunque... Un certo Arni e un certo Egil, in particolar modo, avrebbero parecchio da dire a riguardo. Forse dovrei semplicemente smettterla di amare i miei personaggi, in questo modo, forse, potrei dar loro delle vite più semplici.
...Nah!
Ora che ci penso, può anche benissimo darsi che, per questo caso specifico, sia il fattore lingua norvegese che mi emozioni mentre scrivo. Cioè dai, provate a leggerla... Non è una lingua meravigliosa? E' bellissima. Dev'essere, anzi lo è sicuramente, merito suo se le parti di Arkin in Norvegia sono le mie preferite dell'intero racconto.

      p.s.
Era tanto che volevo dare un pungno ad Arkin. Svein ha realizzato questo mio desiderio. Grazie Svein.
p.s.
Era tanto che volevo dare un pungno ad Arkin. Svein ha realizzato questo mio desiderio. Grazie Svein.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 15
*** Pagina 14 ***
Pagina 14.
I'm sitting with an empty glass
and a broken heart,
Thinking to myself what have I done,
Cause as my future got bright
we started losing light,
And I couldn't see that you were the one
Take take take me back,
I wanna go back,
Back to what we had!
Do you remember when
we started this mess,
My heart was beating out of my chest!
(Sono seduto con un bicchiere vuoto
e un cuore spezzato,
Pensando a me stesso, cosa ho fatto,
Perché quando il mio futuro è diventato luminoso
abbiamo iniziato a perdere la luce,
E non ho potuto vedere che eri tu
Prendi, portami indietro
Voglio tornare indietro,
Tornare a quello che avevamo!
Ti ricordi quando
abbiamo iniziato questo casino,
Il mio cuore batteva fuori dal petto!)
– Remember when, Chris Wallace
«Mh. Sì… non preoccuparti, va tutto bene. Mh. Okay. Okay. D’accordo, ci sentiamo stasera… Buon lavoro…»
Chiusi la chiamata e tirai un respiro profondo, mentre osservavo il nome sullo schermo del cellulare per quei pochi secondi prima che tornasse la schermata della home: “Padre”. Non ero mai riuscita a memorizzarlo con altro nome, a diminuire quella distanza che sentivo sempre quando ero al suo fianco.
Ovvio che dall’ospedale lo avessero chiamato immediatamente quando si erano accorti fossi io. Sia mai che il ricovero non necessario della preziosa bambina del Primario potesse passare senza che il padre lo sapesse.
Ero ben cosciente del pericolo che avevo corso ed ero riconoscente a Mattia per aver chiamato il 118, ma… “La strigliata telefonica dal paparino me la sarei risparmiata volentieri, ecco.”
Mi lasciai andare sul letto, chiudendo gli occhi dopo pochi secondi e portandomi la mano sulle costole, dove faceva più male. Dopo una breve imprecazione, rilassai i denti e risollevai le palpebre, nel campo visivo solo il soffitto chiaro di camera di casa di mia madre, nella mano libera ancora il cellulare.
Ripensai alle ultime conversazioni avvenute, riflettendo su quando mio padre fosse umanamente cambiato da quando i suoi genitori erano morti. Una parte di me era rimasta incredula dal fatto che fosse rimasto del tutto indifferente quando gli avevo detto, con non poca fatica, del danno della macchina, che era da rottamare. La strigliata, me l’ero presa più per aver pensato che potesse importargli più delle condizioni dell’auto che del fatto che fosse sinceramente preoccupato per me.
“Devo essere una figlia davvero orribile per pensare una cosa del genere del proprio padre…” Non volevo fargli male, non volevo che pensasse che non gli volevo bene, perché gliene volevo, tanto… sicuramente molto più di quello che ero disposta ad ammettere. “Abbiamo sempre avuto un pessimo tempismo, noi due…”
In passato, ricordo con chiarezza che c’erano stati momenti in cui avevo cercato il suo affetto e questo mi era stato negato, nella maggior parte delle volte a causa del lavoro e “rigorosità professionale da mantenere in x ambienti”, così l’aveva sempre giustificata lui. E c’erano anche stati molti momenti in cui invece era stato lui ad aver cercato il mio di affetto, che gli avevo puntualmente negato, perché la mia emotività me lo aveva in qualche modo impedito. Non ci siamo mai trovati, io e mio padre, in quanto a scambi d’affetto.
Però, quando avevo avuto bisogno di lui, c’era sempre stato. A modo suo forse, sicuramente, ma c’era sempre stato. E nonostante quello strano tipo di rapporto che avevamo, anch’io volevo sempre esserci per lui, nel caso avesse avuto bisogno. Perché gli volevo bene, anche se non ero mai stata in grado di capire se l’amore che provavo nei suoi confronti fosse quello che una figlia deve al padre, in quanto genitore, oppure fosse puro e semplice. Ma poco mi importava, lui aveva contribuito a mettermi al mondo, aveva in un modo o nell’altro contribuito a farmi crescere, e questo mi bastava come “scusa” per volergli essere vicina.
Alzai la mano, il palmo aperto, e mi incantai della luce che mi attraversava gli spazi tra le dita. E il resto del mondo svanì come per magia. “Questo corpo è fantastico… Nonostante tutto quello che gli ho sempre fatto… Nonostante tutte quelle volte che l’ho massacrato, continua imperterrito a lasciarmi vivere… A non abbandonarmi, a proteggermi… E non mi chiede niente in cambio.” Una piccola fitta alle costole, dovuta a un respiro di maggior portata, mi costrinse a mordermi il labbro e tirare un sorriso. «Beh. A parte riposarsi ogni tanto…» Lasciai cadere la mano e mi girai su un fianco, accoccolandomi in una posizione che mi risultasse comoda. Avvicinai la mano al petto, sentendo il cuore battere dietro la pelle, e mi lasciai cullare dalla sua ninnananna.
«Grazie…»
A farmi riacquistare i sensi fu la fitta alla testa. Mi portai le mani alle tempie, come riflesso automatico, credendo ignorantemente che stringere il cranio avrebbe alleviato il dolore.
«Du våknet? (Ti sei svegliato?)»
La voce calma di Svein mi arrivò alle orecchie, ma il cervello non riusciva ancora a connettere.
Tentai di rispondere, col solo risultato di farfugliare parole incomprensibili persino a me stesso, mentre cercavo di aprire gli occhi e tentavo di capire in che posizione fossi. Sdraiato? Seduto? In piedi? In ginocchio? Impossibile dirlo, la testa girava come una trottola, tant'è che dovetti poggiare le mani a terra, cercando una stabilità che però non arrivò. “Ma che… Perché gira tutto così velocemente? Dove cazzo sono…”
«Det er aldri bra å bli slått ut, spesielt når de er full, fortalte de deg aldri? (Non è mai bene finire KO, soprattutto da ubriachi, non te l'hanno mai detto?)»
“Ubriaco…”
Cercai di ricordare le ultime 24h… niente. Il vuoto più totale. Strano, non avevo mai avuto problemi a ricordare, anche il più piccolo dettaglio. Anzi, il mio problema più grande era sempre stato l’essere incapace di dimenticare.
Rammentavo di aver staccato tardi da lavoro e essere crollato sul letto, poi era tutto un miscuglio di strane sensazioni e nero. E dolore.
Una fitta improvvisa al petto mi fece portare una mano a stringere la maglia all'altezza del cuore, e in quell'istante, come una scarica elettrica, il dolore si trasferì agli occhi. Mi sarei mosso per portarmi le mani al viso, ma i polsi mi vennero bloccati saldamente da mio cugino. «Ikke tør du. (Non ti azzardare.)»
In quel momento provai ad aprire lo sguardo e, oltre a sentire come le palpebre incrostate e la luce che mi accecò per lunghi secondi, vidi Svein tanto serio da far paura.
«Bravo, så. (Bravo, così.)» Lentamente mi accompagnò le mani, abbassandole, e si mise un mio braccio attorno al collo, facendomi mettere in piedi con cautela. «La oss gå i sofaen og snakke en stund, ja? (Andiamo sul divano e parliamo un po', sì?)»
Nel breve tragitto, con gli occhi ormai abituati alla luce, mi guardai esitante intorno. “Sembra sia passato un tornado qui dentro…”
«Hvordan føler du deg? Kan du snakke? (Come ti senti? Riesci a parlare?)»
Svein mi allungò del ghiaccio avvolto in un panno, picchiettandosi la mascella come muto sprono. Ubbidii, inizialmente esitante, ma non appena il gelo mi sfiorò la pelle un'altra fitta mi ammazzò quelle cellule cerebrali rimaste integre.
Mi ci vollero un paio di minuti buoni per essere in grado di parlare: «Hva... hva skjedde her inne… (Che… cos'è successo qui dentro…)»
«Mens jeg var ute, ble du full og ødela halve huset, for ikke å snakke om hendene dine. (Mentre ero fuori, ti sei ubriacato e hai distrutto mezza casa, per non parlare delle tue mani.)» Mi osservai un attimo le estremità degli arti superiori, notando solo in quel momento che erano avvolte in fasce mediche. “Ma che cazzo…”
«Og hvorfor skulle jeg gjøre det… (E perché l'avrei fatto…)»
«Vi vil (Beh)» Svein si stese in avanti, poggiando i gomiti sulle ginocchia, con un sospiro pesante. «Det er det jeg også vil vite. (È quello che vorrei sapere anch'io.)»
Una scintilla si accese in testa. «Vent litt, hva er klokka? Jeg må gå på jobb… (Aspetta un attimo, che ore sono? Io devo andare a lav…)»
«Sitt stille. (Stai seduto.)» Svein mi fece riappoggiare sul divano, mettendomi le mani sulle spalle. «Jeg har allerede ringt onkelen min og sagt at du ikke kan gå i dag fordi du er for syk. (Ho già chiamato lo zio e gli ho detto che oggi non puoi andare perché stai troppo male.)»
«Jeg er ikke s… (Io non sto mal…)»
«Og vet du hva han fortalte meg? (E lo sai che mi ha detto?)» Osservai mio cugino, non certo di voler sapere la risposta. Lui si sistemò meglio sulla poltrona davanti a me. «Det var på tide at han innrømmet det. (Era l'ora che lo ammettesse.)» Alzò la mano aperta. «Fem dager, men når du kommer tilbake, har du kommet tilbake til deg selv. Eller i det minste vite hvordan du kommer deg på sporet igjen. (Cinque giorni, ma quando rientri che tu sia tornato in te. O quantomeno sappia come tornare in carreggiata.)»
Mi scappò una piccola risata, più per la disperazione che altro, dopodiché rialzai lo sguardo e vidi gli occhi di Svein, quelli non di un cugino, ma di un fratello maggiore. Mentirei se dicessi che in quel momento sarei riuscito a rifilargli qualche cretinata ben congeniata, non si poteva mentire a quegli occhi.
«Hva skjedde, Arkin? (Cos'è successo, Arkin?)»
Prima ancora di riuscire a ricordare, a parlare, sentii le lacrime che avevano già iniziato a scendere calde sulle guance. Mi ci volle un po’ per riuscire a formulare la frase.
«Tenker du noen gang på fortiden? (Tu ci pensi mai al passato?)»
«Ikke egentlig ... Når du flyr, må du se frem til deg. (Non proprio… Quando voli devi guardare avanti a te.)»
Tirai un sorriso. «Du er virkelig en elitesjåfør, ikke sant? (Sei proprio un pilota d’elite, eh?)»
«Å fly er mitt liv, vet du. (Volare è la mia vita, lo sai.)»
«Svar deretter på dette: Har du noen gang angret? (Allora rispondi a questo: hai mai avuto dei rimpianti?)»
Svein rifletté qualche secondo prima di rispondermi. «Ja. Men jeg tror alle har angrer. (Sì. Ma penso che tutti abbiano dei rimpianti.)» Lo guardai un attimo, un poco confuso perché non certo di capire quello che volesse dirmi: «Hvis du ikke angrer på det du har gjort, betyr det at du ikke har endret deg fra fortidens du. Det betyr at du ikke har vokst opp. Og det å ikke vokse opp er ikke hyggelig, Arkin. Det er ikke hyggelig å forbli barn for alltid, det er en utopi. (Se non rimpiangi nulla di ciò che hai fatto, significa che non sei cambiato dal te del passato. Significa che non sei cresciuto. E non crescere non è bello, Arkin. Non è bello rimanere per sempre bambini, è un’utopia.)»
Chinai il capo, i gomiti poggiati sulle ginocchia e le mani sotto di me strette tra loro. Cercai di trovare le parole più giuste per cercare di fargli capire quello che avevo in testa. «Hva om ... Angrene dine ikke var knyttet til deg ... men til noen andre … (E se… I tuoi rimpianti non fossero collegati a te… ma a qualcun’altro…)»
Fu il turno di mio cugino a guardarmi confuso.
«Hvis man angrer på hva han gjorde fordi han skadet seg, kan jeg forstå det. Jeg kan ... tilgi. Men når angrer bekymrer noen andre ... Hvordan tilgir du deg selv når handlingene dine har fått andre til å lide? Da ... de drepte dem … (Se uno rimpiange ciò che ha fatto perché ha ferito se stesso, lo posso capire. Lo posso… perdonare. Ma quando i rimpianti riguardano qualche d’un altro… Come fai a perdonarti quando le tue azioni hanno fatto soffrire gli altri? Quando… li hanno uccisi…)»
«Hva mener du… (Che vuoi dire…)»
Udii il me tredicenne che convinceva i genitori di Paolo a farlo venire al raduno. Lo vidi che gli lanciava il pallone durante la finale. Lo sentii pensare di minacciarlo di fare goal perché altrimenti non gli avrebbe più parlato.
Lo vidi osservare la palla entrare in rete, mentre Paolo cadeva a terra, davanti ai suoi occhi, dalla quale non si sarebbe più rialzato.
Mi portai le mani al volto, non cercando di fermare le lacrime o modulare la voce. Sarebbe stato uno sforzo inutile. «Jeg drepte min beste venn. (Io ho ucciso il mio migliore amico.)»
E da lì le parole furono come la piena di un fiume che frantuma i suoi argini.
Aurora entrò in casa di soppiatto, avendo evidentemente paura di svegliarmi. Me la ritrovai che faceva capolino dall’entrata di camera: «Ma non stai dormendo.»
«Nope. Mi sono svegliata da poco, però, se ti può essere di consolazione.»
«Sarà meglio.»
Sorrisi, battendo la mano sul bordo del letto come incoraggiamento per farla venire a sedere. Lei non se lo fece ripetere due volte.
Il fatto che fosse entrata senza bussare non era una cosa strana, entrambe avevamo le chiavi delle case dell’altra, da anni ormai. Ce l’eravamo scambiate quando ci allenavamo insieme, per poter andare dall’altra la mattina presto senza dover suonare cellulari o campanelli, nel caso non avesse sentito la sveglia delle 5 per andare a correre. Non era mai stato un problema per i suoi genitori e, per quanto riguardava me, in casa di mia madre vivevo da sola 9 mesi l’anno visto che lei era insegnante di italiano in Inghilterra; e casa di mio padre erano almeno in dieci ad avere le chiavi, una in più o in meno, soprattutto se persona fidata come Elsa, per cui lui stravedeva, non cambiava di certo nulla. E poi non abusavamo mai delle chiavi dell’altra, com’era giusto che fosse.
«Ti ho portato delle lasagne con gli asparagi del monte dietro casa di Leo, del cinghiale in umido e delle rape. Sono buone, hanno preso il ghiaccio degli ultimi giorni e sono venute belle speciali.» Prese il tavolino da letto e iniziò ad apparecchiare, sotto il mio sguardo affascinato e incredulo.
«Sarai un’ottima nonna.»
«Non sono ancora mamma. E lo sai che queste cose non le ho cucinate da sola.» Rispose lei con un sorriso e una lieve carezza sulla nuca. «Come ti senti?»
«Sto bene…» Mugolai, mettendomi una fetta di lasagna in bocca.
«Ma?» Chiese lei, impossibile non intuisse il mio non detto. Mi conosceva troppo bene.
«Ma nulla… Ho sentito ora mio padre.» Tagliai corto. Elsa mi accarezzò la guancia e mi sollevò il mento, alzandomi lo sguardo. Dio, quanto amavo quelle due pozze di miele in quei momenti, mi ci sarei voluta immergere e assimilare tutta la loro dolcezza. «Stai bene?»
Amavo il fatto che non mi avesse chiesto di cosa avessimo parlato, che non le importasse cosa mi avesse detto e che il suo primario interesse fosse come mi sentissi io.
Attesi qualche secondo prima di rispondere, poi tirai un sorriso: «Mi sono presa una strigliata per aver pensato che gli importasse più della macchina che di come stesse sua figlia, per il resto tutto bene. Mi richiamerà stasera.» Abbassai le palpebre e inclinai appena la testa, quel tanto che bastava per permettere alla mia guancia di essere sfiorata dall’intera mano della mia amica, per godermi appieno il suo affetto. «Voleva rientrare in Italia prima e venirmi a trovare, gli ho detto di non farlo. Voleva che andassi almeno a casa sua perché ci sarebbero persone che si sarebbero prese cura di me, visto che mamma non tornerà ancora per un po’. Gli ho detto di no. Ha accettato, anche se parecchio, parecchio adirato.»
«Puoi rimanere qui se è questo il posto in cui ti senti più a tuo agio, non importa che tu vada là. Ci sono io che mi prendo cura di te.»
Riaprii lo sguardo, ringraziandola con gli occhi, perché le parole non sarebbero riuscite ad uscire a causa del nodo alla gola che si era formato, né tantomeno a comunicarle l’affetto che provavo per lei.
«Dopo lo chiamo io tuo padre e gli spiego la situazione, ora però mangia che sennò si fredda tutto!» Gli occhi le brillarono improvvisamente, l’entusiasmo che la contraddistingueva dal resto dei comuni mortali tornò a far splendere il suo volto.
Amavo Aurora. Sarei stata persa senza di lei.
«Jeg kan ikke fortsette slik, jeg vet ikke hvor jeg skal slå hodet lenger. (Non posso andare avanti così, non so più dove andare a battere la testa.)»
Svein non disse nulla, era stato ad ascoltare la mia storia aspettando che trovassi da solo le parole, senza mai interrompermi o farmi fretta. Quello che fece nel momento successivo mi spiazzò tanto da farmi smettere di piangere: mi abbracciò.
Non sono un grande fan degli stereotipi, ma mentirei se dicessi che i norvegesi sono molto propensi a contatti affettivi come gli italiani. Non significa che non siano in grado di esprimere affetto verso chi lo provavano, solo che non sono i classici tipi da baci e abbracci. O almeno, io non ne avevo mai incontrati di particolarmente affettuosi, e Svein non era certo uno che si potesse dire come eccezione alla regola.
Forse, fu proprio per quello che capii davvero il significato e l’importanza di quell’abbraccio in quel momento.
Mi strinse forte, quel tepore che emanava era davvero quello di un fratello maggiore; non potei far altro che nascondere il volto sulla sua spalla e finire di piangere lacrime che non credevo nemmeno di avere.
Solo in quel momento mi resi conto di quel che gli avevo detto. Avevo detto di aver ucciso qualcuno a un militare. A una persona che, in in caso di guerra o serie crisi, era pagata per uccidere le persone. Nonostante il suo lavoro, Svein non era mai stato un amante delle guerre e degli scontri. Lui aveva bisogno di essere in cielo per poter respirare, e il fatto che avesse scelto la strada del militare anziché quella del semplice pilota di linea, era perché credeva davvero nel suo Paese e che, nelle peggiore delle ipotesi, sarebbe stato in grado di proteggere i suoi affetti con le proprie capacità. Lui diceva sempre che i militari servivano a proteggere, non a ferire. E che fosse compito di altri il non far accadere il peggio.
«Arkin jeg ... Jeg kan ikke hjelpe deg. Men du trenger hjelp. (Arkin io… Non sono in grado di aiutarti. Ma tu hai bisogno di aiuto.)»
Dentro di me, da qualche parte, sapevo bene che la morte di Paolo non avesse niente a che fare con me, che nessuno su questo pianeta me ne avrebbe addossato la colpa. Nessuno, tranne il sottoscritto. E forse questo era quello che mi faceva più male, perché avevo come la sensazione che il resto del mondo non mi credesse, non capisse come mi sentivo davvero.
«Jeg kjenner en god psykolog, vil du ta en prat? (Conosco un ottimo psicologo, ti va di farci una chiacchierata?)»
«Penger… (I soldi…)» Mi fermò prima che potessi finire la frase, guardandomi dritto negli occhi, uno sguardo che non ammetteva repliche: «Vi har det. Og i tilfelle vi virkelig befinner oss med vann i halsen, leier vi rommet opp. På en eller annen måte gjør vi det. Men du må helbrede. (Li abbiamo. E nel caso dovessimo trovarci davvero con l’acqua alla gola, affittiamo la camera su. In qualche modo facciamo. Ma tu devi guarire.)»
Mi passai l’avambraccio sugli occhi, per asciugare le ultime tracce di lacrime, e annuii.
«Ok, kom igjen. (Okay, vieni.)» Svein sciolse completamente l’abbraccio e mi dette una pacca sulla spalla, sorridendomi incoraggiante e prendendo il cellulare di tasca. «La oss kalle det sammen. (Chiamiamolo insieme.)»
«Senti, devo dirti una novità importantissima.» Appena finito di pranzare, Elsa si sedette davanti a me sul letto, le gambe incrociate e gli occhi che le brillavano in un modo che non le avevo mai visto prima. «Io e Leo ci sposiamo.»
Inclinai appena la testa, non comprendendo da dove venisse fuori quella notizia per nulla nuova. Erano anni che erano fidanzati, dovevano solo scegliere una data, appena si fossero un po’ stabilizzati con i rispettivi lavori e la casa nuova. «Sì, lo so che siete fid…»
«No no, non hai capito.» Mi sorrise lei, stringendomi le mani tra le sue. «Il primo giorno di Marzo, ci sposiamo.»
Silenzio.
Cercai di metabolizzare la cosa.
Non mi riuscì.
«Eh?»
Guardai il calendario accanto al mio letto. Mancavano meno di due settimane all’inizio di Marzo.
«Mi fai da testimone?»
Il fatto che sia quasi Marzo il momento in cui pubblico questo capitolo, visto come ho voluto chiuderlo, è una sensazione bellissima. Una di quelle che ti fa stare bene dentro per ore.
Un grazie speciale a quelli che stanno seguendo questo racconto, silenziosi e non. Non mi aspettavo davvero tante visite, e a dispetto di quel che vorrei, alimentano il mio ego.
Il mio ego avrebbe bisogno di essere ridimensionato un poco negli ultimi tempi, ma va bene anche così. Ci pensa la gente che non è in grado nemmeno di fare copia-incolla, facendo fare figure del bip, a sistemarlo. Quindi no prob.
Arkin mi sta dando non pochi problemi in questi ultimi capitoli. Sì lo so che parlo solo di lui e probabilmente dovrei fare qualche accenno anche a Cam, ma il ragazzo mi fa scrivere in un’altra lingua e google traduttore è uno schifo. E quindi i problemi li da lui.
Godo ancora per il pugno di Svein. Ma tanto.
Sì, sono bastarda dentro.

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 16
*** Pagina 15 ***
Pagina 15.
And all the ones that love me they just left me on the shelf,
my farewell
So before I save someone else, I've got to save myself
And before I blame someone else, I've got to save myself
And before I love someone else, I've got to love myself
(E a tutti quelli che mi hanno lasciato sullo scaffale,
il mio addio.
Quindi prima di salvare qualcun'altro, devo salvare me stesso.
E prima di dare la colpa a qualcun'altro, devo salvare me stesso.
E prima di amare qualcun'altro, devo amare me stesso.)
– Save Myself, Ed Sheeran
Quella notte mi svegliai di soprassalto.
Mi ritrovai seduta sul letto che stavo grondando sudore gelido da ogni poro, incurante dei flebili dolori al collo e alle costole. Mi portai una mano al petto, dove strinsi d’istinto, proprio sopra il cuore, mentre l’altra andava alla testa martellante. “Cosa diamine…” Il respiro era affannato, nemmeno avessi appena finito una gara di canottaggio. Facevo fatica a trovare ossigeno, sembrava che l’aria non ne contenesse abbastanza per saziare i miei polmoni.
Mi sforzai di alzarmi dal letto e andai alla finestra, che spalanchai, e buttai la testa fuori. Inspirai a fondo l’aria gelida e umida della notte, incurante del dolore alla cassa toracica, cercando invano un poco di sollievo.
Riuscii a trovare nuovamente un equilibrio solo dopo qualche minuto.
Con la mente un poco più lucida, mi lasciai cadere seduta con la schiena al muro, restando sotto la finestra di camera. “Un incubo… Ho fatto un incubo…”
Incubo. L’avevo davvero chiamato così? Ero stata io a dargli quel nome?
Portai le mani al volto e, sorprendendomi, mi resi conto che stavo piangendo, chissà da quanto.
Una stretta al cuore mi tolse il fiato, anticipando quello che era un attacco di panico in tutto e per tutto. Il formicolio partì dalle punte dei piedi, per salire poi lentamente per le gambe, arrivare alle braccia, le mani, lasciando sensazioni che quel corpo fosse mio senza appartenermi davvero. Se dicevo alla testa di muovere le dita delle mani, queste rimanevano immobili sulle mie gambe, come paralizzate, sotto il mio sguardo in preda al panico. Il formicolio si espanse sul volto, portandosi con sé tic nervosi e incapacità di parlare, gridare, chiedere aiuto. Finché non arrivò al cervello e anche pensare razionalmente divenne impossibile.
Feci l’unica cosa che avevo imparato a fare nella mia vita di fronte a queste situazioni: attesi.
Rimasi immobile, sotto la finestra, finché il formicolio non cessò da solo.
Era un bene che fosse arrivato al cervello e non si fosse arrestato prima: mi impediva anche di avere paura, facendolo finire senza che quasi me ne accorgessi davvero. Non sapevo mai quanto durasse in realtà, a me parevano secondi e anni allo stesso tempo. Ma sapevo che passava, l’aveva sempre fatto, e lo fece anche quella volta.
Non appena mi accorsi di riavere il controllo sul mio corpo, chiusi gli occhi e cercai di respirare profondamente, lasciando ancora le altre membra immobili. Troppo presto per cercare di muoverle, non ci fossi riuscita mi sarebbe solo montata la paura. Perciò decisi di rimanere lì, ancora un po’, seduta sotto la finestra con l’aria fresca che entrava in camera e nei miei polmoni.
Riuscivo ancora a sentire le lacrime che scendevano sulle guance, ma non feci nulla per fermarle. Sapevo fossero dovute al sogno che avevo fatto, il motivo per il quale avevo avuto quell’attacco di panico.
Avevo sognato la mia vita, un futuro in una casa con la mia famiglia, i miei bambini, e loro padre. Peccato che il padre, anziché Mattia, fosse Arkin.
«Hei, jeg er Gunnar. (Piacere, sono Gunnar.)»
«Arkin…»
«Ikke vær nervøs, det er ingen grunn. Liker du sport, Arkin? Hva med å gå for to skudd? (Non sia nervoso, non ce n’è motivo. Le piace lo sport, Arkin? Che ne dice di andare a fare due tiri a canestro?)»
Guardai la palla da basket, appena fermatasi tra le miei mani dopo il passaggio dall’uomo di mezza età che avevo davanti. Alzai lo sguardo perplesso verso colui che si spacciava per uno psicologo, che sorrideva sereno a mio cugino. «Svein, vil du være med? (Svein, ti andrebbe uni dirti?)»
Il soldato, al mio fianco, sorrise come fosse la cosa più normale del mondo. «Med glede. (Volentieri.)»
Alzai un attimo la mano a cenno di aspettare un istante e presi Svein per il braccio, portandolo con me oltre la porta. Il presupposto psicologo fece un cenno con la testa come a dire “non c’è problema, andate pure”.
«Hva skjer? (Che succede?)» Mi chiese mio cugino appena varcata la soglia.
«Hva skjer? (Che succede?)» Gli feci il verso, io. «Virker det normalt for deg at en psykolog, rett etter å ha presentert seg selv, spør deg om du vil skyte to skudd? (Ti sembra normale che uno psicologo, appena dopo essersi presentato, ti chieda se vuoi fare due tiri a canestro?)»
«Vil du helst at du legger deg på en svart skinnseng og spør deg hva du drømte om? (Preferivi ti facesse stendere su un lettino di pelle nera e ti chiedesse cosa avevi sognato?)»
«Vel ... Ja, jeg hadde funnet det mer ... naturlig. (Beh… Sì, lo avrei trovato più… naturale.)»
Svein mi sorrise tranquillo, il che ottenne come risultato solo il farmi sentir ancor più fuori posto.
«Arkin.» Mi diede una patta sulla spalla. «Mannen utenfor døren spesialiserer seg i behandling av stress etter krigen. Hvis du tror den beste måten å starte terapi på er å få pasienten til å ta to bilder, vet du hva du skal gjøre? (L’uomo oltre quella porta è specializzato nel trattamento di stress post-guerra. Se per iniziare una terapia pensa che il modo migliore sia quello di far fare al paziente due tiri a canestro, sai quello che dovresti fare?)»
Mi rubò la palla da basket che tenevo malamente sotto braccio, per poi sorridermi sicuro di ciò che diceva: «Forbered deg på returen (Prepararti al rimbalzo).»
Si voltò e tornò nella sala. Io feci un sospiro, le braccia lungo il dorso, esasperato. «Ditt militær er ikke normalt. (Voi militari non siete normali.)»
«Hvis vi var “normale”, ville vi ikke vært militære, gutt. (Se fossimo “normali”, non saremmo militari, ragazzo.)»
Mi voltai verso l’uomo in divisa che mi era appena passato alle spalle. Non lo conoscevo nemmeno di vista e, dopo aver parlato, aveva continuato come nulla fosse per il suo percorso verso l’altra parte del corridoio. Avrei potuto avere la sensazione di essermi sognato la sua risposta, se prima di svoltare l’angolo non si fosse preso la briga di lanciarmi un’occhiata e un sorriso fin troppo allusivo.
Colto da un’onda di imbarazzo, abbassai il capo e entrai nella stanza dello psicologo, chiudendomi la porta alle spalle.
«Jeg fortalte ham at han ville være tilbake. (Glielo avevo detto che sarebbe tornato.)» Esordì mio cugino, trionfante.
«Så, Mr. Arkin… (Allora, Signor Arkin…)» Mi voltai verso lo psicologo e posai lo sguardo su di lui, mentre una strana sensazione di calma iniziava stranamente a farsi strada dentro di me. La sentii partire dalla testa e dalla punta delle mani, come alimentata da ogni parola dell’uomo e, anche se in un primo momento mi spaesò un poco, decisi di lasciarle invadere il resto del corpo. «Vil vi spille dette basketballspillet? (La vogliamo fare questa partita a basket?)»
Rimasi un attimo in silenzio, nel tentativo di lasciar andare tutti i pragmatismi che la mia testa mi stava facendo montare. “In effetti, un po’ di movimento potrebbe aiutarmi a rilassare un po’ i nervi…” Incrociai lo sguardo con Svein. “Mi fido ciecamente di te, soldato.”
Portai le mani davanti al petto, un sorriso carico a distendermi il volto: «Jeg sparker deg. (Ti faccio il culo.)»
Svein sorrise, quasi strafottente, per poi passarmi il pallone e precedermi fuori dalla porta, lo psicologo dai metodi inosuali davanti a noi per fare strada.
«Allora? Di cosa volevi parlare?»
Alzai gli occhi e li incontrai con quelli sinceri del ragazzo che avevo davanti. Il cuore mi batteva a mille, le mani non riuscivano a stare ferme e sentii le lacrime che erano sul punto di star per vincere la barriera dei miei occhi da un momento all’altro.
Scostai lo sguardo da Mattia e lo posai sulle mie gambe, dove le mani si stavano torturando l’un l’altra. Onestamente, mi ero ripetuta talmente tante volte quello che gli volevo dire, da non ricordare mezza parola.
«Tu… sei felice?» Riuscii a chiedere, o meglio, a sussurrare, dopo un tempo indescrivibile. Ovviamente senza ancora il coraggio di guardarlo negli occhi.
Una piccola, triste, risata uscì dalle sue labbra. «Accidenti… di già?» Ecco, aveva capito. Fantastico. D’altronde non era un idiota.
Una vocina dentro di me mi disse che potevo anche alzarmi e andarmene, che tanto non c’era bisogno di aggiungere altro. L’altra vocina, quella con un minimo di intelligenza sociale, mi disse che invece glielo dovevo dire in faccia, guardandolo dritto negli occhi.
La tentazione di dare retta alla vocina vigliacca era davvero tanta.
«Il fatto è che… Io non…»
«Posso chiederti una cosa?» La sua domanda mi sorprese talmente tanto che mi voltai verso di lui senza nemmeno volerlo. «Se io ti aspettassi… avrei qualche speranza?»
Riabbasai la testa, in volto un’espressione sinceramente mortificata. Non riuscii a dirlo. Ci provai, giuro, ma, per quanto una parte di me lo avesse desiderato, non riuscii a dirgli di sì.
«Ho capito…» Alzò lo sguardo, guardando le persone che camminavano davanti a noi completamente ignare del suono del cuore che stava gridando al mio fianco.
«Mi dispiace…»
«No, non devi.»
«Non volevo finisse così, davvero. Io… sono stata davvero bene con te, sei stato in grado di farmi sentire al sicuro e amata come nessun altro prima… Mi hai insegnato e dato il coraggio a dare un nome alle emozioni che provo… Però… quello che provo per te è solo affetto… Un immenso, incredibile affetto, ma non è amore… Mi dispiace…»
«Ehi.» La sua mano ad accarezzarmi la guancia mi fece alzare lo sguardo verso di lui, mi fece vedere il suo sorriso morbido come il burro, fece vincere le lacrime. «Mentirei se dicessi che non fa un male bestia. Ma… scusami, ma io non voglio vivere al fianco di una persona che non mi ama, cosciente che non mi amerà mai come la amo io.»
Ritirò la mano e io sentii il gelo del vento sulla guancia bagnata. Tornò a guardare in basso, mettendo le mani nelle tasche del giubbotto. «Scusa ma… potresti lasciarmi solo ora? Ho bisogno di metabolizzare la cosa…»
Attesi qualche secondo per cercare di trovare la forza nelle gambe, poi mi alzai e me ne andai. “Mi dispiace, davvero… Ma… neanche io voglio vivere con qualcuno che non amo…”
«Du er i dårlig form, lille kusine. (Sei in pessima forma, cuginetto.)»
“Risparmiami quel sorrisetto strafottente…” Avevo le mani sulle ginocchia, il fiato corto e i polmoni che mi bruciavano nemmeno qualcuno avesse acceso un fuoco da campo al loro interno. Restai con lo sguardo inchiodato a terra, il sudore che mi colava persino dalla punta delle ciglia. “Cazzo… non pensavo di essere messo così male…”
«Hvor lenge varte du, 10 minutter? Din fremtidige kjæreste ville være ganske skuffet over en slik forestilling. (Quanto sei durato, 10 minuti? La tua futura ragazza sarebbe parecchio delusa da una performance del genere.)» Svein era invece in formissima, il suo fiato perfettamente sotto controllo, nonostante fossero 10 minuti che correva come un dannato avanti e indietro per quel maledetto campetto di cemento.
La palla rimbalzava rilassata dalla sua mano al terreno, poco più avanti dei suoi piedi, mentre mi si avvicinava. «Forstår du nå at røyking er dårlig for deg? (Lo capisci ora che fumare fa male?)»
Alzai lo sguardo, rendendolo di fuoco per quel che potevo, rispondendo alla provocazione. «Jeg har… aldri hatt… de jævla musklene… du har… (Io non… ho mai avuto… quei cazzo di muscoli… che ti ritrovi tu…)»
Svein rise come un bambino.
“Però è vero… Non avevo idea di essere messo così male, non me ne ero davvero accorto…” Non riuscii a trattenere qualche colpo di tosse, e i polmoni mi parvero esplodere. “Cazzo.”
«Jeg kjenner det utseendet. (Conosco quello sguardo.)» Mio cugino mi aveva raggiunto, negli occhi una luce che gli avevo visto poche volte, il pallone sotto il braccio. «Du skjønte akkurat hvor mye du suger på egenhånd, fortell meg om jeg tar feil. (Hai appena realizzato quanto ti fai schifo da solo, dimmi se sbaglio.)»
Alzai ancora lo sguardo, e vi rimasi. Avevo l’impressione di trovarmi di fronte Odino, che osservava uno dei suoi figli; un figlio che lo aveva profondamente deluso, tradito. “Mi deve aver colpito davvero forte con quel pugno, l’altra sera…”
«Det er bra. (È una buona cosa.)» Svein mi tese la mano, un sorriso colmo d’affetto gli si dipinse sul volto. «Nå vil du komme deg på beina igjen. (Adesso vuoi rimetterti in piedi.)»
Strinsi la mano che mi stava offrendo, tentando di rendere la presa salda e sicura. Non seppi se mi riuscì, ma lo sguardo che ci scambiammo in quel momento penso non lo scorderò mai.
Fossimo stati in un film, sarebbe stata la scena perfetta per un fermo immagine, ripresa con un’inquadratura leggermente dal basso e la luce proveniente dalla parte opposta; un filtro artistico photoshoppato e poi via ai titoli di coda, accompagnati da una canzone degli Skillet.
Invece, la voce dello psicologo mi riportò alla realtà: «Så Arkin… (Allora, Arkin…)» Mi voltai verso di lui, ricordandomi solo in quel momento della sua presenza. L’uomo si avvicinò a me e mio cugino, che riprese a palleggiare e andò a fare qualche tiro libero in solitaria. «Er du nysgjerrig på å vite hvorfor jeg tilbød deg dette lille basketballspillet? (È curioso di sapere perché le ho proposto questa piccola partita di basket?)»
«Faktisk ganske... ja… (In effetti, abbastanza… sì…)»
«Å studere det. (Per studiarla.)»
«Studer meg… (Studiarmi…)» Ripetei io, scettico. “Questo non batte pari…”
«Yeah!»
Mi voltai verso mio cugino, che aveva appena esclamato per un canestro con schiacciata. “Vola anche senza ali…”
«Ja, det er ikke mange som vet det, men basketball gir et godt speil av personlighet for mennesker hvis man er i stand til å observere. (Sì. Non molti lo sanno, ma la pallacanestro offre un ottimo specchio di personalità per le persone, se si è in grado di osservare.)» Tornai a concentrarmi sul medico. «Du, Arkin, til tross for at du er bestemt dårligere når det gjelder dyktighet til fetteren din … (Lei, Arkin, nonostante sia decisamente inferiore in quanto ad abilità a suo cugino…)»
«Å, men kom igjen! Jeg mener… se det! (Oh ma andiamo! Voglio dire… lo guardi!)» Esclamai io interrompendolo, con una piccola risata, indicando Svein in modo scenico mentre si esibiva in un’altra schiacciata. «Den ene har vinger på føttene! (Quello ha le ali ai piedi!)»
Il Dott. Gunner mi offrì una risata sincera, per poi riprendere: «Ja, han har rett. Men poenget er ikke fetteren hans. (Sì, ha ragione. Ma il punto non è suo cugino.)» Si avvicinò di un altro passo e mi sfiorò il petto con l’indice. «Det er deg, sir. (È lei.)»
Strinsi un attimo lo sguardo, a quel punto quell’uomo aveva tutta la mia attenzione.
«Til tross for ulempen takket hun likevel utfordringen. For stædighet, stolthet. Og han jobbet hardt i løpet av kampen, om enn forgjeves med tanke på det åpenbare atletiske gapet. (Lei, nonostante lo svantaggio, ha comunque accettato la sfida. Per testardaggine, orgoglio. E si è impegnato durante l’incontro, seppur inutilmente visto il lampante divario atletico.)»
«Hvis han prøver å fornærme meg, gjør han det på en veldig original måte. (Se sta cercando di offendermi, lo sta facendo in maniera molto originale.)»
Lui rise. «Jeg fornærmer henne ikke, jeg er bare ærlig. Og objektiv. (Non la sto offendendo, sono solo sincero. E oggettivo.)»
“Mi inizia a piacere assai questo tizio”
«Under en-mot-en-sammenstøt, da hun hadde ballen, var det første hun gjorde å se etter brudd i fetterens forsvar. (Durante gli scontri uno contro uno, quando lei aveva il pallone, la prima cosa che ha fatto è stato cercare le brecce nella difesa di suo cugino.)»
«Er det ikke... åpenbart? (Non è… ovvio?)»
«Ja, men det er metoden som viser den dominerende personlighetstypen. I løpet av de første angrepene søkte hun alltid et direkte gjennombrudd, og gikk bare med en fri arm for å beskytte både henne og ballen. Dette gjorde at hun systematisk fant henne med den stjålne ballen. Men… (Sì, ma il è il metodo che mostra il tipo di personalità dominante. Durante i suoi primi attacchi lei ha sempre cercato uno sfondamento diretto, avanzando con il solo braccio libero a proteggere sia lei che il pallone. Questo l’ha fatta sistematicamente ritrovare sempre con il pallone rubato. Ma…)»
«Heldigvis er det en men… (Per fortuna c’è un ma…)»
«Det er nesten alltid et “men”. (C’è quasi sempre un “ma”.)» Sorrise lui. «Etter å ha feilet de første gangene, forlot hun det direkte angrepet og søkte avstanden mellom henne og Svein, for bedre å studere motstanderen, og forsøkte å skyte på avstand i stedet for under kurven. Dette er fordi han så at fetteren hans flyttet slik først. Dette var imidlertid også en fiasko, fordi Svein klarte å stjele ballen fra himmelen. (Dopo aver fallito le prime volte, ha abbandonato l’attacco diretto e ha cercato la distanza tra lei e Svein, per studiare meglio il suo avversario, tentando dei tiri da lontano anziché da sotto canestro. Questo perché ha visto che suo cugino si muoveva così, in un primo momento. Anche questo è stato però un fallimento, perché Svein era in grado di rubarle la palla dal cielo.)»
“Già… Maledetto…”
«Så hun tenkte, tenkte og begynte å integrere noen velstrukturerte finter i spillet sitt, som gjorde at hun endelig kunne komme med noen poeng. Vet du hva dette betyr? (Allora ha pensato, ha riflettuto, e ha iniziato a integrare qualche finta ben strutturata nel suo gioco, cosa che le ha permesso di fare finalmente qualche punto. Lo sa questo cosa vuol dire?)»
«At jeg må forbedre angrepet. Og slutte å røyke, fordi det gjorde meg atletisk dritt. (Che devo migliorare l’attacco. E smettere di fumare, perché mi ha ridotto atleticamente a uno schifo.)»
Il sorriso di Gunner si ammorbidì, quasi stesse parlando a un bambino. Stranamente, la cosa non mi dette fastidio.
«Også, ja. Å slutte å røyke er definitivt et stort skritt fremover. Men det jeg vil at hun skal innse er at hun kan forbedre seg veldig raskt hvis hun vil. Hun kan imidlertid ikke lykkes alene, hun trenger praktiske og håndgripelige eksempler som faktisk viser henne et nytt perspektiv, for deretter å prøve dem på sin egen hud, før hun bestemmer seg for om de virkelig er effektive eller ikke. Og hvis de ikke er det, finn selv en løsning som fungerer. (Anche, sì. Smettere di fumare è sicuramente un grande passo avanti. Ma quello che voglio che lei realizzi è che lei, se vuole, è in grado di migliorare molto in fretta. Non riesce però da solo, ha bisogno di esempi pratici e tangibili che le mostrino effettivamente una nuova prospettiva, per poi provarli sulla sua stessa pelle, prima di decidere se sono veramente efficaci o meno. E se non lo sono, trovare da solo una soluzione che funzioni.)»
“Okay… Le cose sono due. O questo tizio è pazzo, oppure è un genio. O, nella peggiore delle ipotesi, entrambi.”
«Jeg vil gjerne kunne hjelpe deg. Jeg kan ikke love henne suksess, jeg vil være en skryter hvis jeg forsikrer henne så lett. Spesielt fordi, hvis tiden vi vil tilbringe sammen vil være nyttig for noe eller ikke, kan det bare være hun som bestemmer det. På min side tilbyr jeg deg maksimal støtte og tilgjengelighet som en psykolog kan gi pasienten. (A me piacerebbe poterla aiutare. Non le posso promettere il successo, sarei un fanfarone se glielo assicurassi così facilmente. Soprattutto perché, se il tempo che trascorreremo insieme sarà o meno utile a qualcosa, potrà essere solo lei a deciderlo. Dalla mia parte, le offro il massimo supporto e disponibilità che uno psicologo può dare a un paziente.)» Il suo sguardo si posò un attimo sulle nocche delle mani, ancora riportanti i segni dei pugni di qualche sera prima, per poi riposarsi lungimirante nei miei occhi. «Selv bare for å forhindre at visse… tilfeldigheter skjer igjen. (Anche solo per evitare che certe… casualità, possano accadere nuovamente.)»
Nascosi le mani dietro la schiena e scostai lo sguardo verso il terreno, sentendomi di colpo a disagio. Cercai di mormorare qualcosa come scusante, ma mi imbarazzai solo di più sentendomi dire: «Det var en ulykke... Det vil ikke skje igjen. (È stato un incidente… Non si ripeterà.)»
«Ja jeg er sikker. (Sì, ne sono certo.)» Un sorriso comprensivo sul volto del medico, che vidi con la coda dell’occhio. «Men ikke skamme deg over fortiden din, Arkin. Du ser... hver gest, tanke, ord som er en del av vår fortid har en mer eller mindre sterk innvirkning på vår nåtid og fremtid. Dette er grunnen til at det er bra å reflektere og lære av dine handlinger, spesielt fra de som vi selv kan gjenkjenne som feil. (Ma non si deve vergognare del suo passato, Arkin. Vede… ogni gesto, pensiero, parola che fa parte del nostro passato, ha un impatto più o meno forte sul nostro presente e futuro. Per questo è bene riflettere e imparare dalle proprie azioni, soprattutto da quelle che siamo in grado da soli di riconoscere come errori.)»
Alzai lo sguardo, riposandoli in quelli del medico. E quella strana e dolce ondata di calma riprese nuovamente ad abbracciarmi. «Man må aldri rømme fra sine feil, fra demonene. En sterk person blir ikke født slik, magisk, men blir sterk når de lærer å gjenkjenne følelsene sine og å kontrollere seg selv. Vi har ingen makt over andre, Arkin, vi har bare makt over oss selv, våre handlinger og våre tanker. Og dette er allerede i seg selv en stor supermakt, som du trenger for å kunne kontrollere for å ha en balanse i livet ditt og for å kunne gi balanse til våre kjære også. Han tror ikke? (Non bisogna mai scappare dai propri errori, dai propri demoni. Una persona forte non lo nasce così, magicamente, ma lo diventa una volta che impara a riconoscere le proprie emozioni e a controllare se stessa. Noi non abbiamo potere sugli altri, Arkin, abbiamo potere solo su noi stessi, sulle nostre azioni e suoi nostri pensieri. E questo è già di per sé un grande superpotere, che bisogna essere in grado di controllare per avere un equilibrio nella propria vita e poter donare equilibrio anche ai nostri cari. Non crede?)»
Riuscii solo ad annuire. D’altronde, che cosa avrei mai potuto aggiungere?
«God. Nå som jeg har denne grovt utarbeidede profilen til henne, vil vi gå til studioet mitt for å avgjøre hvilke krefter som mest trenger å låses opp for å la henne kontrollere dem, ved å bruke en litt mer tilnærming... den? Naturlig? (Bene. Adesso che ho questo suo profilo grossolanamente stilato, vogliamo andare nel mio studio per determinare quali sono i suoi poteri che hanno più bisogno di essere sbloccati per permetterle di controllarli, usando un approccio un poco più… com’è che lo aveva chiamato? Naturale?)»
Annuii. E mi morsi le labbra, portandomi una mano al volto, non riuscendo a trattenere un sorriso d’affetto. Ma non mi vergognai. “Dannata bocca larga di Svein…”
Gli lanciai un’occhiata, mentre ancora volava sul campetto da basket. Pareva non stancarsi mai. “Grazie.”
Si voltò verso di me, come se avesse percepito il mio pensiero, dopo l’ennesimo canestro. Mi fece l’occhiolino, cui io sorrisi di rimando, per poi regalarmi un tiro da tre punti. Solo dopo mi si avvicinò, a corsetta. «Deretter? (Allora?)»
Teneva la palla tra le mani, completamente a suo agio. «Jeg skal starte en terapi, lykkelig? (Inizierò una terapia, contento?)»
«Du er? (Tu lo sei?)»
Riflettei un secondo prima di rispondere. Lanciai un’occhiata al medico, che ci aspettava al confine del parchetto per darci un attimo di privacy, approfittando dell’occasione per accarezzare un cane che passava di lì per una passeggiata e scambiare due chiacchiere con il padrone.
Espirai profondamente, poi guardai mio cugino con un sorriso. «Ja. Jeg tror det er riktig trekk. (Sì. Credo sia la mossa giusta.)»
Svein mi sorrise. Un piccolo sorriso sulle labbra, ma che irradiava di luce i suoi occhi color ghiaccio. Mi diede una pacca sulla spalla e ci dirigemmo verso il medico, io e Gunnar saremmo tornati allo studio per la prima seduta, Svein sarebbe andato da Gersemi.
«Men du svetter aldri? (Ma tu non sudi mai?)»
«Det skal mye mer til for å få meg til å svette. (Ci vuole ben altro per farmi sudare.)» Rise lui, mentre giocava con il pallone. Non riusciva a stare fermo, era più forte di lui.
«Forbannet soldat… (Soldato maledetto…)» Mormorai tra i denti, soffocando una risata. “Dio, quanto bene che ti voglio…”
Ci sono tanti tipi di attacchi di panico e, per l’amor del cielo, se doveste mai ritrovarvi ad averne uno, non nascondetelo. Lo so benissimo che è più facile a dirsi che a farsi, ma davvero… sono pericolosi proprio a livello fisico e cerebrale, non scherzateci e non giocateci. E non fate come me da bimbetta che ero gelosa di chi sveniva perché volevo sapere anch’io cosa si provava… poi è successo e non ho mangiato per due giorni.
Ma voi avete presente tutto quello che fa Cam? Bene. Vogliatevi bene e fate tutto l'opposto.
Mi rubò la palla da basket che tenevo malamente sotto braccio, per poi sorridermi sicuro di ciò che diceva: «Forbered deg på returen (Prepararti al rimbalzo).»
Nella pallacanestro, il rimbalzo è il recupero del pallone dopo un tiro sbagliato.
E’ stato Svein a fare i rimbalzi. Perché è stato Arkin a non azzeccare mezzo canestro, all’inzio.
Lo so che avevo detto che volevo fare un punto su Mattia e Cam su questo capitolo, e quindi eccolo qui, breve breve, promesso. Pensavo di “trasferire” queste note a uno dei capitoli precedenti come avevo accennato, perché qui volevo dire due cose sullo psicologo, ma il mio psicologo personale notturno mi ha detto di lasciar perdere e scrivere direttamente qui, perciò… Boh, una volta tanto devo dargliela vinta e quindi le lascio qui e via.
Chiariamo un punto: qualsiasi cosa sia accaduta, Cam tiene davvero a Mattia.
Il ragazzo è un passo fondamentale per lei, per aiutarla a dare un nome alle emozioni che prova. Mattia fa da "psicologo" a Cam, iniziandola a farle dare un nome alle sue emozioni, facendola crescere, e lo fa semplicemente standole vicino. È quel tipo di persona che, standoti semplicemente vicino, ti fa provare cose che magari avevi anche già provato ma ti fa venire in mente “hey, diamo un nome a questa cosa, perché è bella, mi fa stare bene, e me la voglio ricordare”.
Il problema è che la loro relazione è terribilmente... instabile. Anche se la ragazza tiene a lui, non è in grado di provare amore. L'Amore non si può forzare. Prova attrazione, prova un sentimento romantico nei suoi confronti, prova un immenso affetto. Ma non è Amore. Ognuno ha il proprio modo personale di amare, che sia in modo romantico o platonico, e la ragazza in questione si è semplicemente resa conto che il tipo di amore che provava per la persona più gentile e perfetta che avesse mai incontrato, non era un tipo di amore in cui sarebbe stata felice. Incolpandosi magari di ciò, perché Mattia la faceva stare serena, la calmava… ma non è il tipo di serenità e calma a cui Cam ambisce. E’ difficile da spiegare, abbiate pietà…
Il fatto è che tutto questo Camilla lo scopre e se ne rende conto proprio grazie alle abilità che acquisisce grazie a Mattia: diventa curiosa sui sentimenti, suoi e degli altri. Se vede qualcuno provare qualcosa, vuole sapere di cosa si tratta, vuole essere in grado di riconoscere l'emozione che vede e che sente. È come... Si potrebbe paragonare questo periodo di Cam come una persona che adora mangiare ma lo scopre solo dopo aver mangiato un certo piatto di una particolare cucina. E allora la studia, prova nuovi piatti, condimenti, accostamenti, pare non averne mai abbastanza. Si mette a cercare ricette di quella cucina e inizia a prendere in mano per la prima volta pentole e mestoli. E osserva attentamente ogni tutorial che le viene proposto, ogni movimento di quegli chef che sembrano così a loro agio dietro ai fornelli. E li imita. Vuole ricreare i loro piatti perché vuole assaporare quello che mangiano loro dall’altra parte dello schermo.
E poi vuole fare quel passettino in più, vuole rendere proprie quelle ricette e modificarle quel tanto che basta per renderle una sua creazione ma mantenendo la base meravigliosa di cui si è follemente innamorata all’inizio. E questa linea di confine è terribilmente sottile.
Mattia sarebbe il ragazzo dei sogni del 70% della popolazione, ne sono certa, ma Cam fa parte della percentuale del 30%. Non è che sia masochista o abbia voglia di essere trattata male e soffrire, o che la relazione con Mattia fosse “noiosa”, i due avevano un sacco di cose in comune, ma mancava… quel briciolino in più di chimica, che in un rapporto ci vuole. Avrebbe potuto tapparsi gli occhi e far finta di niente, vivere in una famiglia del Mulino Bianco e sorridere a quella mezza bugia per il resto della sua vita, convincendosi che di meglio non avrebbe potuto avere (che potrebbe essere anche vero, ma se uno non ci prova come fa a saperlo?), però ha scelto di no.
Alla fine dei conti, la domanda è sempre la solita: meglio rischiare di avere rimpianti per aver provato, oppure per non aver fatto nemmeno un tentativo?
Non esiste risposta esatta, a ognuno la propria.
La relazione con Mattia è un quadro dalle tonalità pastello, completamente. Non è noioso, è meraviglioso, rilassante e ti acquieta l’anima quando lo guardi. Ma Cam ne vuole uno dai colori accesi, con nuances di pastello qua e la magari, ma il focus del dipinto deve essere un’esplosione di colori accessi, complementari tra loro, che in certi punti si scontrano e fanno fatica ad amalgamarsi, stonando gli uni con gli altri, mentre in altri creano l’armonia perfetta. E... se vogliamo proprio essere sinceri qui, quel tipo di quadro non si ottiene solo trovando "la persona giusta", ma diventando la persona giusta per noi stessi. Come anche scritto nella canzone di incipit, uno deve imparare ad amare, proteggere e curare se stesso, prima di poter amare qualcun altro. E non c'è "l'età giusta" per far questo.

     
|
Ritorna all'indice
Capitolo 17
*** Pagina 16 ***
Pagina 16.
A te che non ti piaci mai
E sei una meraviglia
Le forze della natura si concentrano in te
Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano
Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano.
A te che sei l'unica amica
Che io posso avere
L'unico amore che vorrei
Se io non ti avessi con me
A te che hai reso la mia vita
Bella da morire
Che riesci a render la fatica
Un immenso piacere
A te che sei il mio grande amore
Ed il mio amore grande
A te che hai preso la mia vita
E ne hai fatto molto di più
A te che hai dato senso al tempo
Senza misurarlo
A te che sei il mio amore grande
Ed il mio grande amore
– A Te, Jovanotti
“Non avrei mai creduto di riuscire a mettere piede in questo posto senza avere una crisi di panico…”
Il suono dei remoergometri all’interno della palestra mi mise addosso una profonda malinconia, ma più che lasciarmi andare al dolore, la mente mi fu inondata da ricordi dolci, nostalgici. Momenti felici, passati tra quelle mura e sul pelo dell’acqua.
Mi scappò un sorriso, e mi sorpresi di me stessa. Mi fermai qualche secondo di fronte al cancello color giallo canarino della palestra, per assaporare un attimo quelle nuove sensazioni, quando riconobbi la voce del Jolly mandare qualche imprecazione a quella macchina demoniaca. Il sorriso si fece per qualche istante più largo.
Ripresi a camminare, verso il fiume. Non volevo entrare, era già un gran risultato essere arrivata fin lì, per il momento mi bastava quello.
Attraversai il parco, l’argine e arrivai al pontile. La piena degli ultimi giorni aveva intorpidito il fiume, facendo alzare il fondale, e pezzi di alberi che la corrente aveva strappato all’argine galleggiavano ogni tanto sulla superficie. “Stasera scenderanno solo i seniors…” Non era certamente nelle sue condizioni migliori, più pittoresche. Eppure, ai miei occhi era una visione meravigliosa.
Immersa nei miei pensieri, non mi accorsi di Elsa finché non mi ritrovai le sue braccia a stringermi in un abbraccio da dietro. Mi voltai appena, stordita, quando la sua voce rotta mi arrivò all’anima: «Non ci speravo più di vederti qui.»
Con la coda dell’occhio, vidi i remi della sua barca lasciati cadere senza nessuna cura sul ghiaino polveroso della strada dietro di noi; doveva averli lasciati andare non appena mi aveva vista, correndomi incontro senza pensarci due volte. Solo in quel momento mi resi davvero conto di quanto fossi mancata alla mia amica.
Posai lo sguardo sulle braccia che mi circondavano la vita, sfiorandole con la mano. «Mi dispiace… averti fatto aspettare tanto…»
La sentii fare cenno negativo con la testa. «Non importa. L’importante è che tu ora stia bene.»
Bene… Parola grossa. Non stavo ancora abbastanza bene per tornare a vogare, sinceramente non sapevo se sarei mai tornata. Ma stavo decisamente meglio rispetto a qualche mese prima. Ed era solo grazie a una persona, se ora riuscivo a stare vicino a quei posti senza farmi prendere da un attacco di panico.
Però no, non stavo bene. Perché avevo appena fatto soffrire un ragazzo per cui provavo un sincero affetto, che mi aveva fatta sentire amata e preziosa, per il quale però non riuscivo a provare lo stesso sentimento. Nonostante ci avessi provato.
«Ho lasciato Mattia…»
Elsa sciolse l’abbraccio e mi si mise di fronte, l’espressione sconcertata in volto che anticipava l’ovvia domanda: «Cosa?»
Chiusi gli occhi e respirai profondamente, come per trovare le forze di raccontarle ciò che era successo. «Non si può forzare l'amore, alla fine l’ho capito. O c'è o non c'è. Se c’è, è giusto fare tutto il necessario per proteggerlo. Ma se non c’è… Per me non c’era, quello che provavo era un grande affetto, ma non amore e… non sono una bambina, era giusto essere abbastanza matura da ammetterlo.»
Ci sedemmo su una delle panchine dell’argine, il fiume a fare da ancora di salvezza per il mio sguardo, per quando non trovavo il modo di esprimere ciò che provavo.
Elsa ascoltò tutto senza dire nulla, pazientando nei miei momenti di silenzio senza interrompermi. Le fui grata della sua pazienza.
Una volta finito di parlare, tirai l’ennesimo sospiro della giornata e mi sentii più leggera. Lanciai un’occhiata alla mia amica, al mio fianco, accennando a un sorriso. Ma rimasi sorpresa dal vedere il turbamento nel suo volto.
«Ti ho davvero scioccata tanto?»
Aurora scosse la testa. «Non è quello… Non fraintermi, mi dispiace che tra voi due non abbia funzionato, ma se non lo ami non puoi farci nulla, non è colpa tua. Non si può costringere il cuore ad amare qualcuno…» Strinse gli occhi, come a trovare le parole giuste. «Idra… Ricordi la notte al retone?»
«E come potrei dimenticarla…»
«Ricordi la storia di Zeus che mi hai raccontato?»
«E come potrei non ricordarla…»
«Dopo il tuo incidente… C’è stata un numero extracomunitario che mi ha chiamata ininterrottamente…»
«Sì, me lo ricordo. Hai risposto quando sei venuta a trovarmi a casa di mia madre. Eri anche parecchio incazzata, ma quando sei rientrata mi hai sorriso serena, quindi… ho pensato tu avessi risolto, no?»
Aurora si voltò verso di me, le dita delle mani intrecciate che si torturavano l’un l’altra, negli occhi era evidente il conflitto interiore che stava vivendo, non certa di ciò che stava per rivelare, se fosse davvero la cosa giusta o meno. «Era Arkin.»
Il cuore mi mancò un battito.
Riuscii a formulare la frase solo dopo qualche secondo abbondante. «Com’è possibile… Perché ti ha chiamata?»
«Voleva sapere come stavi. Sull’ambulanza che ti ha portata all’ospedale quella mattina c’era sua sorella, è lei che lo ha informato. Era… difficile, se non impossibile, non notare quanto fosse disperato… Non notare la paura nella sua voce.»
Mi portai le mani a tapparmi il naso e la bocca, mentre le lacrime si facevano prepotenti dietro gli occhi. “Ma allora…”
«E io gli ho detto una cosa davvero cattiva… Ma in quel momento era quello che pensavo, davvero…»
“Quello che ho sentito era davvero il suo odore? Che sia davvero venuto all’ospedale? Ma… allora era in Italia? Da quanto… Perché non… Non posso credere che abbia davvero…”
«Idra, una parte di me mi sta odiando per quello che sto per dirti, ma…» Elsa chiuse gli occhi, si morse il labbro, dopodiché sentenziò: «Credo che Arkin sia la metà del tuo essere umano perfetto diviso da Zeus.» Tirò un sospiro pesante, il suo corpo si rilassò di colpo, come si fosse appena liberato da un peso incommensurabile che aveva portato fino a quel momento.
«Lo so…» Il mio fu un sussurro tremante, che non riuscii a fermare, pronunciato nel gesto di nascondere il volto tra le gambe. «Lo so… Però… fa male…» Mi strinsi le mani al petto, all’altezza del cuore. “Il peso ora ce l’ho io, proprio qui…”
Forse, però, era giusto così. Dio aveva accolto la mia preghiera di quella notte al retone, dando a me il dolore dei dubbi di Elsa… L’avevo chiesto io, in fondo, quel peso. E allora perché faceva così male?
Percepii le braccia di Elsa avvolgermi in un abbraccio, avevo come l’impressione che i ruoli si fossero invertiti. Era questo il mio destino? Fare passa e prendi con il dolore? Appena esso mi abbandonava, lo volevo indietro e appena lo riottenevo volevo che mi lasciasse in pace?
“Ehi Zeus, cos’è un tuo scherzo questo? È il tuo modo per non far riunire le metà che hai separato? Oppure per “costringerli” a riunirsi? Un giochetto da soap opera che ti diverti a vedere, da lassù? Sappi che se è così… se è opera tua… sei davvero un grandissimo bastardo.”
«Hvorfor ser du ikke på meg som om jeg er gal? (Perché non mi guarda come fossi pazzo?)»
Sdraiato sul lettino di pelle nera nello studio dello psicologo - chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stata una scena veritiera? -, mi voltai interrogativo, curioso, verso di lui. Gli avevo appena raccontato della morte di Paolo.
«Forklar deg selv bedre. (Si spieghi meglio.)»
«Jeg kunne ha sverget at han ville se på meg med medlidenhet. Eller med øynene du ser på en idiot. (Avrei giurato che mi avrebbe guardato con pietà. O con gli occhi con cui si guarda un idiota.)»
Gunner inclinò appena il capo, intimandomi silenziosamente di spiegarmi meglio. Io alzai le spalle, distogliendo per un attimo lo sguardo. «Noen ville dømme meg som en idiot for å tro at Pauls død var min feil. Jeg var en tretten år gammel uten fremtidens sfære, jeg kunne ikke vite hva som skulle skje. Ingen tilregnelig person vil klandre meg for hans død ... Hvis jeg tenker på det objektivt, kaller jeg meg selv en idiot for denne følelsen av skyld som griper magen min hver gang jeg tenker på det. (Chiunque mi giudicherebbe un cretino per pensare che la morte di Paolo sia colpa mia. Ero un tredicenne senza la sfera del futuro, non potevo sapere cosa sarebbe successo. Nessuna persona sana di mente mi darebbe la colpa della sua morte… Anch’io, se ci penso oggettivamente, mi do dell’imbecille per questo senso di colpa che mi attanaglia lo stomaco ogni volta che ci penso.)»
«Jeg er ikke her for å dømme deg, Arkin. Det er ikke slik terapi fungerer. (Io non sono qui per giudicarla, Arkin. Non è così che funziona una terapia.)»
Alzai lo sguardo verso il soffitto, storcendo inspiegabilmente le labbra.
«Det burde hun heller ikke. (E nemmeno lei dovrebbe.)»
Mi scappò una risatina scoraggiata. Facile parlare, vorrei vedere lui come supererebbe lo shock di vedersi morire il proprio fratello davanti agli occhi.
«Du ble bare sint. (Lei si è appena arrabbiato.)»
Mi voltai verso di lui, corrucciando lo sguardo. «Nei… jeg er ikke sint… (No… non sono arrabbiato…)»
«Han er fornærmet. Var det det jeg sa som fornærmet deg? (È offeso. È stato quello che ho detto ad averla offesa?)»
«Jeg... (Io...)»
“Ma chi è questo tizio?” Scossi la testa con forza, cercando di tirare un sorriso. Mi misi a sedere, le braccia lungo il torso. «Hun er veldig god, pokker … (Lei è davvero bravo, diamine…)»
«Timen er nesten over, men jeg har ingen andre avtaler for dagen. Vil du snakke litt med meg om den andre jenta også? (L’ora è quasi finita, ma non ho altri appuntamenti per la giornata. Vuole parlarmi un po’ anche dell’altra bambina?)»
Riflettei qualche istante. «Ville det ikke vært bedre å takle ett problem om gangen? (Non sarebbe meglio trattare un problema alla volta?)»
«Hvem vet hvorfor jeg har følelsen av at disse to “problemene”, som du kalte dem, er nært knyttet til hverandre. (Chissà perché ho come la sensazione che questi due “problemi”, come li ha chiamati lei, siano strettamente collegati tra loro.)»
Sospirai profondamente, il volto ancora nelle mani.
Mi rimisi sdraiato e iniziai a raccontare di Cam.
Fu più complicato, molto più difficile. Ebbi bisogno di interrompermi più volte. Non seppi nemmeno spiegare perché, ma se con Paolo ero riuscito a trattenere le lacrime, parlando di Cam non ebbi la stessa forza.
«Che ne dici, come sto?»
Sorrisi, facendo una giravolta davanti alla foto di Paolo, incorniciata dal marmo.
Feci un giro soltanto, dopodiché mi fermai con le mani unite dietro la schiena e questa leggermente protesa in avanti. «Scusa per non essere venuta per un po’, una certa scimmietta bionda mi ha impedito di allontanarmi dal letto per qualche giorno, dopo l’incidente.»
Chinai un attimo la testa.
«Ma che te lo dico a fare, lo so che tanto lo sapevi già… Scommetto che qualche chiacchieratina con Sergio te la sei fatta, chissà che ti ha raccontato di me… Non devi credere a tutto quello che ti dice però, okay? Ero un’adolescente strana...»
Alzai lo sguardo. «Anche se con te non ho mai avuto bisogno di scusarmi di niente, era sempre il vichingo che si scusava per me… come quando vi ho strappato le cinture dei grembiuli mentre giocavamo a cani e padrona…» Una piccola risatina mi distese le labbra. «Ero talmente dispiaciuta che poi sono scappata e mi sono andata a nascondere in un angolino ad aspettare la fine della ricreazione… Poi però tu mi hai scovato e mi hai fatto uscire, e Arkin ti ha chiesto scusa per il grembiule dicendo che era colpa sua, perché aveva iniziato a tirare troppo forte e ti aveva spinto ad andargli dietro. E tu hai semplicemente sorriso, preso le cinture di stoffa e te le sei legate a mo’ di benda… e abbiamo iniziato a giocare a moscacieca… Ricordi?»
Nostalgia.
Non ottenni risposta, ovviamente. Non me ne aspettavo una. «Sai, ultimamente ci pensavo…» Avvicinai una mano e accarezzai il volto di Paolo con tutta la delicatezza di cui ero capace. «Se tu dovessi effettivamente rispondermi, andrei fuori di testa per la paura…» Un piccolo sorriso divertito mi si dipinse sulle labbra, per trasformarsi un secondo dopo in uno triste. Sfiorai la pietra gelida con la fronte. «Però, allo stesso tempo… non sai quanto mi piacerebbe poter sentire di nuovo la tua voce…»
Il suono del cellulare mi distrasse, facendomi tornare al presente. Era la sveglia, era arrivato il momento di andare.
Non potevo fare tardi al matrimonio della mia migliore amica.
«Du smiler. (Sta sorridendo.)»
«Jeg gråter som en gal … (Sto piangendo come un demente…)» Ribattei io, mentre abbassavo la mano. Ma non riuscii a smettere di sorridere.
«Han er forelsket i denne jenta. (È innamorato di questa ragazza.)»
«Er det et spørsmål eller en uttalelse? (È una domanda o un’affermazione?)» Non so perché non lo guardai, ma il soffitto di quella stanza era davvero troppo interessante. Completamente piatto e azzurro, sembrava di guardare un pezzo di cielo sereno. Calmava.
«Fortell meg. (Me lo dica lei.)» Lo sentii sorridere. «Hvorfor ville han ikke fortelle deg at han bor i Arendal? (Perché non le ha voluto dire che vive ad Arendal?)»
Mi morsi il labbro, nervoso. Mi alzai a sedere con un colpo di reni e mi voltai verso di lui: «Hvorfor forteller du meg ikke det? (Perché non me lo dice lei.)» Lo attaccai, senza volerlo davvero. Un’ondata di nervosismo, agitazione, frustrazione mi aveva come investito in pieno. «Fordi jeg ikke vil ha et langdistanseforhold. Fordi jeg ikke kunne be henne om å komme til Norge med meg. For hadde han sagt nei, hadde jeg blitt sur. Fordi hun hadde vært gal for å si ja. Fordi jeg ikke ønsket å miste det. For det jeg gjør med henne, det er feil ting! (Perché non voglio una relazione a distanza. Perché non potevo chiederle di venire in Norvegia con me. Perché se mi avesse detto di no, sarei impazzito. Perché sarebbe stata una pazza a dirmi di sì. Perché non la volevo perdere. Perché qualunque cosa faccio con lei, tanto è la cosa sbagliata!)» Mi misi le mani nei capelli, la voce rotta. «Fordi ... jeg orker ikke miste henne ... Og hvis hun har det bra nå ... så har jeg det også ... Hvis du elsker noe, må du være i stand til å la det gå ... Jeg Jeg har fortalt det til meg i flere måneder, men ... fordi det ikke fungerer! (Perché… non posso sopportare di perderla… E se sta bene ora… allora sto bene anch’io… Se ami qualcosa, devi essere in grado di lasciarlo andare… Me lo continuo a ripetere da mesi, ma… perché non funziona!)»
«Husker du hva jeg fortalte deg først da vi møttes? (Si ricorda quello che le ho detto come prima cosa quando ci siamo conosciuti?)» Mi porse un fazzoletto di carta.
«Å lage to skudd for en kurv. (Di fare due tiri a canestro.)» Risposi io, con un sorriso di stizza.
«Etter. (Dopo.)» Sorrise lui, paziente. Ma quel sorriso mi fece distendere un poco i nervi. «At vi ikke har evnen til å kontrollere andres følelser. Vi må ikke ønske å kontrollere dem. (Che noi non abbiamo la possibilità di controllare le emozioni degli altri. Non dobbiamo volerli controllare.)»
«Deretter… (Quindi…)» Giocai con il pezzo di carta tra le mani. «Du er enig med meg ... Jeg hadde rett i å forlate deg i Italia … (Lei è d’accordo con me… Ho fatto bene a lasciarla in Italia…)»
Gunnar attese qualche secondo prima di rispondere. «Hun burde ha gitt oss begge valget. (Lei avrebbe dovuto concedere a entrambi la possibilità di scegliere.)»
«Hvorfor begge deler? Hva har jeg med det å gjøre? Jeg velger. (Perché entrambi? Che c’entro io? Io ho scelto.)»
«Det var ikke hun som valgte. Ikke den voksne lei, den nå. Det var frykten hennes som gjorde hennes valg; den personifiseringen av den tretten år gamle lei, den som er traumatisert av tapet av venninnen. (Non è stato lei a scegliere. Non il lei adulto, quello di adesso. È stata la sua paura ad aver scelto; quella personificazione del lei tredicenne, quella traumatizzata dalla perdita del suo amico.)»
“Dovevo andare via alla prima ora e finirla con Paolo.”
«Etter venninnens død har hun etablert denne selvforsvarsmekanismen som gjør at hun kan komme nær mennesker, men bare opp til et visst punkt. Hun ønsker ikke vennskap eller forhold som er for dype, noe som vil være i stand til å ødelegge henne psykologisk i tilfelle avvisning eller oppgivelse. For det var det som skjedde med Paolo. Han klarte å ha denne typen forhold til de "nye" menneskene, hvis du vil definere dem, hvem han møtte etter traumet; men Camilla er ikke en ny person, med henne ville han aldri kunne ha et forhold som ikke var dypere, uansett om det var en romantisk følelse bak ham eller forble rent vennskap. Hun mener at Pauls død er hennes skyld, hennes egne avgjørelser. Enten det var hun som tvang ham til å komme til fotballmøtet, om det var hun som presset ham til å score. At disse valgene du la på vennen din er årsaken til hans død. Dette var grunnen til at hun måtte gå og sjekke at Camilla var i live, at hun hadde det bra, etter at søsteren ringte henne. Han var redd for at valget hans om å forlate henne i Italia hadde presset henne mot den ulykken. (Dopo la morte del suo amico, lei ha instaurato questo meccanismo di autodifesa che le permette di avvicinarsi alle persone, ma solo fino a un certo punto. Non vuole amicizie o rapporti troppo profondi, che sarebbero in grado di distruggerla psicologicamente in caso di rifiuto o abbandono. Perché è quello che è successo con Paolo. È riuscito ad avere questo tipo di rapporto con le persone “nuove”, se così si vogliono definire, che ha conosciuto dopo il suo trauma; ma Camilla non è una persona nuova, con lei non sarebbe mai riuscito ad avere un rapporto che non fosse più profondo, indipendentemente dal fatto che ci fosse un sentimento romantico alle spalle o rimanesse puramente di amicizia. Lei pensa che la morte di Paolo sia colpa sua, delle sue decisioni. Che sia stato lei a costringerlo a venire al raduno di calcio, che sia stato lei a spingerlo a fare goal. Che queste scelte che lei ha imposto al suo amico, siano la ragione della sua morte. È per questo che ha dovuto andare a controllare che Camilla fosse viva, che stesse bene, dopo che sua sorella l’ha chiamata. Aveva paura che la sua scelta di lasciarla in Italia l’avesse spinta verso quell’incidente.)»
“Cazzo.”
«Du er en veldig selvsentrert type, vet du? (Lei è un tipo molto egocentrico, lo sa?)» Gunner mi sorrise, mentre lo guardavo ancora con la bocca aperta, incapace di articolare parola.
“Io… non penso tutto questo… Sono cose irrazionali. Stupide, da pensare.”
«Underbevisstheten er ikke rasjonell, Arkin. Det er derfor det er så vanskelig å kontrollere det. (Il subconscio non è razionale, Arkin. Per questo è così difficile controllarlo.)»
Lo psicologo si alzò dalla sua poltrona e venne a sedersi al mio fianco. Parlò guardando avanti a sé, un sorrisetto in volto di chi era perfettamente consapevole di aver fatto centro: «Arkin, verden dreier seg ikke om henne, og hun er ikke arkitekten for alle ulykkene, så vel som underverkene, som skjer i hennes bekjentskapskrets. Jeg beklager å fortelle ham, men han er ikke så mektig. Praktisk talt ingen er det. (Arkin, il mondo non gira intorno a lei e lei non è l’artefice di tutte le disgrazie, così come le meraviglie, che accadono nella sua cerchia di conoscenze. Mi dispiace dirglielo, ma non è così potente. Praticamente nessuno lo è.)» Si voltò verso di me, io che ancora guardavo in basso. «Det vi trenger å jobbe sammen er å få henne til å redusere viktigheten som underbevisstheten hennes presser henne til å ha av seg selv, hva sier du? (Ciò su cui dobbiamo lavorare insieme è farle ridimensionare l’importanza che il suo subconscio la spinge ad avere di se stesso, che ne dice?)»
Solo in quel momento lo guardai negli occhi, come calamitato da una forza invisibile e sconosciuta. Ancora incapace di parlare, annuii sommessamente.
“Ma questo qui è umano?”
Non eravamo in una chiesa immersa di fiori, ma in una sala del comune piuttosto austera.
La cerimonia… Quando avevo chiesto a Elsa se fosse sicura di volersi sposare in comune anziché in Chiesa, dire che la sua risposta mi avesse lasciata basita era nulla.
«Costa meno.»
L’aveva detto con uno dei suoi sorrisi più belli a illuminarle il volto. Mi era venuto da piangere per lei. Perché lo sapevo, sapevo benissimo che lei fosse una di quelle inguaribili romantiche che aveva sempre sognato il matrimonio delle favole. Quello in un’enorme chiesa, con mille invitati, il vestito bianco candido che la rendeva regina in mezzo a tutti quei fiori sparsi sulle panche e quelle luci colorate che entravano dalle immense finestre.
Ah… Il vestito…
Altra nota sulla quale mi disperai io per lei. Elsa aveva sempre avuto in mente il suo vestito da sposa: un abito bianco ghiaccio, con lo scollo a cuore e il corpetto rigido coi fianchi costellati da brillanti e decorazioni floreali. Una gonna semplice sul davanti, ma con delle rose alla base della vita dalle quali uscivano strascico e balze. Dei guanti lunghi fino alle spalle e un velo lungo, immenso, che avrebbero dovuto reggere i paggetti durante la sua camminata verso l’altare e che le sarebbe ricaduto davanti al viso durante la cerimonia, per poi avere Leonardo che le avrebbe liberato il volto quando il prete avesse dato loro il permesso di baciarsi.
Invece indossava un semplice abito bianco, lungo appena alle caviglie, un paio di décolleté chiare dal tacco modesto. Non aveva i guanti e non aveva il velo.
Distolsi gli occhi dal sindaco, che aveva finito di dichiarare i due marito e moglie, per posarli sui neo sposi. E mi scappò più di una lacrima, mandando a fare in culo il trucco per il quale mi ero impegnata troppo più del dovuto, visto comunque lo scarso risultato.
«Ma perché questa fretta? Perché non aspettate come avevate detto? Oh.», le avevo preso il braccio con una mano, guardandola dritta negli occhi, preoccupata. «Ma che sei incinta?»
Per tutta risposta, Aurora si era messa a ridere. «Che tragica che sei!»
«Tragica ‘na sega, Elsa! Voi due mi state correndo a mille e non si capisce per cosa!» Avevo risposto io, iniziando davvero a preoccuparmi che potesse essere successo qualcosa.
Aurora era rimasta con il sorriso che non accennava a sparire. Aveva alzato lo sguardo verso il cielo stellato e aveva detto, semplicemente, con tutta la naturalezza del mondo: «Io lo amo.»
Sapevo che la stavo guardando strano, confusa, ma d’altronde non potevo farne a meno.
«Ora che casa è pronta, voglio poterci entrare con lui da marito e moglie. Non mi importa se non ci possiamo permettere la cerimonia, il vestito dei sogni, la luna di miele… Non mi interessano più queste cose. Non ho bisogno di loro per essere felice, per loro ci sarà sempre tempo. Nessuno ci vieta di fare un matrimonio in chiesa un domani, con un grande ricevimento e il vestito più bello del mondo. Ma se sono sicura di una cosa è che non voglio sposarmi perché sono incinta, e allo stesso tempo non voglio dover aspettare un sacco di anni solo per potermi permettere il “matrimonio tradizionale” per poter finalmente poi rimanere incinta e creare la mia famiglia.»
Più parlava e meno la capivo. Aveva 22 anni Cristo Santo, non 40. Davvero aveva paura di non essere in tempo?
«La realtà… È che questo desiderio l’ho sempre avuto, ma non lo sapevo. Non lo riconoscevo in questa forma, perlomeno. È come se ci fosse sempre stato, ma non gli avevo mai dato ascolto… Come faccio a spiegarti…»
Ma cos’era, ubriaca? O forse l’ubriaca ero io…
Si era voltata verso di me e mi aveva guardata dritta negli occhi, coi suoi color miele e dolci come tale. «Idra, sai che se a Leo succedesse qualcosa di grave, davvero grave, io non potrei nemmeno entrare in ospedale per vederlo? Anche se viviamo insieme, solo perché legalmente non sono sua moglie, non sono niente.»
Avevo strizzato gli occhi, avevo cercato di capire quello che cercava di dirmi.
«E lo stesso lui con me. Io non voglio questo, non lo voglio assolutamente. Se mi succede qualcosa, voglio che la persona che amo possa stare al mio fianco. In salute e in malattia, hai presente?»
Mi ero ritrovata a distogliere lo sguardo e abbassare il capo, annuendo senza nemmeno rendermene conto. Poi un flash.
«È... colpa mia se state correndo così?», le avevo chiesto terrorizzata. «È per quello che è successo a me? Vi ho messo paura io? Guarda che se è così, non dev...»
Elsa mi aveva stretto le guance con la mano, impedendomi di proseguire con uno sguardo di fuoco. «Tu osa solo aggiungere un’altra parola, e ti strappo le labbra.»
Aveva atteso qualche secondo, poi aveva rilasciato la sua presa su di me e, dopo un sospiro, mi aveva avvolta gentilmente in un abbraccio. Con il capo sul suo seno, non potevo vederle il volto, ma sapevo che indossava la sua espressione da ragazza innamorata persa. Bastava ascoltare il battito del suo cuore e la sua voce tranquilla per capirlo, e calmarsi di conseguenza. «Non mi importa nulla della festa, io voglio poterci essere per Leonardo e voglio che lui possa esserci per me. Anche sotto gli occhi della Legge. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è il sentimento che ci lega l’un l’altro, e non ci serve una festa della durata di un giorno e più per dimostrarlo. Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, se non a noi due. In questo rapporto ci siamo noi due, non gli altri, capisci?»
Sì, capivo. Ma comunque non mi tornava. Forse stavo solo cercando di capire, mentre in realtà non ci stavo cavando fuori un ragno dal buco.
Avevo alzato gli occhi e l’avevo guardata, cercando di capire quanto di ciò che mi aveva detto fosse la verità, se fosse ciò che pensava davvero. Perché se era davvero così convinta come affermava, allora sapevo che sarebbe andato tutto bene.
«Mi farai da testimone?» Mi aveva chiesto, ancora. Io avevo tirato un sorriso, che avevo fatto cercare di essere il più sincero possibile, e avevo annuito. Elsa aveva aumentato la presa dell’abbraccio, contenta, euforica.
Mi ci era voluto qualche secondo prima di circondarle la schiena e ricambiare.
Osservai le espressioni del neo-sposi mentre si guardavano negli occhi e mi asciugai un’altra lacrima. Non versai nemmeno una goccia di sale per disperazione, o tristezza o qualsiasi altro sentimento del genere, no. Le lacrime che mi scendevano erano tutte di pura gioia. E commozione. Perché, nonostante non fosse avvolta nel suo abito color ghiaccio, immersa nei fiori in una chiesa, Aurora non era mai stata così bella in vita sua.
Vedendola così, capii il vero significato dell’esser “vestiti d’amore”. Perché era Amore quello che si leggeva negli occhi di Aurora e Leonardo quel giorno. E allora capii tutto quello che la mia amica mi aveva detto poche sere prima. E le detti ragione.
Non appena la cerimonia fu terminata, Leonardo prese Elsa in braccio e percorse la “navata” così, con lei che rideva come una bambina, io e il Jolly, testimone di Leonardo, che li seguimmo, il resto dei nemmeno 50 invitati dietro di noi.
Precedetti mio cognato alla macchina e gli aprii lo sportello del passeggero, facendo cenno con la mano verso l’interno: «Mademoiselle.»
«Idra hai pianto?» Mi chiese con una faccina adorabile la neo-sposa, mentre Leo la faceva accomodare al posto del passeggero in macchina.
Prima di chiudere la portiera, mi chinai verso di lei e l’abbracciai forte. La sentii sorpresa da quel gesto, e non le potevo dare torto, ma non riuscii a trattenermi. Dopo qualche secondo, approfittando dell’attimo di privacy che ci era stata riservata, dato che Leo stava salutando gli altri invitati, le accarezzai i capelli e le sussurrai all’orecchio. «Scusami, avrei dovuto capire prima, quando hai provato a spiegarmelo.»
Elsa si liberò dal mio abbraccio e mi guardò confusa, io le sorrisi, accarezzandole la guancia: «Non avevo motivo di preoccuparmi per te, sei la sposa più bella del mondo. Anche senza il matrimonio tradizionale che abbiamo sempre fantasticato.»
Gli occhi di Aurora vennero attraversati da un velo di lacrime, che mi affrettai a far svanire storgendo le labbra e dandole due piccoli schiaffi sulle guance.
«Ehi, ma che…» Non la lasciai finire, portando la mia fronte a sfiorare la sua e guardandola dritta negli occhi, il volto ancora nelle mie mani.
Non dissi niente, non ce n’era bisogno. Quei tre secondi di scambi di sguardi ci bastarono per comunicarci tutto quello che volevo dirle.
Una parte di me stava piangendo disperata, nel dolore più assoluto. Quella parte di me stava morendo in quei tre secondi d’orologio, in cui nei nostri occhi passarono come in un film ad altissima velocità tutti i momenti che avevamo passato insieme, tutti i ricordi che condividevamo, solo io e lei. Sapevamo entrambe che da quel giorno in poi il nostro rapporto non sarebbe più stato lo stesso, lei si era sposata e, anche se questo non implicava chissà quali cambiamenti tangibili, nessuna delle due poteva mentire all’altra: non sarebbe più stata la stessa. La stessa che quella parte di me che stava soffrendo aveva amato tanto, e avrebbe continuato ad amare in eterno, ma avrebbe dovuto farlo solo mediante ricordi.
Ma questo non era un male. Affatto. Perché se la vecchia, nubile Elsa era svanita quel giorno, l’Elsa sposata era appena nata e questa versione era un milione di volte meglio.
Sarebbe stato rassicurante fingere che non sarebbe cambiato nulla da donna libera a donna sposata, ma sarebbe stata una bugia. E questo ci avrebbe rovinate. Invece, accettare che Aurora stava per iniziare una nuova parte della sua vita, che era arrivata a uno dei capitoli che le auguravo con tutto il cuore essere il più bello, soddisfacente e il più lungo della sua esistenza, era un modo per andare avanti. Per imparare a conoscere e amare quella nuova versione di lei, che era finalmente entrata a far parte, assieme alla persona che amava, di un noi.
Mi staccai da lei con un sorriso colmo d’amore sul volto, mentre Leonardo saliva in macchina. Elsa mi guardò ancora mezzo istante e, prima di voltarsi e dare un bacio a suo marito prima che mettesse in moto, le sue labbra si mossero per rivolgermi un silenzioso “grazie”.
La osservai allontanarsi, superare la collina e dirigersi verso la sua nuova casa, non riuscendo a non sorridere, emozionata. Non vedevo l’ora di conoscere quella nuova versione, migliorata ne ero certa, della mia Elsa.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 18
*** Pagina 17 ***
Pagina 17.
(The scent of air after the rain...
I hear your pulse.
I saw the light.)
Il profumo dell’aria dopo la pioggia…
Sento il tuo battito.
Ho visto la luce.
– Ao Haru Ride, Io Sakisaka
Attraversai il cancello del cimitero facendomi il segno della croce che i piedi già mi portavano da Paolo, rendendomi conto solo durante il tragitto di quanto si fossero automatizzati quei gesti. Da quando ero venuta con Arkin, lo andavo a trovare quasi tutte le settimane.
Arrivata a pochi passi dalla cappella, però, notai l'inferriata aperta e mi bloccai sul posto. Il cuore iniziò a battermi a mille e nella testa iniziò a farsi largo il pensiero di girare i tacchi e scappare, andare via prima che potesse vedermi qualcuno. Riuscii a fermarmi dopo un paio di passi, ritornando in me.
Cosa avevo da scappare? Perché dovevo avere paura di incontrare qualcuno nella tomba del mio amico?
Mi voltai ancora e mi diressi nuovamente verso il suo marmo, decisa a mantenere la promessa che mi ero fatta di andare avanti, di non scappare più dai miei sentimenti e dal mio passato. Di affrontare il dolore a testa alta.
“Non entrerò diretta, chiederò educatamente permesso a chiunque sia dentro e…” Il pensiero si arrestò non appena arrivata a un passo dalla cappella, perché una donna uscì, portandosi dietro la porta mentre si asciugava l’angolo dell’occhio.
Rimasi pietrificata. La riconobbi subito: era la madre di Paolo.
Il cuore tornò a battermi all’impazzata, una vocina in testa mi diede dell’imbecille per non essermene andata subito. Che cosa c’avevo guadagnato? Potevo benissimo tornare un’altra volta, no? Accidenti a me.
«Desidera?» Non lo disse per offendere, aveva un tono dolce. L’aveva sempre avuta Erica quella dolcezza affettuosa nella voce, tipica di chi darebbe un braccio per gli altri, anche quando non se lo meritano; Paolo l’aveva ereditata da lei, quella dolcezza infinita che possedeva.
E io dovevo avere veramente una pessima faccia in quel momento.
«Signorina, si sente bene?»
Mi sforzai di riattivare il respiro, che mi accorsi di aver involontariamente messo in pausa da quando l’avevo vista uscire dalla cappella. Balbettai qualcosa privo di senso, per guadagnare quel tempo necessario a far tornare l’ossigeno ad arrivare al cervello, e dire: «Ero v-venuta a trovare… un vecchio amico…»
Riuscii a percepire il suo sguardo interrogativo anche se i miei occhi erano fissi sui lacci delle mie scarpe.
«Lei conosceva Paolo?»
«I-io…» Alzai un istante lo sguardo, per riabbassarlo subito dopo. Mi morsi il labbro, le mani le stavo torturando tra loro, mentre cercavo non sapevo nemmeno io dove la forza di parlare, di far uscire la voce.
Chiusi gli occhi, feci un respiro profondo e dissi, seppur tremante: «Andavo all’asilo con lui…» Alzai gli occhi, infilandomi le unghie nel polso dietro la schiena, per costringermi a non riabbassarli più. «Mi chiamo Camilla.»
Gli occhi della donna si fecero un attimo interrogativi, dopodiché pensierosi, all’evidente ricerca di abbinare una faccia conosciuta al mio nome, per poi spalancarsi dopo pochi secondi di riflessione. «Camilla…» Erica mi venne incontro, l’andatura leggermente inclinata, già pronta all’abbraccio in cui mi avvolse. Non appena le sue braccia mi circondarono, non riuscii più a trattenere le lacrime.
Erica mi guardò sorridente, asciugandomi le lacrime che stavo odiando con tutta me stessa con le sue mani morbide. «Sei diventata così bella…» Mi sussurrò con un sorriso meraviglioso, mentre io stringevo i denti per cercare di trattenermi e smettere di piangere come una piccinaccola, senza riuscirci. C’erano tante cose che avrei voluto dirle, prima di tutto farle le mie scuse per non essermi fatta più viva, e le mie condoglianze. Ma in quel momento riuscivo a malapena a respirare, figuriamoci a parlare.
Dopo qualche minuto mi calmai, riuscendo a riavere il controllo su quel dolore che provavo da una vita, ma mi sembrava così nuovo. Forse perché finalmente avevo smesso di tentare di non riconoscerlo, di non dargli nome.
Lutto.
Era questo il suo nome. Da quel momento in avanti lo avrei chiamato così.
«Sei davvero cresciuta bene, sai.»
La voce di Erica rimbombava leggermente dentro la piccola cappella. Eravamo entrambe davanti alla bara di Paolo e gli occhi della donna non si staccavano dal sorriso del mio amico.
«Posso… chiedere che cosa l’ha ucciso?»
Non riuscii a credere di averlo detto davvero a voce alta, non seppi dire da dove venne fuori quella domanda in quel momento, mi sarei voluta nascondere a vita non appena avevo formulato il quesito.
Erica però non si offese, o almeno non lo dette a vedere, e mi rispose con il suo solito tono colmo d’affetto: «È stato il suo cuore.»
La mano mi sfiorò il petto, quasi inconsciamente, mentre abbassavo lo sguardo.
«Il medico ci disse che si è trattata di una malformazione cardiaca congenita, impossibile a quei tempi rendersene conto per tempo. Durante la fase di adolescenza il cuore non si sviluppa come dovrebbe e, così, da un momento all’altro, senza nessun preavviso, smette di funzionare.»
Strinsi la stoffa della maglia, dietro la quale si nascondeva il mio organo vitale. Che batteva, funzionante, che mi regalava ogni secondo della mia vita senza che io nemmeno me ne accorgessi.
«Era destino.»
Destino. Ma che davvero? Solo per sfiga? Uno nasce con un problema che lo ucciderà in adolescenza, così, da un momento all’altro, e non lo sa nemmeno?
Ma che stiamo scherzando?
La vista tornò a farsi nebbiosa, le lacrime stavano tornando. Rabbia. Impotenza. Vergogna, sì anche lei. Cazzo, odiavo pure dar loro un nome.
Mi ricordai di Erica solo quando, dopo qualche istante, mi si rivolse nuovamente: «Te come va Camilla? Ti senti ancora con Arkin? Avevate un’amicizia così bella, voi tre.»
Arkin.
Paura.
Nostalgia. Gioia. Eccitazione.
Alzai lo sguardo, osservai la foto del mio amico.
“Il contrario di rassegnazione, come si chiama?”
Parlai come in trance, senza rendermi davvero conto di quello che stavo dicendo: «Sì, siamo ancora in contatto.»
“Ho bisogno di fare una chiamata.”
Il suono della pioggia che batteva sulle vetrate dell'aeroporto era completamente inudibile da dentro, sovrastato dal parlottare delle gente, gli annunci, la musica e la pubblicità proveniente da schermi, cellulari e altoparlanti.
“Questo posto è davvero caotico…” Da piccola avevo viaggiato spesso con mio padre dopo il divorzio dei miei. Mi aveva portata anche dall’altra parte del mondo, per farmi fare una vacanza, per dimostrarmi che lui a me ci teneva, ma non avevo mai capito l’ansia che poteva provare un genitore nel perdere il figlio.
Non avevo idea di come fossero messe le cose al giorno d’oggi, ma quando ero bambina io, i bimbi che sparivano all’interno degli aeroporti erano una minaccia reale. Mio padre non mi lasciava mai la mano quando viaggiavamo, anche quando si doveva attraversare il metal detector si assicurava sempre di farmi passare per prima e non mi toglieva mai gli occhi di dosso. “All’epoca lo reputavo un atteggiamento un po’ oppressivo, oggi credo che farei lo stesso.”
Senza quasi rendermene conto, giunsi agli arrivi.
In mezzo a tutte quelle persone, eccitate di rivedere i propri cari, diedi una veloce occhiata al volo che mi interessava. Sarebbe dovuto essere il prossimo a uscire. Ricontrollai, per la millesima volta, la conversazione che avevo avuto con Gemma qualche giorno prima.
“Arkin dovrebbe aver preso questo volo… Ma se invece non ci fosse, che diamine ci sto a fare io qui?” Scossi la testa, cercando di scacciare quei pensieri. “No, ormai ho preso una decisione. Gli devo dire quello che provo una volta per tutte. E… se lui non prova lo stesso, addio. E chiuderla qui, fine della discussione! Ma me lo deve dire in faccia, dannazione! E per bene!”
«Come sarebbe a dire che non sei venuta a prendermi? Sei stata tu a insistere che dovevo venire a tutti i costi in Italia, o sbaglio? E mi molli in aeroporto? Mo' lo paghi te il taxi.»
Alzai lo sguardo, il suo profumo arrivò al mio cervello ancor prima della sua voce, il resto del mondo era come improvvisamente sparito in una nuvola di ovatta.
«Mi dici allora ora come ci arrivo io a casa, genio?»
I nostri occhi si incrociarono, e la mia anima rimase imprigionata in quegli zaffiri, senza volerne più uscire.
Arkin si arrestò sulla soglia degli arrivi, fu tutto come una sensazione di déja-vu, ma stavolta nessuno dei due corse ad abbracciare l’altro. Fu la gente dietro di lui a farlo riscuotere e muovere. Il mezzo norvegese sussurrò una singola parola al telefono, che non capii, dopodiché si diresse verso di me e, con un movimento quasi impercettibile della testa, mi fece cenno di seguirlo.
Uscimmo dall'aeroporto, camminando fino ai giardini lì vicino, dove Arkin si fermò a pochi passi da me. Nessuno dei due aveva ancora spiccicato parola.
Nessuno dei due aveva un ombrello e la pioggia primaverile di fine Marzo ci sfiorava leggera, ma non ci facemmo caso.
Strinsi le mani, per farmi coraggio, mentre il vai e vieni delle persone attorno a noi si faceva sempre più assente ai miei occhi. «Se ti stai chiedendo perché sono venuta, sappi che è perché devo dirti che ti odio.»
Lui rimase in silenzio, non fece un passo. Non mi guardava nemmeno, era girato dall’altra parte. Stava immobile, in silenzio, e basta.
«Avevo incontrato un ragazzo meraviglioso e sono stata costretta a mandare tutto a quel paese per colpa tua. Non è giusto… Quello sarebbe potuto diventare l’uomo della mia vita, diventare il padre dei miei figli… Era una persona fantastica, perfetta per me! E invece io ho dovuto mandarlo via per colpa tua… Perché ogni volta che stavo con lui volevo stare con te, faccia a schiaffi! Perché ogni volta che lo baciavo volevo che fossero le tue stupide labbra! Perché ogni volta che lo guardavo negli occhi, sognavo di star fissando invece quei tuoi stronzissimi zaffiri!»
“No… Aspetta Cam… Non è così che glielo volevi dire… Non è questo che gli volevi dire! Tu… volevi dirgli che lo ami, non che lo odi, dannazione! Perché mi sto incazzando così!”
«Hai finito di insultarmi?» Lo disse atono, senza muovere un muscolo, mentre mi dava ancora le spalle, anche la mano sulla maniglia del trolley era rilassata. E quel suo atteggiamento mi fece calare un velo rosso davanti agli occhi.
“Come può stare così tranquillo quando io riesco a malapena a controllarmi? Quando è un anno che non ci vediamo! E io che sono anche venuta fin in aeroporto e lui resta impassibile così?”
«No!» Lo gridai, sbattendo il piede a terra e i pugni stretti lungo i fianchi, come fosse la bizza di una bambina. Non mi importava nulla di chi potesse sentirmi, di chi si trovasse attorno a noi, del fatto che stessi facendo una scenata in piena regola.
Con il volto abbassato e la vista offuscata dalle lacrime - di rabbia, gioia, dolore -, vidi le sue scarpe da ginnastica a un passo da me. Percepii il profumo della sua pelle, che non avevo mai smesso di amare, e solo in quel momento mi resi davvero conto del casino in cui mi ero andata a ficcare. “Che cazzo ho fatto…” Avevo detto addio a un ragazzo che poteva offrirmi una vita tranquilla, serena, senza litigi e piena d'amore… per dire addio, come volevo io, ad Arkin. “Ma che credevo… Che diamine ci faccio io qui…”
Forse non mi ero impegnata abbastanza con Mattia, forse sarei riuscita a innamorarmi davvero di lui, forse ero ancora in tempo, se solo…
“No.”
«Sono io quello giusto per te, l’unico che può diventare il padre dei tuoi figli.»
Alzai appena lo sguardo, quel tanto che bastava per vedere l'espressione di Arkin. E non ebbi bisogno d'altro. “Non voglio vivere in una bugia, e un amore con Mattia sarebbe solo una bugia da parte mia…”
«Sono io l’unico che può amarti davvero.»
Cercai di trattenermi, ma un piccolo sorriso mi distese le labbra, mentre nuove lacrime mi scorrevano dagli occhi. “Eros, piccolo bastardo… Allora ci sei di mezzo anche te…” Le asciugai nervosamente, riprendendo il controllo di me stessa: il fatto che mi dicesse che fosse in grado di amarmi, non mi bastava per stare serena. Non potevo farmelo bastare, non così.
«Se è vero...» Strinsi i pugni. «Se è vero che puoi amarmi…» Lo guardai dritto negli occhi. «Allora quantomeno bac...» Non mi lasciò finire la frase. Mi prese il volto fra le mani e le nostre labbra si unirono.
Fu un bacio completamente diverso dal primo: non c'era nulla di dolce, era come se racchiudesse tutto il dolore e la mancanza che avevamo provato negli ultimi mesi, nell’ultimo anno. E tutto il desiderio che avevamo accumulato e avevamo un assurdo bisogno di sfogare, assieme a una muta promessa di non farci soffrire mai più come avevamo già fatto in passato, troppe volte.
Senza rendermene conto, le lacrime avevano iniziato a scendere piano, anche se costanti, e i sentimenti che le animavano erano completamente diversi da quelli che avevano dato loro vita.
Arkin mi guardò negli occhi, la fronte a sfiorare la mia, il respiro leggermente affannato, come il mio. «Sì, ti bacio. Non aspettavo altro che il tuo permesso. E no, non è un errore. Non lo è mai stato.» I suoi pollici andarono a catturare le mie gocce di sale. «Non piangere occhi multicolor, non voglio mai più vedere queste lacrime. Non voglio mai più vederti triste.»
«Sono lacrime di gioia, cretino!» Mugolai a denti stretti, senza riuscire a trattenere un sorriso. Lui rise, al settimo cielo: «Allora questo cambia tutto!»
«Deficiente...» Sussurrai, trattenendo a stento le risate.
Ci riempimmo di baci, brevi e divertenti, mentre ridevamo felici. Parlammo tra un bacio e una risata: «Sei… completamente mezza… Ti costava tanto… portare… un ombrello?»
«Senti da che… pulpito… Non ci ho pensato… all’ombrello… okay?»
«Perché tu... lo sappia... la mia testa... è ancora un... completo disastro... Però... ci sto lavorando.»
«Bene... perché... anche le mie emozioni... sono un gran... casino... e hanno bisogno... di un nome... E... ci sto ancora... lavorando.»
Arkin sorrise divertito qualche secondo, prima di azzerare nuovamente la distanza tra di noi per un bacio più lungo, più tenero.
Interruppe di nuovo la nostra unione, stavolta un po’ più a lungo, come scusa per prendere aria. Tenendomi ancora il volto fra le mani, mi guardò negli occhi e chiese: «Possiamo lavorarci insieme?»
Paura.
«Se non scappi dall’altra parte d’Europa.» Sussurrai dopo qualche secondo io, ed ebbi come la sensazione di aver rotto qualcosa.
Ansia. Senso di colpa.
Arkin mi accarezzò la guancia, il suo sguardo vagò per un attimo sulla punta del suo pollice, che raccoglieva l’ultima mia lacrima. Gli occhi seri tornarono poi a incatenare i miei, mentre la sensazione alla bocca dello stomaco mutava ad ogni sua parola: «Verresti assieme a me, dall’altra parte d’Europa?»
Meraviglia, esitazione, felicità.
Mi ci vollero un paio di secondi, forse per essere davvero sicura che fossero i nomi giusti, e il corpo mi venne invaso da brividi potenti quanto inaspettati. Terrore… Per un istante temetti si trattasse di un attacco di panico, ma poi chiusi gli occhi e ascoltai i battiti del mio cuore. “Non è paura, questa è… eccitazione?” Quasi senza rendermene conto, annuii. Fiducia.
Le nostre labbra tornarono a unirsi, e, per chissà quale ragione, una parte di me era certa che tra noi ci fosse chimica, in tutti i sensi, anche se non ci eravamo mai esplorati ancora.
Un barlume mi fece tornare in mente una cosa, facendomi interrompere il bacio: «Dopo la laurea però.»
«Quand è?» Mi accarezzò appena la fronte per liberarla da qualche capello dispettoso che stava iniziando a farmi il solletico, mentre il cuore mi saliva in gola.
«Luglio.» Riuscii a sussurrare alla fine. Lui storse le labbra, e io mi sentii morire. Stavo per dargli un pugno, quando scoppiò a ridere, divertito dall'espressione che gli avevo regalato. «Sto scherzando! Ovviamente sto scherzando, certo che organizzeremo tutto dopo la tua laurea, o quando ti sentirai pronta. Ci sono tanti modi per poter ingannare la distanza, nel mentre.»
«Sei un mostro! Un mostro orribile e crudele!» Urlai, cercando di trattenere le risate, minacciando di dargli una ginocchiata tra le gambe, ma Arkin fece in tempo a scansarsi. Mi prese il volto tra le mani, mentre ancora ridevamo, riprendendo il bacio in modo divertito. Dopo poco, cambiò però gusto, divenendo un qualcosa che faceva sciogliere il petto e privava le gambe di ogni forza, regalando una sensazione di calore e benessere che non avevo mai provato prima.
Amore.
“Strano… non avrei paura a dirti che ti amo, anche adesso.” Per qualche bizzarro motivo, non mi pareva affatto troppo presto per dirlo. Magari era solo questione che lui lo conoscevo da una vita, oppure che stavo iniziando davvero a prendere gusto nel dare nomi a ciò che provavo, o anche che quel sentimento era tanto forte che il difficile era farlo rimanere in silenzio. “Forse forse…”
Mi staccai dal bacio. «Arkin…»
«Ti amo.» Non appena lo disse, sentii qualcosa dentro di me letteralmente esplodere.
Alzai lo sguardo e, probabilmente turbato dai miei occhi, cercò di rimangiarsi quanto aveva appena detto: «Scusa, io…» Lo zittii con un bacio veloce, per poi prendergli il volto tra le mani e guardarlo dritto negli occhi. «Jeg elsker deg. (Ti amo.)»
Vidi comparire il velo delle lacrime dietro quei suoi zaffiri, un lieve rossore gli prese il possesso delle guance. Ma prima che potessi commentare quella sua reazione adorabile, e onestamente anche inaspettata, mi strinse forte a sé in un abbraccio, nascondendomi il volto al suo petto.
Avvolsi le braccia alla sua schiena e rimasi piacevolmente in quella posizione, con l’orecchio poggiato al suo petto e immersa nel suo profumo, semplicemente ad ascoltare il battito del suo cuore attraverso il tepore della pelle.
La pioggia si era fermata e, non appena le ultime nuvole liberarono il sole, i suoi raggi ci raggiunsero tiepidi.
Asciugarono in breve tutto ciò che ci circondava, lasciando che il profumo di erba umida e primavera inebriasse l'aria.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 19
*** Non Scritto ***
Non Scritto.
«Stjerne, cosa fai?» Le labbra di Arkin mi sfiorano morbide il collo scoperto, la sua barba mi fa appena il solletico, mentre mi volto verso di lui con un sorriso fanciullesco. «La colazione è pronta, non vorrai farla freddare.»
«Niente, ora arrivo.»
Mi guarda negli occhi qualche secondo, poi torna eretto ed esce dal mio studio, dicendo semplicemente: «Ti aspetto giù.»
A volte mi sento completamente nuda di fronte a lui e a quelle gemme, vulnerabile come fossi ancora una bambina. Mi scrutano, mi capiscono, comprendono tutto di me ancor prima che io possa dire qualcosa. E lo stesso vale all'inverso: so bene che ha perfettamente capito cosa sto facendo, so che il suo atteggiamento disinteressato è in realtà un modo per nascondere la trepidazione di vedere il mio nuovo lavoro completo.
Poso il pennello e mi alzo, indosso la vestaglia e scendo le scale, fermandomi un attimo a osservare la tavola da pranzo alla mia destra colma di quelle che a cose normali sarebbero squisite cibarie e bevande, ma che al momento mi fanno montare la nausea solo a sapere che sono lì.
Volto a sinistra e mi metto seduta sul divano del salone, chiudendo gli occhi e cercando di pensare a un modo per farmi venire fame.
«Mademoiselle.» La voce di Arkin mi fa voltare verso di lui, tornando al presente.
«Non credi di aver esagerato con la colazione?» Chiedo, fingendo un sorriso, mentre lui mi scruta di nuovo con quei due zaffiri. Si siede accanto a me, sul bracciolo, e mi porge un bicchiere colmo di spremuta d’arancia appena fatta, rispondendo sincero: «Assolutamente no. È lo stretto necessario, se ti va qualcosa che non c’è, dimmelo che lo vado a compr-» Lo interrompo, posando la mia mano sulla sua e abbassandogliela, con il risultato che lui mi guarda preoccupato. «Arkin… Puoi per favore smettere di trattarmi così? Non sono malata, sono solo incinta.»
Lo vedo abbassare lo sguardo e storgere leggermente le labbra in un’espressione di non gradimento. Comprendo il motivo di questo suo atteggiamento quasi assillante: durante l’ultima gravidanza sono stata a un passo dal perdere il bambino perché non mangiavo nulla, ero arrivata al punto che avevo saltato talmente tanti pasti che il mio corpo si era dimenticato di come fosse mangiare tre volte al giorno. So che questo mio atteggiamento è sbagliato, lo so benissimo. Ma in gravidanza la nausea del primo semestre è spesso talmente forte che perdo completamente appetito, faccio fatica a mangiare qualsiasi cosa, anche se so che è sbagliato. Una parte di me ha sempre ammirato quelle donne che, in gravidanza, dormono 20 ore al giorno, come Elsa.
Io ho rischiato grosso, non solo per la mia salute ma anche per quella di mio figlio. Ne sono pienamente consapevole.
Poggio la testa sulla sua spalla, sorridendo tranquilla. «Ti ringrazio per tutto quello che fai, ma non c’è bisogno di tutto questo. Sto mangiando regolare stavolta, tranquillo.»
«Voglio che tu stia bene.»
«Io sto bene.»
«Voglio farti stare ancora meglio.»
Mi scappa un sorriso. Sì, è sempre lo stesso, non importa quanto tempo possa passare, Arkin è sempre il solito.
Percepisco la sua mano accarezzarmi i capelli e con essi parte della schiena, lo lascio fare e mi godo la sensazione del suo tocco leggero per un momento, prima che veniamo interrotti dal bimbo di quasi due anni che ci chiama per aprire il cancello in cima alle scale.
Arkin si alza e si dirige da nostro figlio con un sorriso, dandogli il buongiorno e scendendo con lui per mano. Appena arrivato al piano terra, il piccolo mi corre incontro e mi salta in collo, schioccandomi un sonoro bacio sulla guancia. «God morgen mamma! (Buongiorno mammina!)»
«God morgen min kjære, sov du godt? (Buongiorno tesoro mio, dormito bene?)»
Lui annuisce energico, poi fa l’espressione classica di chi si è appena ricordato una cosa importante e scende dalle mie gambe: si mette le manine a cono per tapparsi la bocca e inizia a parlare alla mia pancia, ancora relativamente piatta. Quando ha finito, Arkin gli chiede: «Lille krigeren, er alt okei? (Piccolo guerriero, tutto bene?)»
«Ja. Jeg ønsket å fortelle min søster at det er morgen, selv om det er stjerner på himmelen. (Sì. Volevo dire a mia sorella che è mattina, anche se in cielo ci sono le stelle.)»
Io e Arkin ci scambiamo un’occhiata confusa, oltretutto visto che il sesso del bebé è ancora ignoto, poi però, vedendo l’espressione orgogliosa di nostro figlio, sorridiamo anche noi e mio marito si china poggiando le mani sulle cosce, in modo da arrivare all’altezza del piccolo. «Lille krigeren, vet du hva helter gjør hver morgen for å være sterk og klar til å redde verden? (Piccolo guerriero, lo sai cosa fanno gli eroi ogni mattina per essere forti e proteggere il mondo?)»
«Frokost! (Colazione!)» Esulta il bimbo, alzando le braccia al cielo, facendomi scappare un riso.
«Vel, alle ved bordet da, kraft! (Bene, tutti a tavola allora, forza!)» Lo incita Arkin, dirigendosi verso l’altra stanza.
«Mamma også! (Anche mammina!)» Esclama il piccolo, abbracciando una mia gamba. Suo padre coglie la palla al balzo, esclamando furbo: «Selvfølgelig kommer mor også, hun må mate lillesøsteren din også. O bror. (Certo che viene anche mamma, deve dare da mangiare anche alla tua sorellina. O fratello.)» Non posso fare a meno di sospirare, ammettendo silenziosamente la sconfitta, quando mio figlio mi prende la mano e mi tira verso il tavolo da pranzo, esclamando: «Kom mamma, min søster å spise! (Mamma muoviti, mia sorella deve mangiare!)»
«Kommer, kommer… (Arrivo, arrivo…)» Sospiro ridendo, mentre vedo Arkin mostrarmi la punta della lingua vittorioso e dispettoso, con l’espressione da schiaffi migliore del suo repertorio.
Una volta giunti in sala da pranzo, ci mettiamo ognuno al proprio posto e mi ritrovo con un piccolo aspirante guerriero alto novanta centimetri alla mia destra che divora l’abbondante colazione servita dal padre, mangiando composto ma famelico. Vederlo così concentrato sul cibo che ha di fronte, mentre io non ho nessun appetito e solo l’idea di mettere qualcosa in bocca mi fa venire la nausea, mi fa sentire un po’ meglio.
Di colpo, mi viene in mente ciò che è accaduto poco prima e non posso fare a meno di chiedere: «Min kjære, hva... Hva hvisket du til babyen tidligere? Du vet at det også kan være mann, ikke sant? (Tesoro mio, cosa… Cosa bisbigliavi prima al bebè? Sai che potrebbe anche essere maschio, vero?)»
«Nei nei. Hun er en jente. Onkel fortalte meg det. (No, no. È una femmina. Me lo ha detto lo zio.)»
«Onkel? (Lo zio?)»
Gli sguardi mio e di mio marito si fanno equamente interrogativi, quando nostro figlio indica la foto sul camino alle sue spalle che ritraeva me, Paolo e Arkin da bambini e dice, con il braccio ancora alzato: «I natt drømte jeg onkel, at barnet der. Han sa til å ta vare på mamma og pappa, min søster og lære henne alt jeg vet. Og hvis jeg trenger en skytsengel, å vite at han holder et øye med meg. (Stanotte ho sognato lo zio, quel bambino lì. Mi ha detto di prendermi cura di mamma e papà, di mia sorella e di insegnarle tutto quello che so. E che se ho bisogno di un angelo custode, sapere che lui c’è e mi tiene d’occhio.)» Rimango un attimo stranita da quanto appena detto da mio figlio, ma prima che possa dire qualsiasi cosa, lo sbuffo di Arkin mi precede: «Jeg ble byttet ut med et barn, utenfor troen... (Sono stato scambiato con un bambino, da non credere…)» Lo guardo un attimo turbata, ma riconosco l’espressione dei suoi occhi e mi rilasso subito, sorridendo alla risposta di nostro figlio: «Jeg er en kriger! Jeg trenger onkels beskyttelse mer, jeg må beskytte verden! (Io sono un guerriero! Ho più bisogno io dello zio, io devo proteggere il mondo!)»
Mi scappa una risata, che attrae l’attenzione del bimbo al mio fianco, il quale guarda scettico me e poi il mio piatto, ancora intatto. Prende una fetta di pane cosparsa di marmellata di susine e me la mette alle labbra, decretando con cipiglio serio, con quella sua vocina ancora da angioletto: «Spiiiise! (Maaaangia!)» Sto per rispondere, quando mio marito si allea con lui e mi fa: «Non vorrai mica dare il cattivo esempio, non è vero?»
Scacco matto. Dannazione.
Prendo la fetta con la marmellata, sfioro la fronte di mio figlio con un bacio e, dopo avergli sussurrato un grazie, do il primo morso.
Ed è... The End.
Il tempo verbale di quest'ultimo capitolo è stato cambiato al presente deliberatamente. Questo breve epilogo può essere visto in più modi: uno sguardo al futuro/presente, di come sta andando e andrà la storia di Arkin e Cam, oppure come il sogno che fece Cam qualche capitolo fa, quando le venne la crisi di panico al risveglio.
Lo so che ho detto e ridetto che questo racconto non lo dedico a nessuno se non i suoi personaggi, e non ho intenzione di tornare indietro su questo, però un grazie speciale a chiunque abbia avuto il coraggio di arrivare fin qui, sia durante la pubblicazione che in un futuro prossimo, è doveroso. Dunque, grazie.
Un abbraccio a distanza, vi voglio bene! Ci sentiamo alla prossima, dove non so cosa scriverò, ma lo farò (cit).

     
|
Ritorna all'indice
Questa storia è archiviata su: EFP
/viewstory.php?sid=3956757
|