Castle of Glass
(/viewuser.php?uid=456594)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Hurt like hell ***
Capitolo 2: *** Shame on me ***
Capitolo 3: *** Antithesis ***
Capitolo 4: *** Hero(in) ***
Capitolo 5: *** Distance ***
Capitolo 6: *** A junkie spends half his life waiting. ***
Capitolo 7: *** Big dark secrets. ***
Capitolo 8: *** This lack of self-control I fear is never ending ***
Capitolo 1
*** Hurt like hell ***
 II cancelli della prigione si chiusero dietro la mia schiena lasciandomi finalmente solo. Solo e libero. Chiusi gli occhi respirando a pieni polmoni la ritrovata libertà, il sole tiepido di Ottobre riscaldò il mio viso donandomi una sensazione di pace così finta da risultare quasi reale. Quando riaprii gli occhi un raggio dispettoso accecò la mia vista, vidi i suoi capelli rossicci scossi dal vento e non seppi muovere un solo passo nella sua direzione. Era un’illusione? Così bella e perfetta, ferma sul marciapiede opposto, a fissarmi con occhi pieni di affetto e felicità. Sorrisi alzando un braccio nella sua direzione, il suo sorriso bastò a oscurare la palla infuocata sopra di noi. Fissai il semaforo rosso accanto a lei, quando il verde abbagliò i miei occhi attraversai andandole incontro; mentre colmavo quella distanza di pochissimi istanti il mio cervello venne sbalzato a un’epoca talmente lontana da non sentirla quasi più mia. Il ventilatore impolverato e guasto girava lentamente senza donarmi il minimo refrigerio. Steso sul divano consunto della mia casa osservavo mia madre seduta sul tavolo graffiato in legno, la mano tremante tagliava con destrezza la cocaina poggiata in maniera disordinata sulla superficie lercia. Nonostante i miei dieci anni l’infanzia è qualcosa che non ho mai sperimentato davvero, un senso pressante di disagio fece formicolare la mia pelle costringendomi ad alzarmi. Aprii il frigorifero alla ricerca di qualcosa da mangiare, lo trovai vuoto come sempre. «Non c’è nulla da mangiare..» la mia voce atona non sembrò attirare la sua attenzione. «Ho detto—» «So cosa hai detto». La voce sottile di mia madre disturbò quella finta calma. Chiusi il frigo mettendomi le scarpe bucate e sporche, uscendo da lì senza dire altro. Per lei avrei fatto di tutto, persino rubare del cibo che poi le avrei portato senza che nessun ringraziamento mi accogliesse. O peggio senza che nessun ‘’come te lo sei procurato’’ mi fosse domandato. Suppongo di aver iniziato così la mia discesa in quel mondo, passavo le mie giornate a bighellonare con James e Peter, rubavamo cose di poco conto, i soldi degli altri ragazzini, la frutta al mercato. Giocavamo nel campetto da basket malmesso del quartiere, e sembrava bastarci. Poi arrivò Luke, spacciava droga nella zona e non so esattamente in che modo passò dal dare la droga a mia madre a darle il cazzo. Non so se sia chiaro ciò che voglio dire. Lo odiai sin dal primo momento, nessuno era mai riuscito a frapporsi tra me e lei, tranne lui. Mia madre non avrebbe mai ritirato sicuramente il premio ‘’miglior mamma dell’anno’’ ma a me andava bene così, mi andavano bene i suoi sguardi affettuosi quando non era strafatta, le sue carezze tra i miei capelli quando mi poggiavo sulle sue cosce piene di lividi. Il modo in cui mi chiamava ‘’amore mio’’ con quella voce simile al vetro più sottile, temevo sempre di vederla decomporsi sotto ai miei occhi. L’arrivo di Luke cambiò tutto, la vita dentro quella casa divenne irrespirabile, vi erano solo liti, percosse e urla. I suoi ‘’amore mio’’ adesso sussurrati quasi temesse di essere sentita, le carezze sparite. Il mio amore ristagnò in pancia, divenne una palude e infine si inacidì. A quindici anni provammo la prima canna, seduti sui muretti appena imbrattati, io James e Peter ce la passavamo sorridendo come dei coglioni. A quell’età mi bastava del fumo e dell’alcool comprato illegalmente per sentirmi .. felice? Non so. La felicità è un concetto troppo utopico, troppo perverso per un'esistenza come la mia. Forse mi sentivo semplicemente più presente, più ancorato alla mia vita di quanto non lo fossi solitamente. I furti si centuplicarono, dal cibo passammo alle auto in un circolo vizioso senza fine. A sedici anni vennero gli assistenti sociali, mi strapparono da quella casa affidandomi a una famiglia a me sconosciuta: I Wilson. Fu così che conobbi Alice. Una ragazzina di appena quattordici anni dalla vita perfetta, almeno secondo il modesto parere di un sedicenne nella merda fino al collo. I suoi capelli simili alle foglie in autunno, con riflessi abbaglianti. Aveva gli occhi più grandi che avessi mai visto, scandagliavano dentro la tua anima senza permesso lasciandoti scombussolato e forse fu questo a conquistarmi subito, a costringermi quasi nel darle la mia totale fiducia. Eppure dall’altra parte della città, in una New York totalmente diversa da quella c’era ancora mia madre. La sognavo ogni notte, la sua voce sottile cristallizzata dentro di me, artigli profondi sul mio cuore. Il padre di Alice era un generale dell’esercito dall’aria parecchio severa, eppure aveva gli stessi occhi dolci della figlia, sembrava mi avesse preso a cuore per un motivo a me sconosciuto. Mi aiutava con i compiti, mi comprava abiti nuovi e costosi, mi portava alle cene di famiglia senza chiedere nulla in cambio. Mia madre però continuava ad apparirmi nei sogni. Fuggii da quella casa perfetta sei mesi dopo, non riuscivo più a guardarmi allo specchio. Il mio personale castello di vetro ululava ferito, e le sue urla avevano la voce di mia madre. I Wilson non sembravano voler mollare però la presa su di me nonostante tutto, mi cercavano spesso nonostante pensassi di non meritarlo, e forse senza la presenza di Alice avrei fatto perdere le mie tracce del tutto. «Come mi sta?». Fece una piroetta davanti lo specchio del negozio. «Non male..» sorrisi mesto e bugiardo, le stava d’incanto. Alice adesso aveva sedici anni, io diciotto ed ero già al mio secondo richiamo giudiziario. La mia vita non sembrava volersi assestare, vivevo ancora con mia madre e quel bastardo di Luke, continuavo ancora a vederla perdersi e decomporsi di fronte a me sentendomi impotente. Tutto finì (o forse iniziò) davvero una notte, Luke tornò ubriaco come suo solito e stavolta non sembrava volersi limitare ai semplici ceffoni che riservava a mia madre. No stavolta in mano teneva un coltello. Non so cosa scattò esattamente nella mia mente, forse anni di soprusi e repressioni, anni di odio covato e mai esternato del tutto. Mi avventai contro di lui, i miei occhi non vedevano altro che la sua merdosa figura ributtante di fronte a me. I miei diciott’anni prevalsero sui suoi quaranta, quando gli assestai una testata sul naso vidi il sangue grondare da ogni parte, ma non era ancora abbastanza. Afferrai i suoi capelli unti sbattendogli più volte la testa contro il tavolo. Contro quel fottutissimo tavolo nella quale si rimpinzava come un porco e si scopava mia madre sapendo che io li avrei sentiti. Quando si accasciò afferrai il coltello, ero pronto a finirlo del tutto ma l’urlo di mia madre mi fermò. Non l’avevo mai sentita urlare, era come se la sua voce fosse cambiata e la mia palude d’odio ribollì avvelenandomi. «Vattene via. Vattene via prima che riprenda i sensi». La sua disperazione mi raggiunse ferendomi. «Non posso lasciarti da sola.. vieni con me». L’afferrai per il braccio ma il suo scossone mi obbligò a mollare la presa, la vidi cadere rovinosamente accanto al corpo svenuto. Non riuscivo a crederci. «Salvati tu. Appena riprenderà i sensi.. ti ucciderà. Amore mio, ascoltami..». Gettai il coltello a terra, la mia faccia una maschera di pietra lineata in più punti. Avanzai a grandi passi verso il comò in soggiorno buttando all’aria vestiti e oggetti finché non trovai una busta gialla. L’afferrai mettendomela dentro la tasca interna del giubbotto, tornai in camera mia riempiendo appena un borsone di pochi abiti. Quando tornai lei giaceva ancora accanto a lui. «Tornerò da te». Mi fissò con quel viso scavato e smunto. «Spero tu non debba farlo mai più.» I nostri visi adesso vicinissimi si scrutavano con curiosità, alla ricerca di chissà quali cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi due anni. Non ne troverà, è venuta quasi a ogni colloquio portandomi cibo, oggetti, sigarette, osservando il modo in cui lentamente recuperavo la mia vita dentro quella cella troppo angusta. «Sei più alta o sbaglio?». La presi in giro bonariamente beccandomi una delle sue occhiate incendiarie. «Sei più stupido o sbaglio?». Le mani sui fianchi, la punta della scarpa ticchettava ritmicamente sull’asfalto rovente. «Come sta tuo padre?» Stuart Wilson era rimasto vedovo qualche mese dopo il mio ingresso in prigione, avevo assistito al loro dolore attraverso quelle odiose sbarre. «Se la cava, ha una figlia in grado di far tutto». Mostrò i muscoli inesistenti sulle braccia candide strappandomi una risatina, le circondai le spalle trascinandola rozzamente lungo la via. «Sentiamo braccio di ferro, qual è la prima meta?». Un pizzicotto mi colpì il fianco, non mollai la presa. «Casa tua, non oso immaginare come sia ridotta dopo tutto questo tempo». Non volevo pensarci neppure io in effetti, il fatto che Alice chiamasse quella topaia dove vivevo ‘’casa’’ era uno dei tanti motivi per cui la trovavo adorabile. Alla soglia dei suoi quasi ventitré anni era una giovane donna brillante, frequentava il college, aveva parecchi spasimanti (a detta sua) e un futuro come medico. Alle volte mi domandavo cosa ci facesse una così con uno come me. Un rifiuto umano che non era stato in grado di costruire nulla di decente nella propria vita, la mia unica abilità erano le auto. Il mio unico e grande amore. Le fottevo per poi portarle a James che sapientemente se ne prendeva cura, aggiustandole per far si che io potessi correrci alle corse clandestine. «Jay, mi senti?». La fissai sbattendo le palpebre, un mezzo sorrisino si formò sull’angolo destro delle mie labbra. «Ho voglia di una pizza, sai da quanto non ne mangio?» «James era sicuro lo avresti detto, suppongo ti stia aspettando insieme a Peter». Annuii soddisfatto della sua risposta velocizzando il passo. Quattro anime un po’ scalcinate, una di esse senza nulla in comune con le altre. Alice si era avvicinata a loro per causa mia, eppure erano riusciti ad accoglierla senza remore o riserve. Tra me e lei non c’era stato mai nulla, nulla più di un bacio. Lo ricordava? La fissai intensamente e fui tentato di chiederglielo, esitai e persi così il momento. «Siamo arrivati». Indicò la Mercedes parcheggiata poco distante, mi bloccai sul posto e un nuovo ricordo affiorò dentro di me. Somigliava alla prima auto che rubai a Chicago. Un diciottenne in fuga, senza un luogo dove andare, senza un punto di riferimento. Che vita potrebbe mai vivere? La mia, sicuramente. Usai parte dei soldi per spostarmi e dormire in motel squattrinati, arrivando a Chicago dieci giorni dopo la mia fuga. Quando non hai neppure un misero pasto ad accoglierti la sera, o un tetto su cui dormire, comprendi sul serio quanto velocemente i soldi finiscano. Lasciai la mia famiglia e ne ritrovai un’altra lì. Vivevano ammassati nei sottopassaggi abbandonati, molti avevano qualche anno più di me altri erano dei cinquantenni senza denti e senno. Eppure mi abituai presto, nonostante i miei abiti puzzassero di urina e sudore, nonostante non mi lavassi da settimane, a me bastava. O forse fu la disperazione a convincermene. Pensavo spesso ad Alice, le avevo lasciato un misero messaggio in segreteria, chissà cosa faceva? Mi pensava mai? Ripensavo spesso all’ultima volta in cui l’avevo vista, mangiava un gelato seduta su una panca, parlando degli esami imminenti. Fingevo di ascoltarla pensando all’ultima auto rubata, avrei dovuto correre quella sera. Mi pentii di non essere stato più presente quella volta, di non aver ascoltato bene la sua voce un’ultima volta. O di non aver accarezzato i suoi capelli sempre lucidi e profumati. Serrai i denti con un’improvvisa voglia di piangere, fissando le fiamme che si spandevano dal bidone maleodorante vicino a me. «Sei nuovo?». Una voce femminile mi strappò dai miei pensieri, la fissai e il mio mondo sembrò scuotersi lasciando cadere calcinacci ovunque. Aveva gli occhi grandi come lei, la pelle chiara e i capelli scuri. «Ha importanza?». La mia voce roca sembrò divertirla, mi si avvicinò passandomi una fiaschetta che puzzava di rum, l’afferrai bevendone una lunga sorsata. «Come ti chiami?» «Jay, tu?». Il mio nome completo era Jayden, ironico come il suo significato fosse ‘’il Signore ha sentito’’. Forse quando io urlavo lui era impegnato da qualche altra parte. «Shanti». Mi sorrise, aveva i denti stranamente bianchi e dritti. Mi piaceva. O forse mi ricordava lei, ma lo capii troppo tardi. Davvero troppo tardi. Quando le nostre mani si unirono sentii una scossa partire da dentro, le aveva così fredde. Scoprii poco dopo che Shanti aveva ventitré anni, viveva per le strada da cinque anni circa nonostante il motivo mi fosse sconosciuto. Sapeva come cavarsela in ogni situazione, sapeva come taccheggiare i passanti e io come fottere le auto. In poco tempo racimolammo abbastanza soldi per affittarci una specie di loculo dai muri marci. Il secondo giorno in quella casa portò lì la mia condanna più grande. La mia colpa. Il mio peccato e la mia croce. Le sue mani tremanti uscirono qualcosa avvolto in una stoffa gialla e stinta, quando l’aprì riconobbi subito il contenuto: eroina. «Da quanto ti fai?». Il mio tono non conteneva tracce di interesse o giudizio, fu questo forse a spingerla a punirmi per il resto della mia vita. «Pochi mesi, vuoi provare?». Mi fissò, ancora quegli occhi enormi a rovistarmi dentro. «Quella merda? No grazie». Soffiai fuori una risata sprezzante, non ero un santo e nella mia vita di merda ne avevo provato ..ma quella. «Hai qualcosa da perdere? Il modo in cui ti senti dopo.. questa vita è comunque una matassa maleodorante di merda, perché non sopperirne un po’ il dolore?». Avrei dovuto dirle allora che io qualcosa da perdere l’avevo. Aveva lunghi capelli setosi, e gli occhi più belli che avessi mai visto. Perché non lo feci? Forse perché quando sei solo e abbandonato ricordarti di chi ami viene difficile. O forse perché le ultime parole di mia madre continuavano a pugnalarmi al petto, con lo stesso coltello abbandonato sul pavimento quella notte infernale. La mia discesa all’inferno iniziò quel giorno, mentre l’ago bucava la mia pelle e la mia mente si perdeva in un vortice squassante. |
Capitolo 2
*** Shame on me ***
 IIChicago non fu un semplice anno della mia vita. No quello a Chicago fu L’ANNO della mia vita. L’anno in cui passai dall’essere un semplice ragazzo problematico al diventare un rifiuto tossico incapace di guardarsi persino allo specchio. Persi la mia identità, persi me stesso tra quelle mura intonacate di un bianco sporco che mal copriva il precedente colore. Un po’ come me, pennello invisibile nella mia anima che non riusciva a coprire del tutto la sporcizia in cui ero piombato. I primi tempi non furono male, quando l’eroina entrava dentro le mie vene vi era pace. Come un orgasmo al contrario che durava un singolo minuto, sessanta secondi di quiete in cui il resto del mondo spariva e restavo solo con me stesso. Niente più mostri. Niente più sensi di colpa. Niente più fughe e niente più urla di mia madre. Ma la marea si alzò anche per me, le dosi iniziarono ad aumentare e i soldi a scarseggiare, io e Shanti spesso dividevamo la dose e non bastava mai. Il mio corpo iniziò a soffrire internamente, durante le mie crisi d’astinenza sentivo come se qualcuno torturasse le mie budella da dentro. Soffrivo steso su quel letto, con l’afa a distruggermi, contorcendomi tra le lenzuola madide di sudore. Ricordo persino le lacrime sparse sul cuscino quando sapevo che la droga non sarebbe arrivata da me. Mi arenai. Semplicemente.
Mi fissavo allo specchio guardando gli occhi scavati, le pupille perennemente dilatate, il colorito grigiastro e una perdita di peso che mi rendeva quasi irriconoscibile. Così preso da me stesso iniziai a non vedere più lei. Lei così magra e pallida, lei e le sue braccia martoriate. Ricordo un giorno in cui stavo male, male sul serio, i miei occhi fissi sulla sua figura che con mani tremanti provava a mettersi il rossetto sbavandone i contorni. Sapevo in che modo aveva iniziato a procurarsi la droga e non me ne fregava un cazzo. Si faceva scopare agli angoli delle strade, cedeva il suo corpo per soldi o peggio per delle dosi che poi avrebbe diviso con me. A modo suo credo mi amasse, amava quel me stesso così dipendente da lei, e odiava allo stesso tempo quel me stesso arido incapace di amarla davvero. Il suo corpo aveva finito col ripugnarmi forse perché in primis ripugnavo me stesso. Svendevo il suo corpo, non le dicevo nulla fingendo di non sapere con la paura che avrebbe smesso lasciandomi agonizzante. Ripensavo ad Alice, il suo viso stampato a fuoco nella mia mente diveniva sempre più lontano, era come se il mio stesso cervello si rifiutasse di pensare a qualcosa di così perfetto e pulito.«Torno dopo». La sua voce flebile accolse il mio totale silenzio. Non riuscivo neppure a spiccicare parole, mi sentivo vuoto dentro, morto. Desiderai la morte parecchie volte, iniziavo a sentirmi un estraneo nel mio castello. Quando mi vestivo, quando parlavo, quando scopavo (ormai raramente) e persino quando piangevo. Era come se fossi un piccolo robottino a cui tirano la corda, eseguivo meccanicamente dei gesti che non sentivo miei. Questo corpo nella quale risiedeva la mia anima rotta non era più di mia proprietà. ***
«Hai intenzione di tenere il broncio per molto?». La fissai roteando gli occhi in maniera eloquente. «Se avessi fatto guidare me, magari—» mi zittì con un cenno della mano, i suoi bracciali tintinnarono producendo una dolce melodia. «Oh andiamo piantala di fare il maschilista, pensi di essere l’unico in grado di portare una macchina?». Ci fissammo qualche istante, sorrisi e valse più di mille parole. In realtà si, pensavo di essere l’unico. Anche volendo non avrei saputo spiegare il filo sottile che mi teneva legato a quei cuori artificiali fatti di pistoni e olio. Con le auto riuscivo a fare magie, quasi come se fossi nato da dentro un fottuto motore e non dalla figa di mia madre. Mia madre. Non la vedevo ormai da anni, so per certo vivesse ancora lì. Con lui. A quanto pare non era riuscita a fare qualcosa di concreto nella sua vita. E io? Mi venne da ridere a quel pensiero, e lo feci beccandomi un’occhiata risentita dalla piccola vipera di fianco a me. Osservai il portone incrostato e pieno di graffiti, da qualche parte doveva ancora esserci il mio. Ignorai andando avanti, entrando dentro l’androne scuro e maleodorante. Abitavo al quinto piano di un palazzo fatiscente, l’ascensore era un lusso che nessuno in quel quartiere poteva permettersi, eppure non me ne lamentavo. Mi piacque la sensazione di stanchezza nelle mie gambe, ero stato così tanto steso su una brandina a riflettere e vomitare maledizioni verso me stesso. Quando l’ingresso di casa mia mi accolse delle urla seguirono pochi istanti dopo. James e Peter applaudirono il mio rientro con quelle facce adesso più ‘’mature’’, sorrisi loro andandogli incontro ricevendo il secondo abbraccio sincero dalla mia uscita di prigione. «Il bastardo è tornato quindi?». La voce profonda di James interruppe quel momento forse troppo dolce per gente come noi. «Avremo di che pentircene». La voce atona e cinica di Peter gli fece da sfondo, diedi loro due cazzotti ben assestati mentre Alice spariva in cucina probabilmente cercando le pizze promesse dagli altri due. «Alle corse aspettano tutti te.» James mi fissò in maniera eloquente, annuii circondandogli le spalle con un braccio. «Lo so. Sono tornato solo per questo, dove cazzo andreste senza di me?» «Probabilmente ai Caraibi a bere del Mojito». Peter spense al solito la mia arroganza con poche battute sparendo lungo il corridoio, era l’unico che si preoccupava di aiutare Alice nelle faccende domestiche. Aveva un modo tutto suo di esternare l’affetto, sempre così cinico e quasi brutale dai suoi occhi irradiava però una luce così calda da sopperire la sensazione di disagio che procurava solo aprendo la bocca. Fissai i tre volti attorno al tavolo sentendo una strana sensazione partire dalla bocca dello stomaco, mi avevano perdonato? Mi avrebbero perdonato se avessi sbagliato ancora? Perché io conosco me stesso, so di cosa sono capace, so quanto è precario l’equilibrio che mi tiene ancorato al baricentro. ***
Dopo trecentosessantacinque giorni di pura sofferenza scattò in me qualcosa, ruppi lo specchio del bagno perché incapace di fissarmi ancora. Shanti dormiva ubriaca sul letto, alle volte l’alcool riusciva a farti tirare un po’ di più, riusciva a farti sentire un po’ più tardi l’esigenza di farti. Tornai in camera fissandola, le cosce piene di lividi mi ricordarono mia madre, una lacrima sfuggì solcando la guancia. Non l’asciugai lasciando che corrodesse la mia pelle, che cosa ero diventato? Molti pensano che gli eroinomani non siano in grado di intendere e volere, si sbagliano. Sbagliano tutti. Il senso di colpa è così viscerale da mozzarti il respiro. Scrissi un biglietto sbagliando parecchie parole a causa del tremore, parole semplici: ‘’mi dispiace, Jay’’. Fuggii come un ladro nel cuore della notte, l’abbandonai al suo destino seguendo il mio che si prospettava ben più oscuro di quella notte senza luna. In giro per i vicoli fissavo volti smunti e sofferenti, senza neppure rendermene conto i miei piedi mi condussero alla stazione dei treni. Ricordo di essermi fatto nei cessi durante il viaggio, e quando le ombre dei grattacieli di New York mi accolsero sentii di essere nel posto giusto. Se dovevo morire l’avrei fatto lì, lì dove stava il mio cuore, i miei affetti. Una parte di me in realtà pensava di poter cambiare, con l’aiuto di James e Peter magari. Con l’aiuto di Alice. Non credo dimenticherò mai il suo viso quando mi intrufolai nella sua camera qualche notte dopo. «Che cosa hai fatto..» sapevo cosa volesse dirmi, mi chiedeva cosa avessi fatto del me stesso che aveva lasciato. Come potevo spiegarle di non saperlo? Stuart mi indirizzò a parecchi centri di disintossicazione, ma fuggivo puntualmente da ognuno di essi. Randagio persino nella mia stessa città. Rubavo per mantenermi la droga, il cibo adesso era irrilevante. Allontanai James, allontanai Peter. I miei scatti di rabbia erano incontrollabili e furiosi. Non riuscivo a gestire più tutta la rabbia di una vita passata a prendere mazzate, non riuscivo ad avvicinarmi alla porta di mia madre, fino a una notte. Bussai alla sua porta e quando i nostri occhi si incrociarono qualcosa si ruppe dentro di me. «Te l’avevo detto che sarei tornato». Mi sorrise, lei bambola sgualcita dai vestiti sporchi. «Amore mio..» odiavo quando lo diceva. Non so perché, quel nomignolo che tanto avevo adorato da bambino adesso sembrava divenuto la mia peggiore condanna. Mi fissò le braccia chiudendo gli occhi per un secondo. «Mamma..» «Non posso credere tu l’abbia fatto». Non c’era giudizio nelle sue parole, ma una lenta rassegnazione. La rassegnazione di chi sa di aver peccato, contro Dio, contro se stessa e contro la sua stessa carne. La rassegnazione di chi sa che non potrà mai cambiare le cose. «Mi manchi così tanto—» la mia voce si ruppe, serrai i denti tirando su col naso. Le grate dalle quali mi guardava restarono chiuse. Per me. Per suo figlio. «Devi andartene. Lui sta tornando». Quando il suo volto sparì mi sentii perso come quando stavo a Chicago. Che senso aveva tornare se lei non era disposta ad accogliermi? Perché non riuscivo a farmi amare abbastanza? Perché uno sconosciuto sembrava contare più di me? Perché la droga sembrava ormai essere la mia unica ancora di salvezza in quel mare di disperazione? Quando la mia vita andò totalmente alla deriva, dopo anni di dipendenza, accadde qualcosa. Quella notte era un lavoro apparentemente semplice, avrei dovuto rapinare un supermercato, togliere tutto l’incasso e portarlo con me. Ancora oggi non mi spiego come sia potuto accadere, vidi solo le volanti arrivare come se sapessero già che sarei stato lì. Avevo fatto jackpot, niente più ammonimenti per me. Le porte della galera si aprirono: avevo ventidue anni. Nessuna cauzione per un relitto come me, non potevo comunque permetterla. Soffrii le pene dell’inferno lì dentro, mi disintossicai a forza strappando pezzi della mia carne, aggrappandomi alla poca voglia di sopravvivere che mi era rimasta. Aggrappandomi ai colloqui con Alice, con James e Peter, con Stuart. «Mia madre—» lo fissai dal vetro senza riuscire a continuare. «Si, lo sa. Sono andato da lei qualche giorno fa». Sopperii ancora una volta la voglia di piangere annuendo mestamente. Il generale mi fissò con affetto. «Non sei solo Jayden». Era da sempre l’unico a chiamarmi così. Volli credergli, per un singolo istante io volli credergli davvero. Mia madre non venne mai a trovarmi, non chiamò, non mandò neppure un biglietto. Sembrava avermi semplicemente rimosso dalla sua esistenza, e così dovetti adeguarmi. Dovetti strapparla a forza dal mio cuore, nonostante facesse male. Passai lì dentro due anni, uscendo mi sentii un uomo nuovo. Un uomo ritrovato. Lo ero davvero? ***
L’orologio segnava le due, e la luna alta nel cielo ci vide seduti a fissarci in silenzio. Aveva da sempre quello strano modo di entrarmi dentro, rovistare un po’, capire cosa avessi e come mi sentissi. Alle volte mi domando se senta anche ciò che provo quando lei è attorno, mi domando se lo ignori perché è meglio così. Perché due vite come le nostre non potrebbero mai incontrarsi, non nel modo in cui vorrei io. «Hai stilato un prospetto di vita diciamo da qui ai prossimi mesi?». Mi sorrise bevendo distrattamente dell’acqua. «Lo sai, sono un accanito fatalista. Seguirò la corrente». Mi stiracchiai rumorosamente ignorando il suo sguardo di disapprovazione. «Quindi nel tuo gergo sarebbe qualcosa come: farò lo stronzo incapace sul divano di casa mia fin quando le piaghe sul mio culo non andranno in putrefazione?». Restai in silenzio qualche secondo prima che la mia risata non facesse tremare persino le pareti. «Può darsi, ti dispiace?». Mi avvicinai col busto, i nostri visi adesso vicini. Riuscivo a vederle quella spruzzata di lentiggini così assurdamente adorabile. Mi beccai uno spintone poco carino prima di fissarla alzarsi, i piedi rigorosamente scalzi, dirigendosi lungo il corridoio. La seguii docilmente permettendomi di osservare la mia camera, il mio letto, non vedevo un materasso decente da anni. Si stese dal lato destro, consapevole della mia predilezione verso il lato opposto. La ignorai togliendomi la maglia, spogliandomi davanti a lei senza vergogna; alle volte era più un metterla alla prova, capire fino a che punto si sentisse a suo agio con me. Per qualche secondo non la sentii respirare, quando mi voltai tornando in boxer sul letto recuperò egregiamente lanciandomi il cuscino in faccia. «Non puoi dormire come tutte le persone normali?». Mi stesi sospirando fintamente insoddisfatto. «Dovresti ringraziarmi sai?» mi fissò interrogativamente. «Di solito dormo nudo» sorrisi malizioso poco prima che affondasse i suoi artigli tra i miei capelli dandomi una severa scrollata. «E’ il momento di crescere, hai quasi venticinque anni, idiota». Borbottò quell’insulto dandomi le spalle, un invito implicito a circondarle la vita con il mio braccio avvicinandola a me. Seppellii il viso nell’incavo del suo collo, mi piaceva il suo odore. Da sempre lo stesso, Alice odiava i profumi e come le bambine utilizzava semplicemente il borotalco. Eppure a me piaceva, non so, era come abbracciare qualcosa di bello, di confortante, qualcosa di pulito. Come fare un bagno nell’acqua limpida e fresca quando il tuo corpo è talmente sozzo da risultare putrescente. «Mi sei mancata». Dovevo aggiungere altro? «Anche tu». Forse no, forse sapeva e conosceva le cose meglio di me. «Tuo padre sa che sei qui?». Si mosse a disagio tra le lenzuola. «Sa che sarei venuta a prenderti, si.» Alice aveva un modo impeccabile di evadere le mie domande. «E sapeva anche che saresti rimasta a dormire?». Si voltò così repentinamente da spaventarmi quasi, i nostri nasi sfregarono tra loro. Probabilmente se ne rese conto in quel momento provando ad allontanarsi, ma la mia stretta divenne micidiale. «No. Non sarebbe comunque d’accordo, lo sai com’è fatto..» mi domandavo spesso se Stuart avrebbe approvato dormisse con un qualsiasi altro ragazzo, magari di buona famiglia e dal passato limpido. Sapevo comunque quanto fosse un pensiero bastardo il mio, quell’uomo mi aveva sempre trattato come un figlio, ma potevo biasimarlo davvero se provava a proteggere quella che figlia lo era davvero per lui? «Alice—» provai a parlare, volevo sul serio chiederle se ricordasse il nostro bacio, ma qualcosa me lo impedì. «Mh?» «Niente, ho pensato che domani ti porterò a mangiare un bel gelato». Sorrise in maniera disarmante e per un secondo scordai il filo logico dei miei pensieri. Restai a fissarla dormire per ore, mi piaceva. Lo facevo da anni ormai, le scostavo i capelli dal viso, fissavo come le ciglia lunghe ombreggiassero le guance, o come la bocca appena schiusa divenisse quasi lucida. Quando la fissavo così intensamente sembravo possedere tutte le risposte alle mie domande, compresa quella sul perché non saremmo mai potuti stare insieme. E tra tutte era sicuramente la risposta che più odiavo. «Seriamente sei cieca?». Allargai le braccia sbuffando stizzito.
«HAI FINITO? Scusami tanto se non solo la nuova Michael Jordan della nazione, ok?». Mi lanciò la palla con rabbia voltandomi le spalle pronta ad andarsene. La fermai costringendola a voltarsi. «Sei arrabbiata?». Mi fissò come fossi un demente. «Ovvio che lo sono. Ti incazzi perché non riesco a fare uno schifosissimo canestro?». Il suo modo di rigirarsi le cose era a tratti adorabile e a tratti snervante. «Vorrei ricordarti che mi hai chiesto tu di insegnarti, e adesso ti lamenti?». Battibeccare era ormai consuetudine per noi. Avevo diciassette anni, lei quindici. Veniva spesso nel campetto malmesso per vedermi giocare, se c’era lei a fare il tifo per me allora la vittoria era assicurata. «Non pensavo di certo fossi un pazzo isterico nell’insegnare. Dammi questa maledettissima palla». Me la strappò di mano posizionandosi nuovamente vicino al canestro, sorrisi rubandogliela di mano ignorando i suoi strepiti, lasciando che mi inseguisse. Sollevai il pallone in alto, saltellò di fronte a me cercando di prenderlo finché le mie braccia non caddero sulle sue spalle bloccandole ogni via d’uscita. Mi fissò immobile aggrottando la fronte. «Se faccio canestro da questa distanza, avrò un premio?» «Non ci riuscirai mai». Più mi sfidava e più diventavo competitivo. Con lei praticamente vicinissima sollevai le braccia, mirai con un occhio socchiuso lanciando la palla. La sua testa rossiccia seguì i movimenti come al rallentatore, e quando centrai perfettamente il canestro tornò a respirare. «Ho vinto». La mia voce la colse di sorpresa, voltò il viso repentinamente solo che ad accoglierla non ci fu alcuna risata ma le mie labbra che traditrici toccarono le sue. Mi ero sempre chiesto che consistenza avessero, dal colorito così simile alle ciliegie, e finalmente lo seppi: morbide e calde, sembravano state create apposta per me, o probabilmente volli convincermene io. Ciò che non mi aspettavo fu sicuramente il sentirle schiudersi e ricambiare quel bacio che suggellò la fine di un torrido pomeriggio d’agosto. Non ne parlammo più dopo quella volta, né io provai ancora a baciarla. Avrei desiderato farlo, ma la vita pochi mesi dopo mi portò lontano da lei, lontano dalle sue labbra, lì a Chicago dove forse un suo bacio avrebbe dato un nuovo destino alla mia vita. |
Capitolo 3
*** Antithesis ***
 IIILa penna macchia d’inchiostro le pagine bianche con sopra le mie iniziali, quante ne ho scritte da anni a questa parte? Tantissime, e tutte mai recapitate. Le conservo dentro il cassetto della scrivania sulla quale sono seduta, aspettando il momento giusto per consegnartele, per trovare il coraggio di confessarti il mio peccato e la mia colpa. I miei sentimenti per te. Ogni lettera comincia sempre allo stesso modo, e finisce alla stessa maniera. Non cerco scusanti per ciò che ho fatto, per le bugie dette a te, a mio padre a tutti; sento di aver seguito la disperazione nel vedere la tua vita andare a brandelli, sento di aver fatto l’unica scelta possibile per ricondurti sui miei stessi binari. Ci sono riuscita? Quando ti ho visto oltre i cancelli della prigione, quel sorriso che tanto amo, quegli occhi brillanti, il mio cuore ha avuto un sussulto. Mi domando per quanto dovrò nascondere l’amore viscerale che sento per te, fino a quando i nostri destini viaggeranno su binari diversi? Hai una risposta per me Jay? Quando il punto chiude il flusso delle mie parole i miei occhi tremano nello sforzo di leggere, la ripongo dentro il cassetto sopra il resto del mucchio, chiudendolo a doppia mandata proprio come sembro aver chiuso il mio cuore. Le lezioni sono sempre così stancanti, l’unica nota positiva in questa giornata è la promessa di quel gelato. Scendo i gradini a passo svelto cercando tra gli sguardi l’unico della quale mi interessa davvero qualcosa, ferma sul marciapiede sistemo le pieghe della mia giacca sono sempre stata un tipo maniacale lo ammetto, secondo i miei amici più vicini soffro di una qualche fobia. Due ragazzi mi urtano scusandosi pochi secondi dopo, li vedo rincorrersi, avranno all’incirca quindici anni. Mi ricordano noi due. La prima volta che vidi Jayden credo non la dimenticherò mai, stavo nascosta nel sottoscala osservando gli assistenti sociali dalle fessure dei gradini, i miei occhi si poggiarono su quel ragazzino dai vestiti sporchi e malmessi e da lì non sembrarono più riuscire a staccarsi. Aveva le spalle così ingobbite, gli occhi lucidi e il modo di fare sbruffone tipico di chi sente il mondo contro. Ci misi due mesi per attirare la sua attenzione, o almeno credo, alle volte lo beccavo a fissarmi di nascosto ma quando provavo ad avvicinarmi mi respingeva con sdegno. Inizialmente pensavo provasse invidia e disgusto per quella ragazzina dalla vita troppo semplice, dai capelli troppo pieni di carezze amorevoli. Non ho mai avuto il coraggio di chiederglielo in realtà. «Facciamo un gioco?». Lo vidi fissarmi sorridente. «Che gioco?». Per la prima volta ero io quella diffidente nei suoi confronti, a quindici anni mi faceva paura persino la mia ombra. «Il gioco dello specchio. Devi seguire i miei movimenti alla perfezione, ci riuscirai?». Mi sfidò palesemente e io accettai. Nessuno ha la benché minima idea di quante volte facemmo quel gioco, di quante volte puntualmente io alzavo il braccio sinistro e lui l’opposto. Iniziai a pensare lo facesse apposta e quando glielo chiesi mi sorrise come suo solito dandomi una conferma silenziosa. «Hai presente le antitesi?» «Conosci parole così complesse?». Lo punzecchiai mangiando il mio solito gelato. «Tu sei la mia.» Mi sedetti su quella sedia scomoda fissando attraverso il vetro la porta che di lì a poco si aprì rivelando la sua figura. Stava meglio, o almeno era ciò di cui volevo convincermi. Vederlo lì dentro mi provocava malessere, vomitavo puntualmente dopo ogni incontro. Si sedette di fronte a me poggiando la mano sul vetro, lo imitai e giuro di aver percepito il suo calore anche da lì.
«Che sguardo pensieroso». La sua voce mi fece sobbalzare, portai una mano al petto fissandolo incredula, come se vederlo in carne e ossa fosse qualcosa di assolutamente impossibile.«Tuo padre mi ha detto che hai superato un altro esame». C’era orgoglio e disperazione nella sua voce. «L’ho fatto. Avevi dubbi?» «No.. non ho mai avuto dubbi su di te». Una nuova ondata di nausea mi invase. «Stai bene? Mangi? Ti ho portato delle cose sai—» mi interruppe. «Giochiamo?» «Come vorresti giocare?». Lo fissai interrogativamente. «Al gioco dello specchio». La sua risata fu come un balsamo. «Non siamo ormai grandi per questo gioco?». Guardai in tralice la guardia che continuava a ignorarci. «Non importa, gioca con me». Alzai la mano destra e lui la sinistra. Quella notte mi consumai tra le mie lacrime. «Mi hai spaventato—» non riuscii a finire e lui se ne accorse. «Lo vedo, sei bianca come un cadavere. Vieni, ti faccio vedere una cosa bellissima». Dal suo sorrisino diabolico dedussi non fosse qualcosa di propriamente ‘’bellissimo’’, non nel senso ovvio del termine almeno. Pochi istanti dopo una Range Rover grigio metallizzato apparve di fronte a me. «Dove diavolo l’hai presa…» lo guardai con occhi indagatori beccandomi il suo sbuffo. «Da qualche parte». Sapevo cosa voleva dire nel suo gergo. Mi spiaccicai una mano sul viso cercando di non perdere la calma. «Sei deciso a fare ancora la testa di cazz—» «Il linguaggio signorina». Mi rimbeccò com’era solito fare mio padre trascinandomi quasi a forza dentro l’auto. Odorava di nuovo, ma poco importava, ero matematicamente sicura del fatto che non fosse uscita da una concessionaria, anzi. Sapevo come agiva insieme a quegli altri due randagi, Jay rubava le auto cambiandovi le targhe, ci giocava qualche giorno e se lo convincevano allora le cedeva a James che le sistemava all’officina in vista di qualche corsa, Peter concludeva il tutto aprendo le scommesse e tenendo in mano i contanti, facendoli fruttare. Quel ragazzo era un commercialista mancato. Tutti loro erano qualcosa di ‘’mancato’’, talenti non sfruttati o sfruttati male. La sua guida mi terrorizzò come al solito, nonostante questo non c’era persona al mondo che portava l’auto come lui. Nessuno, nemmeno mio padre che di anni ne aveva il triplo. Jay era semplicemente un portento. «Ti piace?». Mi fissò fermo al semaforo. «Molto.. ma non credo ci correrai». Storse le labbra annuendo. «Neppure io, ma era bella, valeva la pena godermela per qualche giorno». Prima di abbandonarla da qualche parte, non lo disse ma io capii ugualmente. Il fatto che fossi ormai entrata in quel meccanismo illegale doveva preoccuparmi? Tra qualche mese mi avrebbero visto in abiti succinti con un foulard spiegazzato in mano a decretare l’inizio delle corse. ( JAY )
Ero rimasto cinque minuti buoni a fissarla guardare quei due adolescenti, convinto pensasse a noi due a quell’età. Avrei dato parte della mia vita per sapere a cosa pensasse, per capire se quando nella sua mente balzava il mio viso il suo cuore sussultava al pari del mio. Non ho mai avuto problemi a esternare le mie emozioni o i miei sentimenti, non ho mai avuto problemi ad abbordare le ragazze nei locali o per le strade, ma con lei semplicemente non ci riuscivo. Forse perché era Alice, e questo bastava a chiudere tutto. La fissai mangiare il gelato, si scioglieva più velocemente di quanto riuscisse a leccarlo. Sorrisi avvicinandomi, rubandogliene un po’ e beccandomi un imprecazione contenuta a causa della bocca piena. Respirai il suo odore e mi bastò. In quel momento non sapevo bene cosa stessi facendo della mia vita, ero tornato il solito Jay quello dei furti d’auto e delle corse, e sapevo quanto lei fosse delusa. Lo sapevo ma non riuscivo comunque a porre rimedio. In un’altra vita sarei stato un pilota, poco ma sicuro, ma in quella di adesso non c’era spazio per i sogni in grande stile. «E’ buono?». Annuì soddisfatta camminando per le vie trafficate della metropoli. «Papà ti ha detto che sono andata via di casa? Ho affittato un loft in centro». L’orgoglio di quella sua affermazione era impossibile da non notare. «Me lo ha detto si, a stento conteneva le lacrime». La spinsi divertito beandomi della sua risata. «Ho tentennato un po’, sai dopo mamma.. insomma non volevo si sentisse solo». Odiavo vederla incupirsi di fronte a quei pensieri, lo odiavo perché non potevo porvi rimedio. Leccai le mie labbra secche, avevo finito il mio gelato da un po’. «Non si sente solo, anzi, credo avesse bisogno anche lui dei suoi spazi. E poi lo sai che è così fiero di te, ormai parla solo di questo finirò per non andare più a trovarlo». Mi finsi scocciato beccandomi uno spintone meritato che accolsi con una risatina. «Guarda che sei stronzo forte sai? E tu?». La domanda mi colse di sorpresa. «Io cosa?». La fissai bloccandomi tra la folla. «Ti senti solo, Jay?». Camminò all’indietro senza staccarmi gli occhi di dosso. «Se la risposta fosse si? Mi inviteresti a stare con te?». Inarcai un sopracciglio avanzando verso di lei. Probabilmente non si aspettava quella risposta. «Lo faresti? Non potresti portare le tue conquiste da me». Sorrise trionfante, convinta di aver vinto quel round. «Perché? Saresti gelosa?». Il gelato colò sulle sue dita, ma non sembrò accorgersene. «Gelos— oh ti prego, sono semplicemente desiderosa di pace. I rumori molesti non mi piacerebbero». La sua voce stridula confermò la bugia. «E se per ipotesi volessi te e non le altre?». Si bloccò fissandomi imbambolata. «Stai scherzando?». La fissai afferrandole la mano sporca di gelato, la portai alle labbra pulendole le dita con la lingua. La sentii rabbrividire. «Forse». Sorrisi come un coglione superandola, velocizzando il passo incurante dei suoi strepiti. «TORNA QUI. BASTARDO NON TI FERMI?». Risi fino a piangere. L’officina mi accolse nella penombra, il suo odore non era cambiato e io l’adoravo ancora come anni prima. Mi guardai intorno beccando delle gambe uscire fuori da sotto un auto. Bussai sul cofano poggiandomi con indolenza. «C’è qualcuno?». Il rumore delle ruote cigolanti e infine il viso di James sporco di olio sbucarono da sotto. Mi fissò con quegli occhi chiari perennemente incazzati. «Quella troia di tua sorella, vuoi salutarla?». Mi sorrise con simpatia beccandosi un calcio che lo fece ruzzolare dal carrello. La prese bene alzandosi e pulendosi con una pezza che servì a sporcarlo solo di più. «Dove sta Peter?». Indicò una porta chiusa, oltre vi era ‘’l’ufficio’’ o almeno così lo chiamavamo noi. Di legale in quel posto non c’era praticamente un cazzo. «Ti piace?». Guardò l’auto e io lo imitai, sorrisi annuendo lentamente. «Oh si, è lei?». La bambina sulla quale avrei corso. «Ovvio, diverrà un gioiellino puoi starne certo». Mi rassicurava sempre come se non sapessi di cosa fosse capace. Gli indicai la Range Rover fuori. «Sto provando quella, se mi piace la porto qui, magari dopo la prossima corsa. A proposito quando sarà?». «Due settimane». La voce di Peter interruppe il discorso, ci voltammo simultaneamente a fissarlo. Aveva i capelli lievemente scompigliati, sfregava gli occhi rossi di chi passa troppo tempo su un monitor. E non per guardare porno. Non solo almeno. «Sono già aperte le scommesse?». Mi fissò con sarcasmo a quella domanda. «Tu che dici? E stanno andando malissimo» James aggrottò la fronte gettando la pezza sporca a terra. «In che senso?» Peter sbuffò indicandomi. «Puntano tutti su di lui, ergo: non prenderemo un cazzo di nulla se vince. Ho provato a pagare gente per spargere voi, per dissuaderne alcuni, ma niente». La sua voce stizzita mi fece ridere. «Che ci posso fare, sono una leggenda». Mi spolverai la spalla beccandomi un cazzotto in quel punto e un grugnito poco gentile. «Dovresti iniziare a perdere, dici che potrebbe funzionare?». James fissò Peter come a cercare la sua approvazione. «Forse, ma perderemmo soldi ugualmente. Riparare le auto costa, e tu lo sai». Alle volte pensavo quei due vivessero in un mondo tutto loro. «Si, pronto?? Il pilota è qui e dice che non gliene fotte un cazzo, non perderà». Modestamente ci tenevo al mio primato. «Allora preghiamo tutti che il Leone ti batta». Leone era un tipo parecchio talentuoso che correva spesso, nessuno sapeva il suo vero nome. «Bacerà il mio maestoso culo». Sollevai il dito medio beccandomi le loro risate divertite. Avevo due settimane di tempo per prepararmi alla corsa, era il mio ritorno praticamente e nulla poteva andare storto. Avrei dovuto invitare anche Alice? «Secondo voi dovrei dirlo anche a—» James mi interruppe prima che continuassi. «Ovviamente no, non è posto per lei quello, e io non so se riuscirei a tenerla d’occhio in mezzo a tutti quegli avvoltoi». Non aveva tutti i torti in effetti. «Ma sentitelo, vuole la sua principessa a fare il tifo per lui». Peter mi scimmiottò spostandosi veloce al mio accenno nel volerlo picchiare. «Ha un dono quella ragazza, quando tifa per me io vinco. Dico sul serio». Mi fissarono scettici entrambi. «Prima o poi assisteremo allo sbocciare del vostro amore o?» James allargò le braccia con un’espressione sinceramente curiosa. «Ovvio che no, pensi vorrebbe uno come me?» «Purtroppo si». Peter e la sua affermazione gelarono la stanza. «Ma che cazzo dici?» lo fissai in tralice incredulo. «Sei così cieco.» ( LAUREN )
Sfilai la cinta dell’accappatoio tornando verso la camera da letto, le mie orme insanguinate tracciavano quasi una mappa dei miei ultimi movimenti. Il corpo riverso a terra giaceva immobile sommerso dal suo stesso sangue, simile ad un porco condotto al macello. Poggiai i piedi sopra la sedia attaccando la cinta alla trave, legandola al mio collo senza distogliere gli occhi da quel viso ingrigito sotto di me. I suoi occhi erano adesso vacui e spenti. Avevo passato gli ultimi due giorni a farmi scopare dai suoi amici, li aveva portati lì con quello scopo, nessuna riunione, nessuna spartizione di droga o denaro. Li aveva portati lì col chiaro intento di vendermi e pagare i suoi debiti. Avevo contato ogni corpo sopra di me, ogni penetrazione tra le mie cosce adesso macchiate di sangue e piene di lividi. Quando erano andati via sazi e soddisfatti ero rimasta immobile per ore, incapace di muovere anche un solo muscolo del mio corpo. Lo sentivo ridere dall’altra stanza, aveva visto tutti quegli uomini scoparmi e ora rideva. Andarmene non sarebbe stato abbastanza, a che pro in fondo? Io una vita fuori da quelle mura non l’avevo più. Avevo perso tutto venticinque anni fa, quando restai sola e incinta. Quando il mio amore abbandonò me e quella vita stanca. Andarmene non era abbastanza. Piantai la lama sul suo petto così tante volte da sentire le braccia indolenzite, non potevo andarmene senza portarlo con me. Jayden l’avrebbe cercato e ucciso, si sarebbe rovinato ancora la vita per colpa mia.
Chiusi gli occhi un istante e rividi il suo viso, somigliava così tanto a suo padre. Mi pentii di non avergli detto chi fosse, mi pentii di non avergli detto che in passato ero stata una donna felice. Una donna indaffarata ad amare. Una donna pulita, senza droghe, senza alcool, senza Luke pallido riflesso di lui ed ennesima punizione che mi concedevo. Quando spostai la sedia i miei occhi si spensero fissando il corpo morto ai miei piedi. Penzolai come una bambola di stoffa, finalmente protagonista e artefice della mia vita. |
Capitolo 4
*** Hero(in) ***
 IVUn rumore improvviso, un sordo bussare quasi violento, mi strappò dal sonno in cui ero caduto dopo una notte di bagordi con James e Peter. Sollevai appena il viso cercando di capire se l’avessi sognato o meno, ma l’ennesimo forte rumore bastò a togliere ogni dubbio, fissai la sveglia segnava le 4:00. Mi alzai a fatica andando a tentoni lungo il corridoio. «JAYDEN COX, POLIZIA DI NEW YORK». A quelle parole mi bloccai, avevo con me una pistola e sapevo bene che trovarla lì equivaleva a finire dritto davanti al giudice. Imprecai a bassa voce velocizzando il passo, aprendo la porta poco prima che la buttassero giù. Ci fissammo per un tempo che mi parve infinito, non avevo fatto un cazzo ne ero sicuro. O meglio, nulla che loro potessero sapere. La Range Rover era parcheggiata a qualche isolato da casa mia, ricollegarmi a lei era impossibile. «Salve agente, un ottimo orario per venire a farmi visita». Sorrisi sterile fissando i due uomini che sembravano adesso meno sicuri di se. «Signor Cox deve venire con noi». Aggrottai la fronte aprendo del tutto la porta, incrociando le braccia al petto. «Non ho fatto nulla, avete un mandato?». Mi fissarono ancora più a disagio. «Non è per lei. Ma per sua madre». Smisi di respirare, il semplice atto di inalare l’aria sembrò troppo complicato. «E’ nei guai? Datemi un minuto». Feci loro cenno di aspettare ma non ne ebbi il tempo. «Signor Cox—» il secondo poliziotto si interruppe lasciando la parola al primo. «Deve seguirci all’obitorio, sua madre è morta.» La mia vita si arrestò a quella frase, ogni cosa che seguì dopo sembrava proiettata come un film in bianco e nero senza suono, ero seduto su sedie rosse sporche e vecchie a fissare il monitor incepparsi. I miei passi lungo il corridoio mentre indossavo una felpa logora sopra i pantaloni del pigiama. Il mio dimenticare le scarpe, e la sensazione dell’asfalto gelido sui piedi mentre salivo sulla loro volante per la prima volta da innocente. L’odore asettico di quel posto, i muri intonacati di un verde raccapricciante e la porta in metallo che si aprì al mio passaggio. Un medico dal cipiglio arcigno mi accolse e senza preamboli scoprì il lenzuolo. Non avevano trovato alcun documento in casa, era come un’estranea lì dentro, qualcuno senza identità. Una vicina aveva fatto il mio nome, aveva detto ‘’quella donna ha un figlio, ma non viene ormai più’’. Mi venne da ridere, l’avrei uccisa quella puttana. «Ragazzo». Il medico mi ammonì, non mi ero reso conto di aver allungato il braccio per sfiorarla, sfiorare il livido sotto il collo. Aveva fatto male? Quando l’aria ha abbandonato totalmente il tuo corpo, hai sofferto? Nessuno avrebbe risposto a quelle domande, tantomeno lei. «E’ la signora Lauren Cox?». Strinsi i denti annuendo, non riuscivo a proferire parola. «Posso restare solo con lei?». Lo fissai e i suoi occhi improvvisamente sembrarono divenire lucidi, lo vidi in difficoltà quasi come gli pesasse condividere ossigeno con me in quel momento. Non so che espressione vide su di me, ma tanto bastò per farlo sparire oltre quella porta. Eravamo finalmente soli, quanto tempo era passato dall’ultima volta? Avevamo sempre avuto il nostro microcosmo perfetto, un luogo dove bastarci a vicenda, quand’è che tutto era cambiato? Come avevo potuto far si che questo succedesse? Ero stato così cieco ancora una volta. Le sfiorai il viso, era freddo e rigido, non era più mia madre. Quel corpo vuoto non conteneva la minima traccia di lei, chi mi avrebbe chiamato adesso con quella voce stanca e fine ‘’amore mio’’? Chi avrebbe accarezzato i miei capelli lasciandomi dormire sulle sue gambe? La mia vita piombò nell’ennesimo buco nero e non riuscii a vederne la luce. «Jay?». Stavo accucciato al muro del corridoio, mi ero accasciato così lentamente da non rendermene conto. Non risposi a quella voce, non volevo sentirla. «Jay ti prego, dobbiamo andare». Mi scrollai da quella presa fissando Alice con occhi infuocati. «Lasciami stare». Vidi le lacrime nei suoi occhi, volevo urlarle contro che non aveva il diritto. Non era lei quella a dover piangere, ma io. «Jay so cosa—» non la feci continuare, mi alzai inferocito allontanandomi. «CHE CAZZO NE SAI TU? COSA. COS’E’ CHE SAI?». Mi pentii subito di quelle parole, non avevo neppure assistito al funerale di sua madre, non ero stato lì mentre lei adesso era qui per me. Ci fissammo intensamente e io crollai. Mi schiantai su quel suolo, tra le sue braccia. Il mio pianto usciva a singhiozzi, quasi grottesco, simile alla voce di un bambino cresciuto troppo in fretta. Stringevo la stoffa della sua maglia, la mia faccia sepolta contro le sue cosce mentre i suoi jeans assorbivano le mie lacrime. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Ero riuscito a farle avere un funerale privato, fissavo il prete e poi la bara a minuti alterni, continuavo ancora a non sentirmi padrone del mio corpo e della mia vita in quel momento. Continuavo ancora a sedere su quelle sedie impolverate guardando quel film, vedendo me come protagonista, ma restandone ai margini. Di fianco a me Alice mi teneva la mano, alla mia sinistra Peter e James dai visi pallidi e sconvolti. Tutti sapevano, tutti mormoravano sulla donna che aveva assassinato il compagno e poi si era tolta la vita, li sentivo erano come un brusio dentro le mie orecchie, come uno sciame d’api infernale che pungeva e pungeva e pungeva. Alice gemette sottovoce, mi resi conto in quel momento di averle stretto la mano con così tanta forza da staccargliela quasi. Non mi scusai, come non mi ero scusato per tante cose in quei giorni, non mi ero scusato per la mia apatia, il mio non mangiare, il mio continuare a inveire contro tutti. La mia rabbia non poteva essere colmata, mia madre aveva pensato a tutto non mi aveva lasciato neppure il piacere della vendetta per consolarmi. Luke non c’era più. Morto a marcire coi vermi, lo aveva portato con se pensando di liberarmi anche di quel fardello. Cosa mi restava adesso? Mi sollevai, tutte le teste si girarono, le ignorai uscendo da quella chiesa che puzzava di incenso e fiori, puzzava di morte, ammorbava l’aria impedendomi di respirare.Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. L’accendino scattò due volte, qualcuno mi avvicinò la fiamma del suo, sollevai gli occhi e Stuart mi sorrise. «Non ho voglia dei tuoi sermoni». La mia brutalità lo divertì probabilmente, annuì silenziosamente lasciandomi fumare in silenzio. Non dormivo decentemente da giorni, non ci riuscivo. Ogni volta che chiudevo gli occhi la vedevo penzolare in una pozza di sangue. «Quando Anna mi ha lasciato ho pensato il mio mondo avesse perso colore». Inspirai il fumo senza dire nulla. «Niente più profondità negli oggetti, niente più suoni. Avevo solo Alice come suo pallido riflesso». Sorrisi spento. «Quindi? Mi stai dicendo che dopo un po’ passa?». Mi fissò inarcando un sopracciglio. «Non passa mai. Le cicatrici del cuore permangono una vita intera, sta a noi decidere però se curarle o lasciarle aperte a infettarsi». Non riuscii a ribattere, lui meglio di me forse sapeva che mi sarei lasciato andare ancora una volta. Lui meglio di me sapeva quanto i miei occhi neri fossero il preludio della catastrofe. «Ha pianto molto al funerale? Dico, Alice, ha pianto molto?». Ci guardammo qualche secondo, lo vidi respirare profondamente, sapevo quanto dolore gli costasse ricordare. «Ha pianto molto, si. Ricordo però di averla persa di vista durante la cena, la trovai nel dondolo sul patio. Sai cosa mi disse?». Feci di no con la testa invogliandolo a continuare. «Mi disse: se ci fosse Jay avrebbe fatto di tutto per farmi ridere, mi avrebbe fatto fare quello stupido gioco dello specchio, mi avrebbe ricordato ogni mia figuraccia. Mi avrebbe fatta ridere». Chiusi gli occhi e le lacrime uscirono nuovamente fuori dai miei occhi, mossi il capo come a invogliarlo a smettere, sentii solo la sua mano calda e pesante sulla spalla. Ma non bastò. Non bastava mai. Niente sembrava poter bastare in quel momento, mi stavo arenando ancora e non c’era nulla che potessi fare per fermare la mia barca alla deriva. Neppure chiedere aiuto sarebbe bastato. ( ALICE )
«Sono preoccupata per lui, non risponde alle mie chiamate da giorni». Giocherellai con la bottiglia di fronte a me, James si mosse e la sedia accanto alla nostra scricchiolò annunciando l’arrivo di Peter a quella sorta di riunione notturna. «Ha perso la madre, suppongo sia comprensibile». Vidi James fissarlo e passarsi una mano sul viso, aveva le unghie perennemente annerite a causa del suo lavoro. «Ho solo paura che commetta qualche sciocchezza..» la mia voce insicura sembrò dare voce ai pensieri di tutti in quel momento. «Ha saltato anche la corsa». James si attaccò alla propria birra come un assetato nel deserto. Non vedevo Jay da giorni, deviava persino le mie chiamate e non rispondeva al sordo bussare delle mie nocche contro la sua porta. Mi ero persino appostata ore sotto casa sperando di vederlo uscire ma niente, iniziavo a provare difficoltà persino a seguire le lezioni e il mio tirocinio in ospedale era ormai alle porte. Non avevo più scritto alcuna lettera per lui, le mie parole adesso sembravano incastrate nella gola quasi morissero dal desiderio di essere urlate. «Ho un appuntamento, devo andare». Fissai l’orologio ricordandomi solo in quel momento di Matt, un mio collega universitario a cui avevo dato buca una decina di volte. James mi fissò in maniera strana. «Esci con un ragazzo?» Peter diede un calcio alla sua sedia in segno d’ammonimento. «Si, perché? Non posso?». Risi in maniera insicura. «No no figuriamoci, è un bene tu ti trovi un bravo ragazzo. Insomma Jay—» un’altra pedata alla sua sedia seguì un’imprecazione di James. «HAI ROTTO IL CAZZO PETER.» «Parla chiaro». La mia voce divenne tagliente. «Che dovrei dirti?» «Jay cosa?» Peter sbuffò bevendo in silenzio. «Jay nulla, appunto». I nostri sguardi si sostennero, fui la prima a sviare e mi sentii come se avessi appena perso uno scontro. Perché poi? Che colpa avevo? A parte l’essere una codarda che non riusciva a esprimere i propri sentimenti verso l’uomo che amava, ripiegando quindi su altri? Già, che colpa avevo? ( JAY )
Lo chiamavano tutti Safari, forse a causa della sua pelle scura o dei dreads ai capelli. Una cicatrice sembrava spezzare a metà il suo occhio sinistro adesso cieco, un velo azzurro a coprire la sua pupilla, quando ti fissava sentivi le urla dei morti. Lo vidi fermo al solito posto, sollevai il cappuccio della felpa fissando gli altri ragazzi in fila prima di me. La processione dei condannati, mi piaceva chiamarla così. Ognuno di loro aveva una storia da raccontare, ognuno di loro una croce da portare proprio come me. O almeno questa è la scusa di comodo che mi diedi per essere lì in quel momento, sarei potuto andar via adesso e nessuno lo avrebbe mai saputo ma semplicemente non riuscivo a muovermi. Ricordai il mio anno a Chicago, mi sentivo allo stesso identico modo, con l’unica differenza che adesso un posto dove tornare non l’avevo più, non avrei potuto bussare alla sua porta e vederla apparirmi oltre il vetro, fissarmi coi suoi occhi buoni e chiamarmi ‘’amore mio’’. «Jay? Non ti vedevo da un po’». I suoi denti bianchi brillarono nella penombra, tirai su col naso improvvisamente nervoso. «Già.. ho avuto da fare». Mi scrutò quasi come se sapesse. «Che ti serve?». Inarcò un sopracciglio sorridendo, mi era sempre stato sul cazzo il suo modo di sorridere. «Il solito». Mi grattai la guancia guardandomi intorno. Uno scambio pulito e veloce, lui i soldi io l’eroina. La misi in tasca sentendola pesante per tutto il tragitto, quando arrivai a casa i miei movimenti sembravano automatici. Non mi bucavo ormai da tempo eppure ricordavo tutto alla perfezione, era come se il mio corpo non stesse aspettando altro o forse questo era il pensiero di un poveraccio che vuole sentirsi meno inutile. Il laccio emostatico strinse la mia pelle, l’ago la bucò e per sessanta secondi io trovai la pace. Non c’era mia madre, non c’era il suo corpo penzolante dal soffitto. Non c’era Luke. Ma c’era Alice, persino in quel momento la consapevolezza di lei non sembrava volermi abbandonare. Quando piombai in una sorta di torpore sentii la sua mano fresca sulla mia fronte, soffiò tra i miei capelli sudati sussurrandomi che andava tutto bene. Capii da quello che non era reale, perché nulla stava andando per il verso giusto, non più. |
Capitolo 5
*** Distance ***
 VRigirai il cartoncino finemente intarsiato tra le dita che tremavano appena, non vedevo Stuart e Alice dal giorno del funerale. Inizialmente la mia era semplice chiusura verso il mondo, verso coloro che mi amavano, verso i loro sguardi così pieni di pietà da corrodermi come acido sulla pelle. Dopo quella notte il motivo era cambiato, era subentrato il senso di colpa, ero ripiombato in quel vortice dalla quale pensavo di essere uscito per sempre. E non bastava pentirmi, non bastava cospargermi il capo di cenere, no stavolta nessun ‘’mi dispiace’’ sarebbe bastato, lo sapevo e non riuscivo ad affrontarli. Loro però sembravano ancora una volta decisi a non mollare la presa su di me, avevo trovato tra la posta l’invito alla festa per il pensionamento del Generale Stuart Wilson, e a quella proprio io non potevo mancare. Spesso mi chiedevo se avrebbe mai fatto differenza avere un padre come lui o se il problema di base ero io piuttosto che la mia infanzia e il mio passato che mi tormentava in ogni attimo delle mie giornate. — Hai ancora il vestito del matrimonio di tua sorella?
— Perché? — Ce l’hai o no? — Perché? — James hai rotto il cazzo, ti ho chiesto se ce l’hai. — Si, ma a che cazzo ti serve? — Ho una cena, il generale l’ha organizzata. — Passo a portartelo dopo il lavoro. — Okay. — Ah, la prossima settimana ci sarà una corsa. — Parteciperò. Mi fissai allo specchio sistemandomi i polsini della camicia, non era male nell’insieme. Io e James avevamo praticamente la stessa taglia e altezza. Provai a fare il nodo alla cravatta, i miei occhi dallo specchio incrociarono i suoi. Lo vidi seduto sulla poltrona intento a bere della birra. «Devi dirmi qualcosa?». Lo conoscevo come le mie tasche, modestamente. «No figurati». Sollevò una mano mostrandosi disinteressato, lui sembrava invece non conoscere me. «Okay.» «In realtà—» si stoppò un secondo e per un attimo ebbi il timore si fosse accorto di qualcosa. «In realtà si, c’è qualcosa.» «E cosa?». Disfai nuovamente il nodo, la mia mente era più confusa del solito. «Alice esce con un ragazzo». Le mie dita si bloccarono contro la stoffa grigia, i miei occhi si piantarono sulla figura seduta a qualche metro da me. «Chi?». Mostrai un’indifferenza ben lontana dalla realtà. «Non lo so, un collega forse.. che ti aspettavi? Chi tardi arriva male alloggia». Sollevò la bottiglia con un mezzo sorriso ed ebbi l’impulso di mandarlo a cagare e sbatterlo fuori da casa mia. «E’ complicato, tu lo sai». E adesso ancora di più, ma evitai di dirlo. «Non lo so, non so cosa ci sia di così complicato. Mi sembrava soltanto giusto avvisarti». Scrollò le spalle con indolenza alzandosi, sparì lungo il corridoio e due minuti dopo sentii la porta chiudersi lasciandomi solo coi miei pensieri. Chiusi gli occhi sedendomi ai bordi del letto, sostenendomi il capo quasi temessi potesse cadere e ruzzolare sul pavimento. Il solo pensiero che delle mani sconosciute la toccassero mi provocava più nausea di quando iniettavo male l’eroina nelle mie vene. ***
«E’ proprio vero che l’abito cambia totalmente un uomo». La voce divertita di Stuart mi accolse nell’atrio, lo fissai con un mezzo sorrisino stringendogli la mano. Scrutai in quelle pozze chiare, così simili a quelle della figlia, cercando tracce di consapevolezza. Recentemente temevo chiunque potesse accorgersi dell’errore in cui ero ricaduto, eppure in quel sorriso bonario non colsi nulla se non il palese affetto che lo legava a me. A uno scarto come me. «Credo di essere in ritardo». Potendo sarei arrivato direttamente a cena finita, quei posti mi mettevano sempre a disagio. Quelle persone così diverse da me mi facevano sentire ancora più in difetto. «Alice sarà felice di vederti, era sicura non saresti venuto e io ho appena vinto la scommessa». La sua risata profonda ci immise direttamente nel grande salone brulicante di gente, fissai i loro abiti abbastanza simili ai miei, i loro visi rilassati e altri troppo pieni di botox per riuscire a capire quanto poco o molto si divertissero. I suoi capelli lunghi e rossi attirarono la mia attenzione, accanto a lei un ragazzo le sussurrava qualcosa all’orecchio, serrai la mascella ripensando alle parole di James. Quand’è che il mio treno aveva lasciato la stazione? O meglio, era mai arrivato a quella dannata stazione? C’era mai stata una fermata che l’avesse coinvolta? Si era mai sbracciata verso il treno in partenza supplicandolo di fermarsi? E io? L’avevo fatto io? SI. Lo urlai nella mia mente, avevo preso un fottutissimo treno da Chicago solo per ritornare da lei. Da mia madre che non c’era più. Cosa mi restava adesso? I nostri occhi si incontrarono soppesandosi, i suoi colmi di sorpresa e un altro sentimento che non volli definire, era forse imbarazzo per la presenza dell’altro? Quindi sapeva quanto male mi facesse in quel momento? Le andai incontro e per la prima volta non sorrisi. «Sei venuto davvero..» la sua voce sottile si cristallizzò tra noi. «Ti dispiace?». Il mio tono inacidito la fece sobbalzare, aprì la bocca per rispondere ma l’intervento dello sconosciuto glielo impedì. «Sono Matthew, tu devi essere Jayden.. Alice parla spesso di te». Mi sorrise porgendomi la mano, la strinsi senza ricambiare la premura. «Chissà cosa dice». Il mio tono fintamente cordiale ingannò lui ma non lei. «Dovremmo—» Alice provò a interromperci senza successo. «Ha detto che siete cresciuti insieme». Mi stava sul cazzo quella sua sottospecie di bontà. «Ha detto proprio così? In realtà sono il semplice ragazzo di strada accolto per pietà.» «Jay». La sua voce tremante, le sue dita sulla mia giacca. «Oh, beh in realtà—» per un secondo mi fece tenerezza, non era lui il cattivo in quel momento. Ma io. Mi scrollai da quella presa allontanandomi da lì, afferrando un calice pieno di qualcosa che scolai senza indugio. «Festicciola noiosa, eh?». Seguii il suono di quella voce trovandomi di fronte una ragazza dai lineamenti eleganti e i capelli biondi. «E tu saresti?». Inarcai un sopracciglio, mi ero già rotto il cazzo dei convenevoli e stavo lì solo da dieci minuti. «Katie, tu devi essere Jayden». C’era qualcuno tra quelle merde umane a non conoscermi? Iniziavo a dubitarne. «E’ una festa in mio onore e non ne sapevo nulla?». La mia battuta la fece ridere, o forse si sforzò di farlo. «Non ti ricordi proprio di me». Aggrottai la fronte mandando giù il bolo che ostruiva la mia gola. «Ci siamo già visti?». In quel momento vidi Alice fissarmi, mi spostai appena ignorandola. «Un bel po’ di tempo fa, ricordi il compleanno di Alice? I suoi quindici anni, ero la ragazzina grassa che tutti prendevano in giro». Ci credo che non mi ricordavo di lei, si era praticamente dimezzata e la mia faccia rese palese quel pensiero facendola ridere. «Katie, ma certo.. mi ricordo di te». E non mentivo, quella ragazza all’epoca era un’emarginata come me. Io ero lo straccione, lei la grassona. Mi sentii improvvisamente peggio, lei quantomeno era riuscita a uscire da quelle vesti lerce, io ero rimasto il solito scarto che ero a diciassette anni. Afferrai un altro calice bevendolo tutto d’un fiato. «Possiamo parlare?». Osservai le sue dita esili aggrappate alla mia giacca. «No non possiamo, se vuoi scusarm—» provai a divincolarmi ma non me lo permise. «Perché fai così?». Odiavo la sua voce sconsolata, sul serio mi rendeva ancora più miserabile di quanto non fossi già di mio. «Credimi, non vuoi saperlo sul serio» le sorrisi sciogliendo la presa con poca delicatezza. «Invece si». Tornò ad afferrarmi, mi guardai intorno senza percepire alcuno sguardo su di noi. «Dove hai lasciato il tuo accompagnatore? Non è carino da parte tua mollarlo così sai?». La mia ironia scivolò tra noi come acqua sporca. «Hai idea di quante chiamate io ti abbia fatto? O di quante volte abbia bussato alla tua porta?». La sua rabbia mi rimescolò dentro, l’afferrai trascinandola in disparte, verso il giardino illuminato a festa e al momento deserto. «Abbassa la voce». Sibilai quelle parole a un centimetro dal suo viso, fissando la porta finestra schiusa. «Altrimenti?». Mi sfidò apertamente senza scostarsi. «Altrimenti un cazzo, piantala di sfidarmi». Restammo in silenzio un istante, la sentii ridere ma non c’era gioia nel tono. «Stavi provando a sedurre anche Katie?». Aggrottai la fronte. «Anche? Quante tue amiche avrei sedotto, di grazia?». Stranamente mi sentivo innocente. «Non è mia amica». Il tono velenoso mi lasciò interdetto. «Perché? Adesso è magra si conforma agli standard della tua gente». Se l’avessi schiaffeggiata probabilmente avrebbe messo su un’espressione meno ferita. «Pensi questo di me?». La fissai in silenzio senza sapere bene cosa dire, la mia rabbia aveva ancora una volta parlato a sproposito. «Venire a questa festa è stato un errore, salutami tuo padre». Mi voltai provando a sfuggire ai suoi occhi, a quell’atmosfera improvvisamente tesa ma non me lo permise piazzandosi nuovamente di fronte a me. «Ti ho fatto una domanda. Pensi questo di me? Pensi io sia come loro? Che scelga chi amare in base alla classe sociale?». In realtà no, non lo pensavo davvero. Eppure una parte di me, la più infima, lo pensava; se non fosse stato così al posto di quel tale al suo braccio ci sarei stato io. «Sai cosa? Tutto cambia. Non siamo più due ragazzini Alice, adesso non basta più l’affetto, sono altre le cose che contano. I nostri mondi semplicemente non coincidono, lo sai tu e lo so io». Mi fissò come se non credesse alle mie parole. «Sono da sempre l’unica che prova a farli coincidere, sono l’unica che è venuta nel TUO mondo provando a entrarci pur di stare con te». Sputò quell’accusa quasi fosse un peso impossibile da sopportare. «E tu? Sei mai venuto tu nel mio?» «L’ho fatto adesso e mi è bastato». La superai provando nuovamente ad andarmene. «Ho aspettato anni che i tuoi occhi si aprissero e mi vedessero, non succederà mai vero?». Mi bloccai a quelle parole voltandomi. «Non puoi averlo detto sul serio. Ho passato i miei ultimi dieci anni a vederti Alice, ho sempre e solo visto te, nessun’altra. E anche nelle altre io vedevo te». La indicai sprezzante come se quella fosse una colpa sua e non mia. «Tu non hai idea del modo in cui volevo tu mi vedessi». Una fitta di dolore mi percorse il petto, tirai su col naso serrando i denti che sfregarono tra loro. «Tu non hai la benché minima idea di come io ti veda.» «E tu non hai la benché minima idea di come io abbia visto te». Stavolta fu lei a voltarmi le spalle lasciandomi lì da solo, solo come mi sentivo d’essere. Avrei voluto fermarla, chiederle cosa intendesse dire ma non ci riuscii. Semplicemente me ne andai, abbandonai il vociare insistente e la musica classica rinchiudendomi nella mia auto, correndo come un pazzo lungo le strade illuminate alla ricerca di qualcosa. Qualcosa che non sapevo neppure io cosa fosse. O meglio quel qualcosa che avevo lasciato a quella festa, con un vestito in seta bianco che mai più avrei dimenticato. ***
— Safari dove cazzo sei. Ti aspetto da ore, ho bisogno della roba—sto male. Sto male sul serio, okay?
— PER QUALE PORCA PUTTANA DI MOTIVO NON RISPONDI ALLE MIE CHIAMATE. Cazzo ti uccido. Ho una corsa tra poche ore lo capisci? RISPONDI A QUESTO STRAMALEDETTO TELEFONO, BASTARDO. Il rombo dei motori giunse attutito alle mie orecchie, camminavo in mezzo a quei corpi senza neppure sapere come mi reggessi in piedi. Ero madido di sudore, tremavo e la nausea non mi dava tregua mentre il dolore sembrava voler fare esplodere le mie budella. Eppure ero lì, ero lì perché dovevo correre, dovevo riprendere la posizione che a lungo avevo lasciato vuota. Quel podio per la quale sembravo nato. E anche perché i soldi iniziavano a scarseggiare. Vidi James accanto alla nostra auto, mi venne incontro sorridendo ma si bloccò fissandomi sconvolto. «Che cazzo hai». La lingua sembrava incollata al mio palato. «Nulla, credo di avere solo un po’ di febb—febbre». I suoi occhi lentamente presero consapevolezza. «Non ci posso credere, hai ripreso a farti.. brutto bastardo hai ripreso a bucarti». Mi venne incontro a mani alzate, chiusi gli occhi provando a mantenermi lucido. «Non ho ripreso un cazzo. Non mi faccio, sto solo male, lo giuro». Quando li riaprii vidi il disgusto nei suoi occhi, pensai fosse abbastanza come punizione. «TU SOPRA LA MIA AUTO NON SALI». La indicò spingendomi, non ebbi la forza di contrastarlo e per poco non caddi a terra. «Io correrò, l’auto l’ho fottuta io e io ci corro». La rabbia iniziò a montarmi dentro, la indirizzai verso di lui per non abbatterla su me stesso già demolito dall’astinenza. Avevo provato a sopperire la mancanza con l’erba, ma non era servito a un cazzo. «Posso sapere che diavolo succede?» Peter apparve piazzandosi accanto a James. «Dillo a lui, dillo a questo bastardo tossico che ha ripreso a bucarsi». Mi indicò come fossi il peggiore dei vermi. «Hai ripreso a farti?». Mi fissò con una tranquillità agghiacciante. «N—NO NON HO RIPRESO, VUOI LITIGARE? FATTI SOTTO NON HO PROBLEMI». Mi avventai contro James ma Peter si mise in mezzo spingendo entrambi. «Ha detto di no, fallo correre». Per una volta le nostre espressioni coincisero, entrambi sbigottiti dalle sue parole. «Stai scherzando?» «No». Scrollò le spalle senza guardarmi. «Io vado a correre, voi andate a farvi fottere». Mi allontanai così senza più voltarmi, salendo sull’auto. La corsa stava per iniziare. «Ha una crisi d’astinenza.»
«Lo so bene.» «E l’hai lasciato guidare?» «Vedila positivamente, morirà dentro un auto come piace a lui piuttosto che con una siringa sul braccio.» «Ma che cazzo di logica sarebbe?» «La mia.» La prima volta in cui ho schiacciato il piede sull'acceleratore avevo tredici anni, ho capito subito che era quella la mia strada. Le auto sono un prolungamento di me stesso, non c'è stato giorno in cui abbia avuto paura mentre il tachimetro si alzava sempre di più. Ma adesso si. Le mie mani sudano. Il mio cuore sta per esplodere e solo il rombo del motore riesce ad attutirlo. Sono in fottutissima paranoia, un ronzio persistente trafigge le mie tempie. Mi accascio sul sedile vomitando bile sul tappetino mentre una ragazza solleva una bandierina consunta. Sono tutti pronti, la mia gamba ha un lieve tremore, ci stanno 34 gradi ma continuo a sudare freddo e rabbrividire. 𝐆𝐎
Mi ripeto da giorni che il punto di rottura non è ancora arrivato, sono solo due fottutissime dosi al giorno in fondo. Si ma per quanto? Ne ho saltata una, e quando quel figlio di puttana non si è presentato ho passato le ore vomitando, contorcendomi nel mio stesso schifo. Accelero ancora, l'auto protesta quasi non volesse obbedirmi, ma lo farà come sempre. Sono ancora in paranoia. Il mio cervello macina pensieri uno dopo l'altro mentre con gli occhi schizzo impazzito a fissare le auto. Le supero, sto vincendo e vorrei sollevare il dito medio verso James che starà guardando. Rido e piango. Piango e rido. Mi viene da vomitare, i crampi mi stanno divorando da dentro. Alle volte ho di nuovo l'impressione di non avere più il controllo del mio corpo, è come uno schifoso replay di Chicago. Succede ancora, riesco a vedere l'arrivo ma uno spasmo improvviso al braccio mi fa sbandare; mentre fisso il muro comando il mio fottutissimo cervello urlando: il freno. Il freno cazzo. IL FRENO. Non mi ascolta. Arriva lo schianto, le urla e il fumo. Quando esco dall'auto con lo sportello rotto tra le mani sento qualcosa di viscoso sul viso, tocco il sopracciglio completamente aperto, probabilmente non ci vorrà un semplice cerotto ma sono vivo cazzo. Sono qui. Sono vivo, e non so se questo mi renda felice o meno. Il sangue che cola sugli occhi appanna la mia vista, riesco però a fissare James che sembra terrorizzato, vorrei dirgli che ho giurato il falso, che l'eroina è la mia punizione e la inietto direttamente in vena aspettando la redenzione. Vedo Peter accanto con le labbra appena schiuse, a lui non direi nulla e noi sappiamo perché. Ho perso. Ho perso per la prima volta nella mia vita, do un calcio a quel fottuto sportello allontanandomi da lì. Non me ne frega un cazzo di andare da loro a chiarire, devo avere la mia dose o morirò. Morirò. Morirò. 𝐒𝐓𝐎𝐏
— Pronto? — Sono James, sei a casa? — Che è successo? — Si tratta di Jay. — … Sta bene? — Beh—potrebbe star meglio credo. — Spiegati meglio. — Sai già come suturare? Insomma frequenti quella cazzo di università per medici. — …. — Vai a casa sua, lui non ti chiamerà di sicuro. |
Capitolo 6
*** A junkie spends half his life waiting. ***
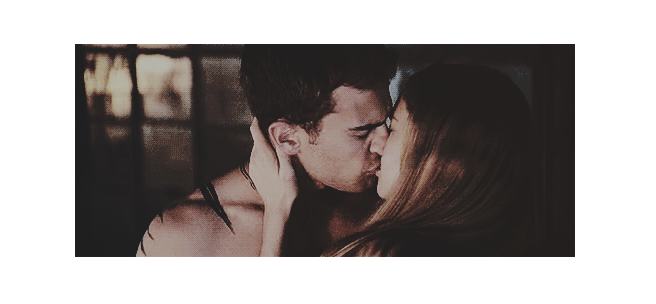 VIVivere da sola aveva adesso i suoi pregi, per esempio se nel cuore della notte mi arrivava una chiamata da infarto non avevo bisogno di sgattaiolare dalla finestra – com’ero solita fare in adolescenza – per non spaventare papà. La mia mente vorticava in un mare tempestoso di pensieri, il fatto che non avesse chiamato lui ma James era abbastanza per mettermi in allarme, che cosa gli era successo? Aveva fatto a botte? Magari durante una rissa avevano uscito i coltelli e .. no no dovevo stare calma, agire d’impulso e farmi divorare dalla paura non era di sicuro il metodo adatto per uscirne indenne. Afferrai la borsa con tutti i miei attrezzi, ricordavo ancora il giorno in cui papà me li aveva regalati, adesso sembrava tutto così lontano. Come se la patina di quel sogno si fosse sporcata lasciando posto alla cruda e nuda realtà. Due colpi alla sua porta prima di sentire da dentro giungere rumori attutiti, sembravano passi strascicati e questo mi confortò; insomma se riusciva a camminare non stava morendo dissanguato in qualche angolo o no? Non capivo perché non fosse andato in ospedale, perché aveva preferito marcire da solo in quella casa. Come sempre. Sembravo non riuscire a trovare un posto accanto a lui, e le nostre parole in quella notte rabbiosa continuavano a rimbombare nelle mie orecchie come le unghie che graffiavano la lavagna. I miei occhi si poggiarono sull’uscio che lentamente si spalancò lasciando il posto al suo viso, la borsa mi cadde dalle mani, soffocai un urlo contro il palmo fissandolo incredula. Teneva una maglia sporca di sangue a coprirgli una parte del viso, il petto nudo era striato di rosso, come se il sangue fosse caduto e raggrumato anche lì. «Che cosa hai fatto..» tra i due non avrei saputo dire chi in effetti fosse il più sconvolto. Mi fissava quasi come se non mi vedesse. «Cosa ci fai qui». Il tono basso ma sbrigativo mi fece pensare che non aveva digerito la nostra litigata di qualche giorno prima. «Secondo te?». Sollevai la borsa in un gesto eloquente spostandolo con poca grazia per immettermi dentro casa. Nonostante la penombra riuscivo a scorgere le sagome dei mobili, degli abiti gettati a terra, l’aveva ridotta ancora un porcile. Come se non riuscisse a vivere nell’ordine, una sorta di complicata metafora dalla quale avrei dovuto dedurre alcune cose. Anzi moltissime cose. «Chi ti ha chiamata?». La sua voce mi arrivò eccessivamente vicina, voltai appena il viso scoprendolo praticamente accanto a me, ci fissammo con pesantezza finché non lo vidi interrompere quella guerra silenziosa e farsi spazio diretto verso la propria stanza. Lo seguii in silenzio, evidentemente sapere chi mi avesse avvisato non gli interessava poi molto. Camera di Jay era esattamente come l’avevo lasciata, disordine a parte, in qualche modo la parte della casa che sicuramente lo rispecchiava di più. Poggiai la borsa sulla poltrona vicino il letto andando a riempire una bacinella con acqua, cercando asciugamani puliti per pulire la ferita. «Posso sapere come ti sei ferito?». Lo trovai seduto sul bordo del letto, la poltrona adesso di fronte a lui quasi come se l’avesse preparata in vista del mio ritorno. «La corsa è andata male». Adesso mi spiegavo anche il motivo per la quale non era andato in ospedale, il fatto che non mi avesse chiamata mi mortificava più di quanto volessi ammettere. «Non hai mai perso una corsa…», parlai con cautela, ero sicura fosse ancora profondamente arrabbiato per quella perdita e i suoi occhi scavati me lo confermarono piantandosi addosso a me in silenzio. Cosa gli stava accadendo? Notai le pupille lievemente ristrette e un nodo attorcigliò il mio stomaco, fissai le sue braccia illuminate dalla luce artificiale ma non scorsi alcuna ferita, era il caso di sentirmi sollevata? Mi sedetti poggiando la bacinella accanto a lui sul letto, togliendogli la maglia dalla faccia per esaminare la ferita. «Sei troppo lontana». Aggrottai la fronte fissandolo. «Cosa? No, sono—» non mi diede il tempo di parlare, la sua mano si intrufolò tra le mie cosce facendomi sobbalzare, avvicinandomi insieme alla poltrona con un gesto secco quando rude. Le nostre ginocchia si scontrarono e urlai quasi di dolore, strinsi i denti fissandolo. «Perché fai così?» ( JAY )Una domanda semplice con un’infinità di risposte al suo seguito però, e tutte impossibili da esprimere ad alta voce. Ritrovarmela lì in piena notte non era stata sicuramente la miglior sorpresa dell’anno, ero sicuro l’avesse avvertita James, Peter non era il tipo anzi lui mi avrebbe fatto marcire soffocato dal mio stesso sangue per punirmi. «Sai suturare?». Inarcai il sopracciglio (quello buono) parlandole in maniera arrogante, ogni volta che la fissavo mi tornava in mente lei che si lasciava sfiorare da quelle mani estranee. Sapevo di non avere il diritto di sentirmi geloso, eppure non riuscivo a farne a meno. Alice non si scompose né mi rispose, suppongo fosse troppo avanti per quei giochetti infimi e da bambini, dimenticavo spesso che lei a differenza mia aveva intrapreso la strada che conduceva alla maturità, mentre io restavo solo e bloccato nei miei tredici anni aggrappato alla gonna di mia madre, fissando il mondo con gli occhi sporcati da un’innocenza mai avuta. Odiavo la mia vita, odiavo tutto, odiavo me stesso e odiavo lei per essersene andata. La immaginavo ancora penzolare dal soffitto, mi ero fatto una dose un’ora prima avevo pensato subito a quella che al mio viso rotto e nel momento del culmine l’avevo vista penzolare. I suoi piedi sporchi a qualche metro dal pavimento, li avrei baciati e bagnati delle mie lacrime se solo fossi stato lì. Mi domandavo spesso cosa facevo mentre mia madre era intenta a togliersi la vita, stavo ridendo? O parlando con qualcuno? Pensavo ad Alice? O magari ero direttamente insieme a lei? Non riuscivo a ricordare un singolo fotogramma di quella giornata, come se fosse iniziato tutto dall’ingresso dei poliziotti in casa mia. «Farà un po’ male..» le osservai le labbra così vicine alle mie, soffiavano aria pulita ma non abbastanza da scacciar via quella marcia dentro i miei polmoni. L’ago perforò la mia pelle, strinsi i denti socchiudendo gli occhi, le sue mani fresche su di me erano come un balsamo lenitivo. Restai fermo a subire quella punizione, ritardando il momento in cui l’avrei vista voltarmi le spalle e andare via. «Domani avrai il livido sicuramente, ne hai già uno all’altezza dello zigomo». Toccai la parte interessata con le dita tremanti, non mi interessava molto della cicatrice in realtà. «Metterò qualcosa..», restai seduto mentre la guardavo riporre ogni cosa nella borsa e richiuderla, le sue mani si bloccarono e i suoi occhi bevvero dalla mia figura china. «Avevi intenzione di sparire? Non cercarmi più e tanti cari saluti?». Il fatto che non si fosse alzata andandosene via non sapevo bene se mi procurasse più gioia o sgomento. «La fai passare come un’idea veramente brutta». Il mio tono strascicato seguì il suo sguardo ferito. «Vorrei capire cosa succede, cosa ti ho fatto esattamente per renderti così». Non c’era bisogno di chiarire il concetto di ‘’così’’ sapevamo bene entrambi cosa intendesse dire. Non potevo risponderle, non era così semplice per me, per noi, dirle tutto ciò che avevo dentro. Mi alzai mettendo una distanza esigua tra i nostri corpi, aprendo la porta finestra e lasciando che la brezza calmasse la mia ansia. Stavo rientrando in paranoia? Rovistai nel cassetto del mobile estraendo una bustina di erba, iniziando a prepararla. Sentii la sua figura alzarsi e venirmi vicino, si poggiò allo stipite con la schiena, restando semplicemente a guardarmi. «Smettila». non ne potevo più. «Di fare cosa?». Lo sapeva bene ma fingeva. Ed era questo il problema principale tra noi, giocare a chi recitava meglio quelle parti che c’eravamo cucite addosso ormai anni fa. La brace si illuminò, inspirai il fumo buttandolo fuori pochi secondi dopo, guardandolo sparire verso il cielo. «Dovresti tornare a casa Alice». Non la guardai continuando a fumare in silenzio, cercando un conforto e una tranquillità nell’erba che ero sicuro non sarebbe arrivato. «E se volessi stare qui con te?». Chiusi gli occhi respirando profondamente, quando li riaprii i miei occhi contenevano tutte le cose che non ero mai riuscito a esprimere. «Guardami negli occhi e dimmi che non hai provato ad andare avanti lasciandomi indietro». Sobbalzò a quelle parole fissandomi e scuotendo il capo. «Non l’ho mai—» non la feci neppure continuare, diedi un calcio alla porta che tremò nel silenzio ancora più assordante. «Lo hai fatto. Con quel tipo, tu lo hai fatto. Ed è giusto così probabilmente, ma smettila di tornare sempre qui e da me. Se devi andare avanti fallo e basta.» gettai la sigaretta ormai consumata oltre la ringhiera. «Ti sei mai chiesto il perché io voglia andare avanti?». La sua voce tremante mi indisponeva, aumentava solo i miei sensi di colpa. «Perché è giusto?» «No, NO. Non perché ‘’è giusto’’, perché sono stanca di aspettarti. Sono stanca di fare quel fottutissimo gioco dello specchio, sono stanca di sollevare sempre la mano sbagliata». Le sue lacrime ruppero la bolla di cristallo, allungai una mano ma lei la scostò con uno schiaffo allontanandosi da me. «Alice..» «NON VOGLIO CHE MI TOCCHI. Se mi tocchi è tutto inutile, finiresti per abbracciarmi e io finirei per cedere, non è ciò che voglio. Jay, non sono i tuoi abbracci quello che voglio». Mandai giù il bolo di saliva, faticavo a respirare, perché proprio adesso? Perché non prima, quando saperlo mi avrebbe forse salvato dal commettere per l’ennesima volta l’errore più grande della mia vita. «Ho passato gli ultimi dieci anni a ripetermi quanto fosse vitale sollevare il braccio sbagliato di fronte a te, perché non eri, non sei e non sarai mai alla mia portata». Serrai la mandibola colmando le distanze tra noi, era così vivida lì ritta di fronte a me da bruciarmi quasi gli occhi. Come poteva pensare non l’avessi mai vista davvero? «Non c’è stato giorno in cui non ti abbia vista Alice, sei diventata l’unica cosa bella della mia vita. A sedici anni pensavo fosse gratitudine e invidia, a diciotto ho capito quanto avessi sbagliato». Non riuscivo a sentirla piangere, era come se ogni singhiozzo mi scavasse dentro lo stomaco, raschiasse fin dentro le profondità lasciandomi agonizzante. Le mie labbra si avventarono sulle sue, sentii le sue mani aggrapparsi al mio collo, la sollevai quasi di peso e la sua schiena aderì all’armadio mentre sollevavo il suo vestito toccando le cosce adesso avvolte ai miei fianchi. «E’ sbagliato». Ansimò quelle parole tra un bacio e l’altro, anche volendo in quel momento non sarei riuscito a fermarmi. «Lo so». La trascinai verso il letto, il suo corpo toccò le lenzuola morbide e il mio la sovrastò. La fissai stesa, con i capelli sparsi sul cuscino a formare una sorta di corona, il vestito del tutto sollevato lasciava poco all’immaginazione. «Jay—» il mio bacio la rapì ancora una volta, mi ero chiesto per anni se il suo sapore fosse stato un semplice miraggio, se avessi immaginato tutto lì in quel campetto da basket. Le sue mani si poggiarono al mio petto scostandomi quasi a forza. «Che c’è..», la guardai e temetti di sciogliermi, la vidi in difficoltà mentre umettava le labbra rosse a martoriate dai miei baci rendendomi ancora più smanioso. «Non l’ho mai fatto». Lo disse come fosse la vergogna più grande, la sua colpa più nascosta. Le mie labbra tremarono appena prima di sfociare in una risata. Seppellii il viso contro il suo collo provando ad attutire i miei singhiozzi. «Posso sapere cosa diamine c’è da ridere? TOGLITI SUBITO.» «No non rido di te, è solo che..» provò ad allontanarmi tirandomi con forza i capelli, le bloccai i polsi sopra la testa mettendomi a cavalcioni su di lei. «E’ solo che quando stavo in prigione temevo arrivasse qualcuno, e che quel qualcuno ti avrebbe toccata.. e baciata». Mi avvicinai ancora, non si ritrasse e le nostre labbra schiuse combaciarono alla perfezione. «Pensi non l’abbia mai fatto perché mi è mancata l’occasione?» mi fissò con quegli occhi chiari e grandi, mi sentii minuscolo. «Non l’ho mai fatto perché volevo te.» Pensai di dover fuggire, pensai di non poterla rovinare così, di non poterci rovinare così. Eppure non ci riuscii, non con lei a fissarmi in quel modo, non con le sue mani che accarezzavano la mia schiena strappandomi brividi di piacere. Non potevo perché non c’era mai stato qualcosa che avessi desiderato di più, perché i miei occhi avevano sempre visto solo lei. Ricordai Chicago ancora una volta, gli occhi grandi di Shanti così simili ai suoi, mi ero lasciato trascinare in quel vortice per sopperire la sua mancanza; come poteva essere sbagliato quindi? Paragonai il suo corpo nudo a un’opera d’arte, andava oltre le semplici aspettative che una mente marcia come la mia poteva partorire. Il sapore della sua pelle mentre ne leccavo ogni fessura, mentre baciavo ogni centimetro ogni spicchio di quella pelle pallida come la luna alta nel cielo. Le sue mani riuscivano a darmi piacere in modi che non pensavo fossero possibili, era come se sentissi ogni singola cosa attorno a me, come se ogni suo bacio, ogni sfregamento delle nostre pelli valesse cento volte di più. Persino il modo in cui le sue dita si muovevano sulla mia erezione mi mandava ai matti, sentivo la pelle andare a fuoco e continuavo a fissarla dall’alto ammirando le guance che non smisero mai di arrossarsi. Entrai dentro di lei lentamente, sentivo la sua carne resistermi e spingermi quasi fuori. I suoi muscoli irrigiditi mentre l’ennesima spinta più forte delle altre mi portò a farla mia, strappando un grido di dolore a lei e un ansimo di piacere a me. Le sue unghie sulla mia carne, graffiavano la mia schiena, le mie dita suoi suoi fianchi la stringevano possessivamente ne modellavano la pelle quasi fosse creta nelle mie mani mentre mi sussurrava di non fermarmi, di continuare a spingermi dentro di lei ancora più a fondo. Mi sentivo schifosamente eccitato, me ne vergognavo quasi, il modo in cui la desideravo e il non volerla sporcare con i miei pensieri. Leccai il suo collo lascivamente, ne morsi la pelle lasciandole un livido che mi augurai vedesse quanta più gente possibile, la sentii afferrarmi i glutei e stringermi le cosce con forza attorno ai fianchi, le sue urla e i miei gemiti supposi avessero svegliato i vicini. La fissai con occhi socchiusi da sotto il cuscino finché non la vidi sbattere il piede contro la poltrona e imprecare in una lingua a me sconosciuta. Mi sollevai appena grattandomi la guancia, sentendola ispida. «Si può sapere che cazzo fai all’alba?». Si voltò quasi spaventata nel trovarmi sveglio, il che era paradossale visto che avevamo fatto l’amore fino a mezzora prima. «Ho scordato di avere una presentazione all’università, se la manco posso giocarmi la laurea». Tipico di lei fare il melodramma per le stronzate, sorrisi assonnato lasciandomi ricadere sul cuscino, il suo, ne sentii l’odore e la mia mano scattò automaticamente ad afferrarle il polso. Urlò di sorpresa ricadendomi addosso. «Jay, devo andare ok?». La sua risata mi spinse a prenderla poco sul serio mentre le rubavo un bacio infilandole una mano sotto il vestito, la toccai attraverso la stoffa delle mutandine strappandole un gemito di piacere. «Vuoi sul serio lasciarmi qui da solo?». Mi morse le labbra come a punirmi, stringendo le dita sottili sul mio polso quasi a voler fermare quelle carezze sempre più intime. «Non fare il bambino, con me non attacca. Passo da te stasera..». Mi scostai sorridendo ambiguamente. «E’ così quindi? Mi usi per il sesso? Sono scioccato». Mi beccai uno schiaffo sul petto e una risatina. «Ebbene si, fai il tuo dovere stallone». Ammiccò provocante alzandosi e sfuggendo alle mie grinfie, la vidi sparire dopo avermi lanciato un bacio che finsi di afferrare al volo. Adesso solo provai a mettere ordine tra i miei pensieri senza grandi risultati, se me ne pentivo? No. Anche se ammetto che forse avrei dovuto farlo, quanto ci avrei messo a rovinare tutto? Forse quella era la volta buona per cambiare, per smetterla con tutte quelle stronzate.. il telefono squillò e il nome di Safari balzò ai miei occhi. Era la prova del nove? Bastava chiudere la chiamata senza rispondere, morire in quel letto per le crisi d’astinenza e poi risorgere dalle mie stesse ceneri. Dovevo farlo per lei. — Pronto?
***
L’officina deserta mi accolse pochi istanti dopo, non vedevo James da quella famosa notte, un forte rumore attirò la mia attenzione, fissai la chiave in metallo rotolare a terra seguita dall’imprecazione di una voce familiare. «Ehi». Lo vidi sollevare la testa di scatto per fissarmi, reclinò il capo quasi incredulo. «Che cazzo ci fai tu qui?». Mi aspettavo un’accoglienza simile, allargai le braccia sporgendo le labbra in un’espressione costernata. «Non so, chiedere umilmente scusa per l’auto e prometterti che alla prossima corsa vincerò?». I suoi occhi azzurri ebbero un bagliore sinistro. «Pensi sia questo che voglio?». No, lui voleva io stessi bene, come potevo spiegargli di averci provato sul serio? «Va tutto bene James, sul serio..», era la stessa risposta che davo a me stesso ogni volta che stavo per farmi, ironico no? «Bucarti quindi è una specie di nuovo passatempo che non porterà alcuna conseguenza?». Raccolse la chiave inglese e io pensai volesse usarla per spaccarmi la testa. I punti tirarono dolendomi. «Quindi che vuoi fare? Non parlarmi più? Finisce qui insomma, vent’anni d’amicizia ed è stato bello finché è durato». Sorrisi in maniera meschina, sapevo com’era fatto e infatti schivai l’oggetto volante poco prima che mi aprisse in due la faccia. «Sei un fottuto pezzo di merda, sono passati dieci giorni dalla corsa e ti presenti solo ora?» «Ho avuto altre cose da fare, e poi sapevo che mi avresti ucciso se fossi venuto quella notte stessa». Mi fissò con un mezzo sorrisino falso. «Altre cose, tipo? Spero non intenda bucarti in qualche viuzza che odora di merda». Okay, iniziavo a innervosirmi pure io. «Vuoi fare a botte quindi?». Annuii togliendomi il giubbotto che gettai a terra, sollevando le maniche della camicia, non ebbi comunque il tempo di completare perché il bastardo mi si avventò contro a tradimento. «Credo mi si siano aperti due punti», toccai il sopracciglio dolente e sentii già le urla di Alice perforarmi il timpano. «Dovevo aprirti il culo». La sua voce affannata seguì uno sputo, si asciugò il sangue dal labbro passandomi una soda ghiacciata che poggiai alla guancia. «Sto con Alice, credo». Non lo guardai ma ero sicuro più o meno dell’espressione che avesse in quel momento. «Quindi i miracoli accadono? Non pensavo che chiamarla quella notte sarebbe servito», colpii la sua gamba col mio piede senza metterci troppa forza. Avevo i vestiti a brandelli, ero stanco e sudato, le mie forze in quel periodo andavano diminuendo. «Penso sia solo l’ennesima cazzata che faccio.» «Lo è, ammesso tu non decida di cambiare vita. Pensi di poterlo fare per lei?». Bevvi un sorso della soda sentendo la gola bruciare. Potevo farlo? In realtà volevo, lo volevo con tutto me stesso, ma i mostri alle mie spalle continuavano a strattonarmi e tirarmi, continuavano a urlare la notte senza darmi tregua. «Penso dovrei cercare Peter, lui di sicuro non farà a cazzotti con me». Lo fissai in tralice e lo vidi sorridere gratificato quasi come se gli avessi fatto un complimento. «Lo trovi stasera al campetto». Annuii soddisfatto alzandomi e scrollandomi di dosso la polvere. «Inizia a sistemarmi l’auto, alla prossima corsa ti farò rimpiangere tutte le tue calunnie.» «Scommetterò contro di te». Urlò quelle parole poco prima che varcassi la soglia, sollevai il dito medio senza voltarmi sentendo la sua risata accompagnarmi. Ho capito una cosa in mezzo a tutto questo schifo, l’ho capita adesso e in pochissimi giorni. Non hai bisogno di essere un eroinomane, un alcolizzato o un reietto della società per sperimentare L’Estremità. Ti basta semplicemente amare qualcuno.
|
Capitolo 7
*** Big dark secrets. ***
 VIILa palla rotolò nella mia direzione, la bloccai fermandola col piede guardando Peter venirmi incontro e fermarsi a pochi metri da me. Ci fissammo in silenzio senza alcuna intenzione di romperlo in favore di parole vuote, il nostro rapporto era sempre stato parecchio strano, al margine di quella linea sottile che separava l’essere fratelli dall’essere nemici, un equilibrio perenne che non avevamo mai oltrepassato. «Giochi con me?» Mi fissò insistentemente e io sorrisi annuendo, afferrai la palla lanciandogliela e senza alcun fischio d’inizio corremmo lungo quel campetto abbandonato. Mi lasciai cadere sulla panca togliendo la felpa che usai come asciugamano per il sudore, bevvi avidamente l’acqua ghiacciata respirando affannosamente. «Sei migliorato.» Peter si accese una sigaretta senza guardarmi. «No, sei tu a essere peggiorato.» Non avevo bisogno di chiedermi come mai, sapeva sempre come colpirmi e riusciva a farlo maledettamente bene. Chiusi gli occhi senza sapere bene cosa dire, forse perché di parole adatte in realtà non ce ne stavano, ero tornato a farmi come il peggiore dei coglioni e ancora una volta non sapevo come uscirne. «Ho sempre pensato che Alice fosse la medicina per ogni tua malattia, che fosse giusto lasciartela.» Aggrottai la fronte fissandolo come se non capissi dove volesse andare a parare. «Lei mi piaceva, intorno ai diciassette anni.. sai, le cotte da ragazzini. Quando partisti pensai che avrei avuto la mia occasione..» «Sei un pezzo di merda.» Sputai fuori quelle parole con divertimento misto a gelosia, e lui rise di gusto. Era la prima volta che sentivo quel suono uscire dalla sua bocca. «Mi è passata quasi subito, Alice è troppo stupida per essere la donna giusta per me.» Inarcai un sopracciglio guardandolo in tralice, voleva farmi incazzare? «Lei è la persona migliore che conosco.» «Ho detto stupida, non peggiore, infatti.» Umettò le labbra secche aspirando una boccata dalla sigaretta ormai consumata tra le sue dita annerite. «Ti ama ciecamente, e non si rende conto che quando vedrà affondarti del tutto.. morirà.» Restai in silenzio sentendo un nodo alla gola stringersi sempre più forte, impedendomi quasi di respirare. «Le donne sono tutte convinte di essere ‘’la soluzione’’ per gli uomini che amano, di essere quelle ‘’speciali’’ anche per il peggior reietto della società.. e quando prendono consapevolezza dell’errore, è troppo tardi. Lo ha fatto tua madre, lo ha fatto anche la mia..» «Parlare con te è sempre..» non riuscivo a trovare un aggettivo adatto per esprimere lo squassante dolore che quelle parole mi causavano. Flettei le dita contenendo la rabbia, le mie vene si ingrossarono illuminate dai fari del campetto. «Se ho torto puoi sempre dirmelo.» mi fissò con sfida e io capii. Voleva avere torto, lo desiderava ardentemente, voleva gli dicessi che Alice era davvero speciale, che lei mi avrebbe curato, che sarebbe stata il salvagente per me povero naufrago alla deriva. Ma non ci riuscii. E questo che voleva significare? «Sai, non credo il problema sia Alice.. lei è davvero speciale, è perfetta. Il problema sono io..» «Sei disposto a cambiare per amore? Perché se non lo sei, dovresti lasciarla andare, lasciala vivere con quel dottore, lasciala vivere in serenità e circondata da un amore non cancerogeno.» Quell’idea per me era semplicemente inconcepibile, pensare di vederla con un altro, di vederle crescere i figli di un altro uomo, il solo pensiero mi mandava al manicomio. «Il giorno in cui sarai in grado di lasciarla andare, senza il tuo fottuto egoismo, allora sarà il giorno in cui l’amerai di più.» Si alzò afferrando la sua felpa madida di sudore, muovendo qualche passo lontano da me. «Non posso lasciarla andare.. come non posso lasciare andare voi. Ci ho provato, quell’anno a Chicago.. sono tornato in ginocchio strisciando per un perdono che non sono sicuro di aver mai ricevuto.» «Si perdona sempre qualcuno che ami e che hai pugnalato.» La sua voce sembrò perdersi nella brezza serale, aggrottai la fronte senza capire fissando la sua schiena rigida che continuava ad allontanarsi da me. «Che cazzo vuoi dire?» Non mi rispose alzando il braccio in segno di saluto, mi sembrò come se la sue spalle si fossero di colpo ingobbite, e i suoi passi strascicati a causa di quel peso mentre restavo lì da solo a chiedermi cosa avrei fatto della mia vita. ( ALICE )
I miei piedi sembravano non toccare il pavimento quasi volassero, avrei voluto dar la colpa alla mia iperattività cronica ma sapevo che in realtà era tutto merito di Jay. Non ero ancora riuscita a riordinare il flusso dei miei pensieri, a mettere ordine tra le cose successe nel giro di 24 ore. L’unica cosa che ero riuscita a fare era stata ignorare Matthew che cercava in ogni modo di intercettarmi, sapevo di essere una codarda ma non sapevo come affrontarlo, cosa dirgli o come giustificare il mio repentino cambio d’atteggiamento. Non l’avevo mai amato, e non pensavo si aspettasse questo, ma consentirgli di avvicinarsi era stato probabilmente un errore a cui non sapevo come rimediare. Nella mia vita non avevo mai voluto ferire nessuno, anzi era tra le cose che detestavo di più quella. Mi ero sempre mantenuta in equilibrio passando in punta di piedi tra la gente che mi amava e che amavo, cercando sempre con riserbo di non ferire. Ogni anima era simile a un vaso di cristallo per me, non potevo sopportare di vederli linearsi o frantumarsi per causa mia, e seppur Matthew era una conoscenza di ‘’poco conto’’ rispetto ad altre, non riuscivo comunque ad affrontarlo. Mi sedetti su una barella del pronto soccorso pensando a Jay, lui era il vaso più bello e anche il più distrutto. Come un’opera di inestimabile valore calpestata e abusata che non puoi fare a meno di amare e volere; le mie dita strinsero il bordo soffice del materasso, andai a ritroso con la mente a quella notte che ci aveva visti finalmente uniti e avvinti come fossimo un solo corpo. Una sola anima. Io credevo nel destino, lo avevo sempre fatto. Non era stata una coincidenza per noi incontrarci, quando i nostro occhi si erano incrociati per la prima volta io avevo sentito quella scossa che all’epoca non capii, le mie viscere che si attorcigliavano mentre provavo a farmi notare da quel ragazzino distrutto dentro. Chinai il capo e una lacrima solcò la mia guancia cadendo nel vuoto, fissai la piccola macchiolina umida sui miei jeans. Non v’era niente al mondo che desiderassi più di lui, ma soprattutto desideravo aiutarlo, curare le sue ferite, era un concetto troppo utopico? Troppo romantico? Da classica ragazzina alle prese col primo amore forse? Ma come potevo pensare di aiutarlo, quando sapevo quale profondo segreto gli celassi ormai da anni? Sarebbe stato in grado di capirmi, di perdonarmi? Di ascoltare le mie ragioni, le mie motivazioni? «Ehi..» la voce familiare di Matthew interruppe il flusso doloroso dei miei pensieri, lo fissai a occhi sbarrati senza sapere cosa dire. «E’ da ieri che ti cerco senza sosta, dove sei finita?» Allungò una mano per toccarmi, mi scostai saltando giù dalla barella afferrando il mio libro di anatomia. «Mi dispiace, ho avuto molto da fare..» si, moltissimo, a letto con Jay. Perché era così difficile affrontare e deludere la gente, per me? «Stasera proiettano un vecchio film al cinema, vuoi venire?» «Senti Matthew.. è un momento difficile questo, penso che dovremmo smettere di vederci..» mi fissai le scarpe racimolando il coraggio a quattro mani, e capii di aver dentro un valore che forse non pensavo di avere. «Difficile?» «No. Non è difficile.. è solo che sono innamorata di un’altra persona.» Stavolta lo guardai e vidi la delusione nei suoi occhi scuri, mi dispiaceva ma non provavo alcun senso di colpa. Perché dovevo vergognarmi di un amore che avevo inseguito così a lungo e che finalmente ero riuscita ad afferrare? ***
Fissai lo spezzatino totalmente bruciato imprecando mentalmente dentro me stessa, avevo invitato Jay a casa mia e avrei voluto cucinare per lui ma come sempre la mia incapacità mi metteva in difficoltà. Non che fossi totalmente una frana nella cucina, ma tendevo un tantino a sopravvalutarmi pensando che sarei riuscita in imprese titaniche come mia madre. Lei si che cucinava divinamente, quando Jay assaggiava i suoi piatti era un continuo sorridere e complimentarsi. «Che diamine è questo fumo?» Mi voltai spaventata fissando il soggetto dei miei pensieri oscurare lo spazio dell’arco che portava dalla cucina al soggiorno a bocca spalancata. «Come cavolo sei entrato?» Guardai oltre lui cercando la porta ma il suo sorrisino mi destabilizzò un po’. «Solo una scema come te poteva usare come codice di riserva la mia data di nascita.» Incrociò le braccia al petto e io mi sentii avvampare, ero stata molto indecisa su quello dovevo ammetterlo. Ma una sera ubriaca avevo finito per dormire sullo zerbino perché perse le chiavi continuavo a inserire il codice sbagliato, e solo la mattina successiva mi ero resa conto di aver digitato per tutta la notte la sua data di nascita. Lo guardai avvicinarsi, pensavo stesse per baciarmi ma il suo viso mi oltrepassò per fissare la pentola annerita. «Non guardare.» Provai a strattonarlo ma non lo smossi di un millimetro. «Perché no? Sembra buono..» mi bloccai a fissarlo sgomenta, mi prendeva in giro? Come se non avesse notato il mio sguardo scrollò le spalle iniziando a prendere i piatti per cenare, poggiandoli sulla tavola. Guardai lo spezzatino dentro al mio piatto con disgusto spostando infine gli occhi sulla sua figura, afferrò la forchetta portandone un pezzo alle labbra. Trattenni il respiro mentre masticava e infine mandava giù senza alcuna espressione. «Vedi? E’ buono.» Continuò a mangiare accanto a me e alla fine mi forzai a prenderne un pezzo e portarlo alle labbra, quando il sapore colpì le mie papille gustative desiderai morire: era disgustoso. Tornai a guardare Jay che mangiava di gusto e iniziai a piangere. «Sei un bugiardo.» Mi coprii il viso con le mani e lo sentii ridere e afferrarmi per i fianchi costringendomi a sedermi sulle sue cosce. «Ma dai, è buono comunque perché l’hai preparato tu.» Mi tolse le mani dal viso baciandomi la guancia umida e salata, leccandosi poi le labbra. «Questo è ancora più buono.» Gli diedi una gomitata scherzosa ma una punta di ansia mi colpì improvvisamente: era così bravo a mentire il mio Jay. Così tanto bravo.. come me. ( JAY )
Le dissi che mi piaceva fare l’amore al buio, che le forme del suo corpo erano ancora più armoniche alla luce della luna, e lei mi credette. Lo faceva sempre in fondo, no? La realtà era ben più misera, al buio i suoi occhi medici non avrebbero visto i lividi sulle mie braccia. Dovevo tornare a bucarmi sui piedi? Quel pensiero mi nauseò, questo mio essere perennemente calcolatore indicava la mia incrollabile natura di bugiardo. Aveva ragione Peter quindi? Dovevo lasciarla andare, e dimostrare così quanto la amavo visto che non riuscivo a farlo in altro modo? Magari con una vita migliore, magari smettendo con quella merda, mettendo la testa a posto, trovandomi un lavoro vero e dandole delle certezze, stabilità. Mi voltai a fissarla, il suo respiro regolare, mi avvicinai respirandola fino a restare senza fiato, era ossigeno puro che mandava in pappa il mio cervello e che allo stesso tempo sembrava tenermi in vita. Ma per quanto ancora? Mi avrebbero trovato in un angolo, con la siringa ancora nel braccio, morto. Quando sarebbe accaduto avrebbe pianto? Si che lo avrebbe fatto, ma la cosa più dolorosa era sapere che non avrebbe maledetto neppure un momento passato insieme a me, che avrebbe comunque rifatto tutto d’accapo. Mi alzai da quel letto come se avessi delle molle, vomitando nel bagno con la porta ben chiusa per paura che mi sentisse. Mi poggiai alle piastrelle coprendo gli occhi con le mani tremanti, ero come un cane rabbioso che continuava a mordersi la coda. Non riuscivo neppure a fare qualcosa per la donna che amavo, per quella ragazza così buona che mi adorava senza remore e senza chiedere mai nulla in cambio. «Più forte Jay, più in alto!» Muoveva le gambe nude con forza, su quell’altalena scalcinata, sembrava volesse toccare il cielo quel giorno.
«Mi stanno per cadere le braccia Alice, se spingo più forte me le spezzerò seriamente.» La sua risata mi coinvolse, mi fissò coi suoi occhi luminosi e chiari. «Ti curerei io in quel caso, sai.. voglio diventare medico e aiutare le persone come te. Anzi non le persone, ma te.» Inarcai un sopracciglio smettendo di spingere, l’altalena lentamente si fermò e io mi piazzai di fronte a lei inginocchiandomi. «Ma io non sono malato..» mi carezzò i capelli, aveva quattordici anni. «Si che lo sei, solo che non riesci a vederlo..» Mi ridestai di colpo sbattendo le palpebre, la luce del sole mi accecò, la sagoma nuda accanto a me adesso mi abbracciava forte continuando a dormire. Non capivo perché avessi fatto quel sogno, perché avessi ricordato proprio quel momento.. o forse si. Forse sapevo bene il perché, semplicemente non volevo ammetterlo. Alice aprì lentamente gli occhi e il suo sorriso provocò una scarica elettrica sul mio petto, il mio cuore sembrava voler esplodere. «Odio quando mi fissi in questo modo.. sembri rimuginare su tutta la tua vita.» Mi accarezzò la guancia, le afferrai il polso baciandole il palmo della mano profondamente. «Pensa positivo, non c’è un ricordo in cui tu non ci sei..» l’attirai contro di me per non farle vedere i miei occhi bugiardi, ve n’erano molti di ricordi in cui la sua presenza non mi aveva illuminato e condotto sul cammino corretto. «Uhm, e sentiamo qual è il tuo preferito?» Sorrisi sornione beccandomi un pizzicotto. «Non dire la nostra prima volta, saresti degradante.» «Ma perché scusa? Sei stata una vergine molto esperta..» fermai la sua mano prima che mi colpisse, ridendo a crepapelle. «Ma sei uno stronzo, lo sai? Allora vuoi sapere il mio?» Mi fissò attentamente, era come se mi stesse traendo in trappola. «Si.» «Quando ti ho visto uscire dai cancelli della prigione, un uomo nuovo per una vita nuova.» Restai in silenzio frenando la voglia di allontanarmi da lei, provando a modulare il mio respiro. «Vuoi sapere il mio?» «No, non voglio.» La sua risposta mi spiazzo, reclinai il capo con sguardo interrogativo. «Non voglio, perché so che il tuo ricordo non mi piacerebbe.. hai sempre avuto un pessimo gusto nello scegliere i momenti insieme.» «Questo perché non ne getterei via nemmeno uno..» «Ne sei sicuro?» Sbattei le palpebre e la sua immagine sembrò svanire per un secondo, rovistai nella mia memoria scuotendo il capo. «Non ne getterei via nessuno.» «Anche se quel ricordo non esiste ancora?» Non ebbi l’agio di risponderle mi baciò impetuosamente, e sotto le lenzuola dimenticai persino il mio fottuto nome. ***
«Pensi di riuscire a correre oggi?» Era la trentesima volta che me lo domandava, ed era la trentesima volta che annuivo esasperato. «Non commetterò alcun errore stavolta..» stavo per dire loro ‘’fidatevi di me’’ ma sapevo quanto sarebbe suonato ridicolo, ed evitai. «Pensiamo positivo quasi nessuno ha scommesso su di lui stavolta, in giro si è sparsa la voce che ha perso il suo ‘’tocco magico’’.» La voce di Peter era al solito monocorde ma pregna di sarcasmo mentre apriva una lattina di birra sorseggiandola soddisfatto. Storsi le labbra in una smorfia carica di disprezzo, non avevo perso un cazzo, ero ancora quello di prima e quella notte lo avrei dimostrato. «Dovremmo invitare anche Alice stavolta?» Al suono di quel nome la mia attenzione si fece immediatamente pressante, guardai James curvando le labbra all’insù. «Cosa stai pensando di dimostrare?» «Ti caghi in mano di quello scricciolo, magari eviterai di presentarti mezzo morto come l’ultima volta.» Provai a colpirlo con un calcio ma lo schivò abilmente mentre Peter beveva in silenzio. «Invitala pure, non ho alcun problema.» Non era vero, ne avevo molti più di quanti potessero pensare o contare, ma il mio orgoglio aveva parlato come al solito per me. Avevo come l’impressione che quella sera vi fossero più persone dell’altra volta, aspettavano tutte il mio fracasso? Era divertente vedere come un singolo errore oscurasse i cento successi precedenti, era così anche con le buone azioni in fondo. Una singola buona azione non riusciva a curare le cento sbagliate, ma l’unica azione sbagliata riusciva a contaminare le cento giuste. Era fatto così l’essere umano in fondo, ero così anch’io quindi? Accucciato vicino il muretto fissavo l’auto con la quale avrei corso fumando l’ultima sigaretta prima dell’inizio, Alice mi venne vicino restando in piedi con le mani dietro la schiena. «Un rispettabile dottorino non dovrebbe venire in posti come questi, non lo sai?» Mi guardò in tralice annuendo con finta accondiscendenza. «Il rispettabile dottorino sta col peggiore elemento della città, questo la rende un po’ meno rispettabile?» I miei occhi percorsero la sua figura a partire dalle caviglie nude appena sotto i jeans che fasciavano abilmente le sue cosce perfette, finendo con una camicetta che stringeva appena il punto vita sottile e il seno alto e non eccessivo. «Questo la rende assolutamente una ragazzaccia, la peggiore.» Gettai la cicca con una schicchera precisa, alzandomi e togliendo la polvere dai pantaloni della tuta strappandole poi un bacio a tradimento. «Resta vicino a James, non voglio che ti allontani per nessun motivo.» Le afferrai il mento con due dita stringendolo con eccessiva forza, come a volerle imprimere quel comando senza possibile via di fuga. Provò a divincolarsi ma non glielo permisi, mi fissò con gli occhi lucidi di chi provava dolore ma non voleva darlo a vedere e alla fine annuì. «Brava ragazza..» sorrisi allontanandomi da lei per salire sulla vettura, non fissai nessuno ero solo io e la strada. Una ragazza si mise di fronte a noi, era vestita in maniera troppo appariscente e v’era stato un momento della mia vita in cui quello era il prototipo di donna che avevo collezionato, un album senza fine che avevo ormai relegato in fondo a un cassetto della mia mente. Le labbra scarlatte si poggiarono al fischietto, tutto tacque finché non sentii il fischio d’inizio e partii senza più alcuna remora. La strada era parzialmente buia, il limitare della vista poteva essere una pesante difficoltà, ma io non mi fermavo di fronte a niente e nessuno; ancora una volta percepii quella sensazione di legame tra me e le auto, qualcosa che non sapevo spiegare come se fossi nato con quel ‘’dono’’. Aumentai la marcia e il tachimetro schizzò in alto e lì restò per tutta la durata della corsa, senza decelerare neppure nelle curve. Stracciai tutti, vinsi a mani basse arrivando con uno scarto di un minuto buono, e quando scesi tra la polvere e il boato mi accolse io riuscivo solo a guardare Alice, James e Peter che mi fissavano da lontano, la prima con occhi terrorizzati e gli altri due con uno sguardo indefinito. Sorrisi sghembo prima che la folla mi accerchiasse e inghiottisse. ( ALICE )
Temevo di aver perso battiti vitali del mio cuore mentre fissavo quelle auto correre come forsennate, o possedute da una qualche sorta di demonio. Il denaro in fondo era una sottospecie di demone, no? Il pensiero che lui fosse lì dentro, e rischiasse di schiantarsi, rendeva le mie ginocchia molli come gelatina. Unii le mani come se pregassi mentre i miei occhi spaventati fissavano una per una le auto che compievano giri regolari. «Vincerà lui.» La voce di Peter mi fece quasi sobbalzare, lo guardai annuendo, eravamo amici da così tanti anni. Lo avevo visto praticamente crescere, così come per James. «Stavolta si..» mi fissò incuriosito, come se le mie parole nascondessero chissà quale significato. «Che hai, Alice?» «Nulla, penso semplicemente a quando smetteremo di mentirci a vicenda..» ero sicura che Jay avesse fatto nuovamente qualcosa di sbagliato, ero un medico e me ne sarei accorta con un qualsiasi estraneo figuriamoci con qualcuno che amavo. Semplicemente non volevo accettarlo. «Perché non inizi tu a dare il buon esempio?» Le sue parole furono simili a uno schiaffo, lo guardai sentendo le labbra tremare dalla voglia di piangere. «So che forse per te è incredibile o assurdo, ma a volte nella vita vogliamo proteggere qualcosa con tutte le nostre forze.» Sembrò spiazzato dal mio tono rude e terrorizzato al tempo stesso. «E tu cosa proteggi, Alice? Te o lui?» |
Capitolo 8
*** This lack of self-control I fear is never ending ***
 ‘’E tu cosa proteggi, te o lui?’’, continuavo a rimuginare su quelle parole mentre percorrevo i corridoi dell’ospedale con sguardo assente. Di recente la mia mente non sembrava volermi dare tregua, pensavo la mia condanna più grande fosse da sempre quella coscienza autonoma che mi soffocava da tutta una vita. Secondo Jay la mia onestà d’animo invece era il mio più grande pregio, era ciò che mi aveva condotto lì dove stavo adesso. Una barella sfrecciò accanto a me, venni richiamata a gran voce correndo dietro l’equipe medica che ormai era diventata la mia seconda famiglia.
«Cosa succede?» Alexander mi guardò distrattamente. «Donna bianca, incidente stradale, possibile emorragia interna.» Fissai il corpo insanguinato e trasfigurato dalle ferite, non riuscivo neppure a distinguerne i lineamenti. Tempo prima James mi aveva chiesto come riuscissi a restare lucida di fronte a quelle tragedie che ogni giorno mi si paravano davanti, in quel frangente mi ero limitata a sorridergli criptica. Non gli avevo detto quanto quelle mostruosità mi lineassero dentro ogni giorno di più, empatizzavo il dolore altrui sentendomi spesso e volentieri impotente eppure dovendo pensare a una vita intera senza quel tipo di contatto umano mi sentivo totalmente persa. Avevo bisogno di quel lavoro, avevo bisogno delle mani che si aggrappavano a me, della loro sofferenza che tentavo di curare in ogni modo possibile. Due ore dopo gettai i guanti e la mascherina uscendo dalla sala operatoria, la donna era salva e il marito in sala d’attesa scoppiò a piangere farfugliando ringraziamenti, accarezzai il suo braccio lasciandolo solo con il proprio sollievo tornando a perdermi dentro me stessa. Il pensiero di Jay non riusciva ad allontanarsi da me, il mio sesto senso continuava a far scattare campanelli d’allarme che mi rendevano irrequieta. Come potevo affrontarlo? Piazzarmi di fronte a lui e chiedergli se fosse ricaduto nelle vecchie e letali abitudini? Come avrebbe reagito? Ricordavo anni prima la sua aggressività, i suoi occhi iniettati di sangue, le labbra secche e tremanti. Mi accasciai al muro coprendo il viso con le mani, non volevo vedere né sentire nulla. Come potevo pensare di essere sincera sapendo di distruggere anche l’ultimo brandello sano che gli fosse rimasto? BUGIARDA. La voce di Peter mi schiaffeggiò con violenza. ‘’Non vuoi dire la verità per egoismo, hai paura di perdere l’ultimo brandello sano che rimane di voi, non di lui’’, strinsi i denti cercando di non piangere mentre quella voce lenta si spegneva lasciando solo echi e mormorii. Qualcuno tirò il mio camice con insistenza, abbassai lo sguardo fissando la bambina bionda che mi sorrideva, la mia espressione cambiò mentre mi accucciavo di fianco a lei. «Qualcuno qui ha perso un altro dente, per caso?» Aveva i capelli morbidi e setosi, il suo odore mi ricordava il mio da bambina. Faith era il suo nome, la madre era stata ricoverata ormai settimane prima a causa del cancro, e il marito si divideva tra lavoro e figlia in maniera stoica. «Sei triste?» I bambini capivano sempre tutto, non era questo ad aver trasformato Jay? Ancora lui, sempre lui. Scossi il capo arricciando il naso in un’espressione buffa e Faith sembrò illuminarsi. «Allora vieni con me da mamma?» Sospirai dandole la mano, era ormai un rito quello di tenerle compagnia mentre vegliava la madre, a volte avevo come l’impressione che lo facesse per il timore di vederla spirare davanti a lei. Il timore che succedesse quando nessuno le era vicino. «Come sta la mia paziente preferita?» Entrai in camera notando la presenza del marito accanto a essa, sorrisi osservando il loro incrollabile amore, era bello da vedere. Mi dava speranza. «Faith è venuta di nuovo a disturbarla?» Scoppiammo a ridere guardando la monella che tentava di nascondersi dietro il mio camice, i miei occhi senza volerlo incontrarono quelli dell’uomo e per la prima volta vi lessi tutta la sua fragilità e paura. «Guarda cosa ho regalato a papà.» Mi riscossi a quelle parole fissando il punto da lei indicato, notando l’orologio al polso dell’uomo, dentro il quadrante dei buffi pupazzi colorati. Risi di cuore involontariamente mettendolo in imbarazzo, eppure la fierezza di portare quel dono era stampata sul suo viso. «Mi dica la verità dottoressa, mia moglie ce la farà?» In corridoio nessuno faceva caso a noi due, mi poggiai a ridosso del muro incrociando le braccia al petto. Quella era sicuramente la domanda da un milione di dollari, e mi veniva posta mediamente due volte al giorno. Una era sempre la sua. «Il dottor Cruz sta facendo il possibile, non lasceremo nulla di intentato posso assicurarglielo.» E la mia risposta puntualmente la stessa mentre lo guardavo stringere le spalle e divenire quasi più piccolo della sua stazza. Il cancro agiva in maniera aggressiva, e la donna rispondeva male alle terapie, ma senza quelle la possibilità di operarla diveniva sempre più lontana. Sarebbe sopravvissuta? «Il nome di sua figlia..» mi guardò come se non capisse e io sorrisi. «Ha chiamato sua figlia ‘’fede’’, è ciò che deve avere adesso.» I suoi occhi divennero lucidi mentre annuiva tirando su col naso. Guardai l’orologio al suo polso con un senso di malinconia prima che il cellulare non vibrasse nella mia tasca, guardai il numero sentendo le mie guance colorarsi e il cuore battere più veloce. ( JAY )
|