Cara Samina
(/viewuser.php?uid=527381)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Dove eravamo rimasti ***
Capitolo 2: *** Nel nome che non posso pronunciare ***
Capitolo 3: *** Non pensavo che un uomo e una donna soli... ***
Capitolo 4: *** Io, te e le mie Ultracreature ***
Capitolo 5: *** Al varco ***
Capitolo 1
*** Dove eravamo rimasti ***
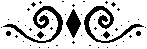 Io sono il boss del Team Skull e non ho paura di niente...
Eppure, quella donna... quella donna mi fa paura! C a p i t o l o 1 : D o v e e r a v a m o r i m a s t i
«Sono salita fin qui perché ero preoccupata per voi e cosa trovo? Il Pokémon leggendario!».
Hapi è appena giunta insieme a Mudsdale sulla cima dell’Altare Lunare. Con un rapido scatto la ragazza salta giù dalla groppa del cavallo per poter andare incontro agli altri due. La biondina in particolare sembra molto scossa, ma ciò non tange affatto Guzman in alcun modo al momento, e neppure lo sfiora minimamente il più misero briciolo d’apprensione per la salute dei marmocchi. Se ne sta fermo e imbambolato con una paura sottile nel cuore – la sente pulsare con forza ad ogni singolo battito – mentre si sofferma con sguardo assente sulla figura grande e celestiale di Lunala che li ha appena tratti in salvo da quel buco di buio e di inferno. Dunque è stato per questo che ha lottato tutto quel tempo, sta pensando. Di certo non avrebbe mai detto che dentro quella fastidiosissima palletta fluttuante e stridula si celasse un Pokémon tanto forte, in grado di evocare il portale per l’Ultramondo. Era stato scettico fino all’ultimo momento, nonostante gli ordini impartiti. Beh, com’è che si dice in questi casi? La corazza non fa il Pokémon... o una cosa del genere. Sì, ecco, comunque chi se ne importa. All’improvviso sente un brivido viscido lungo la schiena: la testa gira, è di nuovo in balia di quelle assurde visioni, i Nihilego lo accerchiano, lui prova a rincorrerli ed essi, parassiti, allungano i tentacoli nel tentativo di sfiorarlo e poi lo toccano e lo vincono, uno di loro lo stringe e la sua pelle è vetro, è ghiaccio, così Guzman si guarda, in qualche modo si guarda senza vedersi perché è tutto buio e il suo corpo non risponde all’impulso di fuggire, non risponde, non risponde, e in una maniera terribile trema senza muoversi. Manca l’aria. C’è qualcosa nel cervello che punge, un dolore terrificante. E intanto gli pare di addormentarsi. Poi di colpo un taglio, un grido di spasimo risuona violento dalla sua bocca, si sente cadere. Accasciato a terra ansima come un dannato, il corpo ancora pesante tentenna, prova appena a socchiudere gli occhi. «Golisopod... Cazzo, amico, vattene... Quelli ti sbriciolano...» cerca di dire, ma la sua voce è rotta, un mugolio senza senso. Poi sono arrivati Sun e la figlia di Samina. Non ricorda, o meglio sa, ma non vuole ricordare quello che è successo nel frattempo, dopo che il Pokémon Blindato l’ha protetto e portato in un luogo sicuro e lui è rimasto per tanto tempo rannicchiato da una parte a cercare di riprendersi, di ritrovare il controllo di sé, a rendersi conto del fatto che, anche solo per pochi secondi, Guzman non era più stato Guzman. Proprio in quel momento, Lunala china la testa e incontra il suo sguardo smarrito. In qualche modo, esso pare percepire tutto quello che sta scorrendo un’altra volta davanti ai suoi occhi. Guzman, a quel punto, pensa di essergli immensamente grato e che però non saprebbe come ringraziarlo. Forse, riflette un po’ distrattamente, potrebbe cominciare con il chiedergli scusa per come i suoi l’hanno maltrattato per catturarlo. Ah, sciocchezze: il grande Guzman non si scusa mai, e non basterà neppure un Pokémon delle leggende a fargli cambiare idea! E nonostante questo, Lunala – o piuttosto Nebulino? – sorride ancora. «Per non parlare di quel bislacco buco nel cielo… Comunque, sono contenta che siate sani e salvi! Ehi, spilungone! Occupati della signora! È piuttosto pallida, ma non sembra ferita». «Eh? Ah! S-sì, certo... subito!». Soltanto allora Guzman si ridesta dai propri pensieri, e soltanto allora si accorge del corpo sottile e fragile di Samina steso sulla pietra. Gli scappa un’imprecazione che si affretta subito a mascherare alle orecchie dei bambini, poi si china accanto a lei, la guarda, la rivolta in modo che le sia più semplice respirare, passa una mano sul suo viso a scostarle via i capelli e poi la guarda di nuovo. Sospira amaramente. «Ma guardati, come ti sei ridotta», dice sottovoce, come se non gli bastasse fissare lui solo quella pelle bianca e livida, rimarcando ancora l’unica azione che in quel momento è in grado di compiere. La prende tra le braccia e la solleva, Samina è una piuma, la stringe un poco al petto come se avesse paura che da un momento all’altro possa sfuggirle via per il più piccolo sbuffo di vento. Il Mudsdale di Hapi si avvicina, con un cenno del muso gli indica la sella. «Ah. Grazie, amico», mormora appena, poi immediatamente la sua attenzione si sposta ancora e unicamente su Samina. La adagia con delicatezza sulla groppa, poi monta anche lui e torna a cingerla piano, lasciando che la sua testa possa poggiare contro l’incavo fra il collo e la spalla. Ogni volta che il suo respiro si allunga sullo scollo della canotta, Guzman riesce a percepire un po’ del suo profumo avvolgerlo qualche istante. La accarezza con esitazione sulle braccia, perché è così fredda, come quelle Ultracreature, e la culla, una bambina. È imbarazzante quanto in quel frangente paia per davvero una bambina, troppo bella ed esile. Guzman ricorda perfettamente l’incauto errore che ha commesso la prima volta in cui si sono rivolti la parola. Era successo in una delle rare notti in cui il cielo a Poh decide di offrire una tregua, così che una volta tanto oltre le nuvole si possano vedere le stelle. Lui si era appena acceso una sigaretta, poggiato contro le mura al di fuori della città, che non voleva dare il cattivo esempio agli altri riuniti nella villa, e con lo sguardo puntato in alto le stava osservando in silenzio, ripensando alla sua misera vita di Capitano fallito e alla rivalità passata con quel belloccio di Kukui, che al contrario nel frattempo era riuscito ad approdare a un porto stabile e sicuro e si era persino da poco sposato con una donna, doveva ammetterlo, proprio niente male. Ma poi un ghigno aveva brillato malignamente su quel suo brutto muso, perché presto il Team Skull avrebbe piegato in due l’intera Alola sotto la sua forza e a quel punto Guzman avrebbe avuto modo di riscattarsi di ogni affronto subito nel corso degli anni. Finalmente la gente avrebbe riconosciuto la sua vera potenza, e l’avrebbe temuto e odiato come era giusto che fosse per l’uomo invincibile che era: la distruzione fatta persona. «Signor Guzman». Nel sentirsi chiamare, aveva girato un poco la testa. Allora, con la coda dell’occhio e la vista annebbiata dal fumo, aveva scoperto questa ragazza meravigliosa, fin troppo carina e composta per un posto come quello in cui erano. «Yo». No, decisamente non era di lì: quello sguardo perplesso era stato anche troppo evidente. Dopo un paio di tiri alla sigaretta, le aveva sorriso. «Di’ un po’, non ti sarai mica persa?». «Come?». «A me non me ne frega niente, ma non mi sorprenderebbe affatto se per caso qualcun altro qui intorno provasse a rubarti quel brillocco là che hai addosso. Io ti ho avvisata. È pericoloso, quaggiù». «Ah, lei intende questo?» aveva detto portandosi le mani al petto ad accarezzare la pietra ricamata sopra l’abito bianco «Che facciano pure, posso permettermene tanti altri. Ma lei non dovrebbe sottovalutare in questo modo le mie capacità. Perché io, al contrario, ho molto a cuore le sue». «Ma davvero?». Ah! Se soltanto non avesse avuto l’ardire di usare quel tono ironico... D’improvviso era sembrato come se ella avesse perduto la pazienza. Con due rapidi passi l’aveva raggiunto, i loro corpi si erano scontrati con forza e Guzman si era ritrovato con le spalle al muro. Allungando le dita sul suo viso la ragazza gli aveva sfilato via la sigaretta dalle labbra e una volta gettatala a terra l’aveva pestata sotto il tacco della scarpa con impeto quasi furente. Egli aveva appena fatto in tempo a scorgere la boccuccia contratta e il sopracciglio sottile piegato sopra l’unico occhio scoperto dalla frangia, che lui stesso aveva perso le staffe, perché fin troppe gliene erano capitate che lo vezzeggiassero così, come scaltre piccole Purrloin, dissimulando con dolci parole l’età che candidamente non dicevano di avere. «Oh, ma che diavolo vuoi?!» aveva esclamato, fuori di sé «Senti, pischella, io lo so che di uomini belli e forti come il grande Guzman non se ne trovano neppure dovessi setacciare tutta quanta Alola, ma faresti meglio a cercarti qualcun altro più giovane, perché io per te sono troppo vecchio! E comunque, mettiti in testa che non voglio problemi con le minorenni, chiaro?». Avrebbe continuato ancora con un altro paio di appunti, ma la risata di lei lo aveva interrotto, e lui si era bloccato ad ascoltarla, tanto era armoniosa e aggraziata. Non si era opposto, stavolta, quando per zittirlo gli aveva posato l’indice e il medio sopra le labbra. «Come sei buffo...» aveva sussurrato, visibilmente divertita, ma con fare gentile, come una madre che rimbeccasse il proprio pargolo «Io ho più di quarant’anni, sai?». ...Guzman!!! Che diamine combini?! Di fronte a quella rivelazione, per qualche secondo era rimasto basito. Assurdo! Quasi si era pentito di averle gridato in faccia così. Dopo l’imbarazzo iniziale, però, lentamente aveva cominciato ad affiorare un sentimento che forse non aveva mai conosciuto con la stessa intensità con cui lo stava provando in quel momento. Aveva riflettuto un’altra volta sulle parole che gli aveva rivolto e quando aveva riportato alla mente la serietà con cui aveva confessato di avere a cuore le sue capacità, per un attimo aveva sentito come una sorta di commozione: perché quelle non erano, come aveva creduto, le solite ottuse adulazioni delle ragazzine che gli correvano dietro nella speranza di ottenere almeno un bacio, che lui si rifiutava sempre di concedere. Certo, avrebbe avuto ragione di dubitare di quell’età che aveva appena dichiarato con tanta fermezza e, avrebbe azzardato, anche sottile compiacimento, poiché era fin troppo avanzata per un viso e un corpo come quelli che aveva davanti. Eppure, guardandola meglio, ad un tratto aveva avuto la certezza che si trattava della verità, o almeno che ciò poteva essere plausibile. I suoi occhi si erano fatti grandi nel riconoscerla, perché mai gli era balenato in mente il pensiero di quella donna: uno spettro di cui sapeva l’esistenza, ma di cui aveva sempre fatto finta di nulla. ...Però, accidenti, le avrebbe dato veramente sedici o diciassette anni! Al massimo venti, forse, ma non di più – e nel caso non ci sarebbe stato comunque. Questa avrebbe proprio dovuto raccontarla a Plumeria: già si stava immaginando lei e tutte le altre farfalline del Team Skull pronte a sfruttarlo per carpire il suo segreto di bellezza – ecco, no, allora magari non avrebbe dovuto farlo. Vedendo che si era calmato, la ragazza, o meglio, la donna, aveva allontanato le dita dalla sua bocca, facendo scorrere la mano lungo la guancia, una carezza, affinché potesse trattenere il suo viso di fronte al proprio ed essere certa della sua attenzione. «Beh. Te li tieni bene», era stato tutto quello che Guzman era riuscito a dire. «Adesso, vuoi starmi a sentire?» aveva domandato allora lei con delicatezza. «Aspetta, prima c’è ancora una cosa che vorrei chiederti. Tu sei la madre di quella piccola pulce di Iridio, non è così?». Non appena aveva pronunciato quel nome, l’espressione di lei era mutata terribilmente. Guzman aveva temuto che l’avrebbe aggredito un’altra volta, ma poi aveva notato che ella si stava trattenendo. Con uno scatto contenuto di rabbia, infatti, si era tirata indietro a poggiarsi con la schiena al muro accanto a lui. «Quell’ingrato... Sì, è mio figlio. Sono passati due anni da quando se n’è andato. Prima gli offro tutto il mio amore e poi, come se niente fosse, se ne va via rubandomi ciò che ho di più prezioso». «Ah, io non sopporto chi non ha rispetto dei propri genitori. Però, sai, tutti i ragazzini scappano di casa. È un’esperienza che tocca fare, una volta nella vita». «Certo. Se solo non si fossero decisi a farlo entrambi i miei figli nello stesso momento». Dopodiché era rimasta in silenzio per diversi minuti. Guzman l’aveva guardata. «Mi dispiace», aveva detto. Ma lei scuoteva la testa. «Non ha importanza», aveva replicato prontamente, «Dopotutto, se non fosse stato per quello scapestrato di mio figlio, non sarei mai riuscita ad arrivare a te. Almeno a qualcosa mi è ancora utile, a quanto pare». Egli l’aveva osservata ancora e non aveva potuto fare a meno di domandarsi se veramente le fosse importato così tanto di lui come sembrava, non capendone il motivo. Doveva interpretare le sue ultime parole come un ulteriore segno della sua benevolenza? O stava per caso cadendo in qualche sporco tranello? «Posso sapere il tuo nome?» le aveva dovuto chiedere quindi, perché ormai la cosa stava cominciando a diventare sempre più seria e delicata, e aveva tremendamente bisogno di dare un senso a quella donna che così misteriosamente era apparsa nel mezzo della notte insieme alle stelle nel cielo di Poh. Lei quindi si era mossa di qualche passo, di nuovo si era fermata davanti a lui, e poi, finalmente, aveva parlato: «Io sono Samina, direttrice dell’Æther Foundation. E sono qui, Guzman, perché avrei un affare da proporti». Nel ricordare l’inizio della loro alleanza, Guzman stringe a sé il piccolo corpo di Samina con ancora più foga. Vorrebbe portarla al più presto in un luogo tranquillo, dove possa riposare qualche ora e riprendere le forze. Allora si gira di scatto verso i marmocchi, verso Hapi, soprattutto, e la scruta con un grugno impaziente. «Ehi, pischelletta! Non ti hanno insegnato che far aspettare le signore è maleducazione?! Muoviti!».  Ciao a tutti! Sono un paio di mesi che sto tenendo d'occhio le votazioni per Guzman nella sezione dei personaggi da aggiungere alla lista della sezione, ma alla fine anche se mancano ancora un paio di voti ho deciso di cominciare lo stesso a pubblicare questa storia. [Edit: Dopo qualche giorno dalla pubblicazione di questo capitolo sono riuscita ad inserirlo nell'elenco dei personaggi della storia, grazie mille a quelle due persone che hanno messo gli ultimi voti di cui c'era bisogno!] Mi è sempre piaciuta un sacco questa coppia, sia per la particolarità del loro rapporto, sia perché ho apprezzato molto i personaggi di Samina e di Guzman singolarmente. Per il momento ho completato soltanto Pokémon Luna, per cui ho deciso di ambientare questa storia in quell'universo. Ho iniziato Ultra Luna da qualche settimana, so che ci sono dei cambiamenti all'interno della trama e non vedo l'ora di scoprirli un po' per volta! Soprattutto, tenendo però a mente che le coppie che piacciono a me solitamente o vengono abbandonate per strada o fanno una brutta fine o comunque non diventano quasi mai canon, stavolta ho visto nella intro della schermata iniziale qualcosa in particolare che mi fa ben sperare per questi due, chissà se sarà proprio così? Per il momento vi chiederei di non farmi spoiler (sia per la coppia sia per il gioco in generale), poi magari con i prossimi aggiornamenti vi avviserò quando sarò arrivata a quel punto o quando avrò finito la trama principale così in caso potremo anche fare dei confronti, che sono sempre interessanti! Tornando a parlare della storia e di questo primo capitolo, ho pensato di voler rendere la narrazione al presente, cosa che però non sono molto abituata a fare, per cui, pur cercando di seguire la consecutio temporum al meglio che potevo nel passaggio da un fatto presente a uno passato, ci sono comunque alcune cose che non mi suonano bene, non so se però si tratti appunto soltanto di una questione di abitudine o se ci sia effettivamente qualcosa che ho sbagliato. La storia in realtà si concentrerà di più su una serie di ricordi passati, perciò il problema si pone al momento solo qui. Fatemi sapere se trovate qualche errore o se avete delle critiche da fare, in caso revisionerò il capitolo! Nei giochi ho apprezzato molto il Team Skull come parodia dei precedenti Team malvagi, credo che sia stata un'idea riuscitissima. Qui ero un po' indecisa su che taglio dargli, se mantenermi su un livello comico o se propendere per qualcosa di più serio, alla fine ho deciso di fare qualcosa che stesse nel mezzo. Spero che possa piacervi! Per quanto riguarda la questione dell'età di Samina, so che magari possa essere sembrata un po' un'esagerazione (la è), ma mi sono chiesta: se Hau, che ha undici anni, pensa che Samina non abbia poi tanti più anni rispetto a lui e al giocatore, quale età dimostra effettivamente questa donna agli occhi di un personaggio Pokémon? Prima di concludere, volevo dirvi che ho da poco aperto un profilo Instagram per i miei disegni (ho chiuso la pagina Tumblr), se volete potete passare a dare un'occhiata qui! Una volta tanto sto provando ad essere una persona ordinata, chissà per quanto lo manterrò... Detto questo, chiudo perché ho parlato veramente tanto! Scusatemi se vi ho trattenuto, grazie mille a tutti per essere passati e spero che tutto sommato questo primo inizio vi sia piaciuto! Al prossimo aggiornamento! Persej |
Capitolo 2
*** Nel nome che non posso pronunciare ***
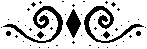 C a p i t o l o 2 : N e l n o m e c h e n o n p o s s o p r o n u n c i a r e
Da quando era entrato nelle grazie della Fondazione Æther e di Samina, Guzman era andato incontro ad una strana trasformazione – o meglio, strana per il tipo d’uomo che era lui: aveva iniziato a porre più cura nel presentarsi e nel parlare, a rivedere il proprio vocabolario togliendo laddove possibile le parolacce e le bestemmie più pesanti, e aveva persino preso a lavarsi più spesso. Tutto ciò ovviamente non era passato inosservato tra le fila del Team Skull e, anzi, per un certo periodo c’era stata una vera e sentita adesione a questo nuovo modello del capo, così che la Villa Losca era riuscita a mantenersi come per magia relativamente linda e pinta per il giro di qualche settimana, e i graffiti sui muri erano stati cancellati e le porte e le finestre aggiustate, i vetri rotti spazzati via dai pavimenti e le dispense rifornite. Ma era durato solo qualche settimana, appunto, e chiusa questa parentesi Plumeria era tornata a sequestrare gli alcolici e le canne, a menare scappellotti alle reclute più indolenti, a ricordare a tutti che, seppur le regole esistessero per essere infrante, bisognava comunque mantenere un minimo di equilibrio nel branco; a fare quello che, insomma, ci si sarebbe aspettato che una sorella maggiore facesse.
Guzman, invece, seppur quasi arrancando, rispetto agli altri era riuscito a tenersi su un livello abbastanza discreto. Non andava troppo orgoglioso del proprio cambiamento, ma era un sacrificio che si era sentito in dovere di fare, data la situazione in cui era venuto a trovarsi così all’improvviso. Tuttavia, non bisogna credere che per questo motivo egli avesse deciso di cambiare il guardaroba o di mettere via le tutone slargate e le felpe tanto comode. Ah! Cazzate: il grande Guzman non si mette in ghingheri per nessuno – piuttosto è il contrario. Per cui, il massimo a cui poteva spingersi era magari cambiarsi i vestiti e indossare della biancheria pulita, se non tutti i giorni, perlomeno una volta ogni due o tre. Dopotutto Guzman non aveva mai badato a certe cose più del dovuto e il motivo oscillava tra la convinzione che ciò rispecchiasse al meglio la sua immagine ideale di uomo duro e grezzo, e la più semplice, malcelata pigrizia che lo assaliva ogni qualvolta si accorgeva della pila di magliette inermi a terra che richiedevano di essere lavate e stirate di buona lena. Ma andava bene anche così. Per come viveva lui, per come aveva sempre vissuto lui, in realtà non c’era nulla che dovesse essere cambiato. Nessuno avrebbe dovuto manomettere il perfetto ordine delle cose che si era instaurato nel corso del tempo e giunto dopo anni al suo ineluttabile equilibrio. Guzman era distruzione, e in quanto tale nella sua persona l’ordine equivaleva al caos. Precetti e amor proprio si mischiavano fra loro in un ammasso confuso nel quale non era possibile individuare un assetto logico razionale, in cui la ragione stessa era illogica e priva di fondamento che fosse comprensibile ad altri. Ogni sentimento si scontrava e rimaneva intrappolato in un altro, poi ci si univa, si trasformava e di nuovo si ritrovava impigliato da qualche parte, così che il suo intero essere fosse costantemente in conflitto tra impulsi che non riusciva a controllare, e laddove non poteva spingersi a porre dei freni germinava incontrastata la rabbia. Per quanto Guzman tentasse di ignorare e snobbare il nuovo ambiente, di arginarlo e contrastarlo in qualche modo affinché non sfociasse entro i limiti della propria persona, alla fine dei conti trovarsi in quei luoghi asettici, in mezzo a quelle persone così diverse e altre, colte, che lo squadravano dall’alto in basso, tutto questo inevitabilmente si riversava su di lui con un che di opprimente. Spesso egli si ritrovava a scrutare fissamente quei camici bianchi e quelle visiere, senza però riuscire mai a trovare un paio di occhi oltre di esse che ricambiassero i suoi sguardi, e quindi si chiedeva se quelli che aveva di fronte in realtà non fossero degli automi, ma non erano automi, dato che nelle loro parole percepiva chiaramente il neppur troppo velato compiacimento con cui gli rinfacciavano termini e concetti e teorie che lui palesemente non era in grado di comprendere. E allora in quei momenti non poteva fare a meno di pensare al fatto che quelli magari si portavano dietro una laurea e chissà quanti dottorati e specializzazioni, mentre lui a malapena era riuscito ad ottenere il diploma di terza media, e dal liceo se ne era andato presto, non appena possibile. Poi era partito per il Giro delle Isole, era stato iniziato al rito da Hala e aveva incontrato Kukui, erano stati rifiutati entrambi come Capitani, ma Kukui adesso era Professore Pokémon, ed era esattamente come quelli lì che gli rinfacciavano con neppur troppo velato compiacimento termini e concetti e teorie che lui palesemente non era in grado di comprendere. Quando si ritrovava ingarbugliato in queste riflessioni, spesso i pensieri si legavano gli uni agli altri in una catena interminabile che si avvolgeva stretta intorno al collo e che portava sempre allo stesso punto e poi ricominciava, finché, forse per sfinimento, egli non se la toglieva di dosso un pezzo alla volta e con una leggera vertigine decideva di avere necessità di reagire, che non respirava più. Perché Guzman aveva sempre saputo di essere stupido, ma non era fesso. Forse non sarebbe riuscito ad eguagliare queste persone quanto a intelligenza, ma era perfettamente in grado di difendersi con altri modi e mezzi. E per farlo aveva bisogno di avvicinarsi a loro, a quel mondo più limpido, sebbene si fosse già reso conto di quanto lurido fosse dietro la bella facciata del castello in mezzo all’oceano che era l’Æther Paradise: avvicinarcisi, non entrarci abbandonando il proprio come alcuni premevano che facesse. A Samina, al contrario, pareva che di tutto questo non importasse nulla. Si limitava appena ad impartirgli gli ordini, poi spariva da qualche parte nella sua reggia incantata e a lui non era permesso seguirla. Una volta si era attardato con lei in uno dei laboratori che la fondazione nascondeva nei sotterranei. Gli altri colleghi se n’erano andati da un pezzo, uno dopo l’altro, e uno dopo l’altro lui era rimasto solo, lì. C’era qualcosa, nella schiena curva di Samina che si piegava sopra i monitor con fare quasi ossessivo, in quelle spalle gracili che fremevano d’improvviso, nell’impeto di qualche pensiero in cui era assorta, in quelle mappe astrali e fotografie che lei consultava con precisione maniacale sullo schermo grande e azzurro, incessantemente, e che Guzman pur sforzandosi non riusciva a capire. Cercava quindi di studiarne i dettagli, di afferrarne un senso, di trovare un collegamento, ma i suoi occhi finivano soltanto per affaticarsi e la testa per fare male. Allora restava in silenzio a guardare, senza porsi domande, lasciandosi assalire dalla vista di tutto quel che gli era sconosciuto e sentendosi piccolo. Poi ad un certo punto apparve un’immagine strana; pareva un tunnel o qualcosa del genere, che si apriva con uno squarcio in mezzo al cielo ricoperto di stelle. Samina l’aveva fissata più a lungo delle altre e il suo corpo rigido si era fatto ancor più inquieto di quanto non fosse stato fino a quel momento. A Guzman sembrò stavolta di avere forse un’idea, un’impressione, così si fece ritto, pur rimanendo fermo al posto suo. «Un varco?» chiese, e si imbarazzò di quanto rapidamente si fosse deciso a intervenire, senza nemmeno annunciarsi, o domandare prima a Samina la sua attenzione. Ella aveva avuto un lieve sussulto e la sua chioma bionda e fitta si era mossa leggermente. Ma non si era voltata. Guzman l’aveva osservata senza aggiungere altro a ciò che aveva detto, che comunque non si sarebbe scusato, attendendo un cenno o altro che però non sapeva se sarebbe arrivato veramente a lui. Si stava richiudendo nelle spalle, ma in quel mentre la voce di Samina lo riscosse. «Sì», rispose. Questo soltanto. «E dove porta?» provò allora di nuovo lui, timidamente, che aveva bisogno di sapere. «Non lo so», aveva detto lei. «Ma c’è qualcosa che io vi devo andare a prendere». «È per questo che tu mi hai voluto? Per andarlo a prendere?». Samina non rispose. Lui si spinse in avanti, tentando di carpire qualcosa di quel che stava pensando, nonostante si trovasse così lontano da lei, qualche mucchio di banchi e di scrivanie e di computer che li separava. Perché non c’era stato fino a quel momento nulla di chiaro in ciò che gli aveva proposto. Ma gli aveva offerto una cifra importante e la sua protezione, così aveva dovuto accettare, per il bene suo e per quello del gruppo. E poi, perché ella lo ammirava. Per quanto ridicolo ed egoistico fosse un tale sentimento a cui si era attaccato fin dalla prima notte, non avrebbe potuto rifiutare l’incarico. E forse proprio per questo la sua figura aveva incominciato a crescere e ad abbellirsi nella sua mente: meravigliosa, splendida, insormontabile, lo sovrastava come un’icona alla quale dovesse votarsi con ogni sacrificio. Questo suo silenzio non faceva altro che caricare ancor di più l’aura solenne ch’egli aveva costruito attorno ad essa ed ella dunque diveniva depositaria di una conoscenza inarrivabile, cui non gli fosse ancora permesso di accedere. «Samina, qual è il mio proposito?» domandò. Non ebbe timore a parlare, poiché era stato con naturalezza e spontaneità che l’aveva fatto. «Non posso ancora dirtelo», aveva finalmente risposto «Ma devi darmi la tua fiducia e al momento opportuno te lo spiegherò. Ora, vai. Per oggi non mi servi più». Erano passati un paio di mesi dal momento in cui quel sodalizio era stato cementato. Di conseguenza, oltre a Samina, Guzman aveva dovuto accogliere nella propria vita anche un’altra persona, sebbene i rapporti con questa fossero all’apparenza ancor più freddi ed egli non fosse capace di confrontarcisi direttamente. E tuttavia, c’era pur sempre una profonda protezione che riversava in essa, anche da lontano, con il proprio potere e la propria influenza. Ma gli ci volle l’incontro di una mattina per capire quanto il suo favore allo stesso tempo la soffocasse. Stava camminando per i fatti propri quando ad un tratto venne richiamato dallo schiamazzo di una rissa. Si mosse per vedere che cosa stesse accadendo ed eventualmente dar man forte, visto che intanto aveva intravisto e riconosciuto i suoi e le loro voci, quando però d’improvviso si rese conto della persona contro cui quelli si stavano accanendo. Subito fremette con impeto violento. «Oh! Ma che cazzo state facendo?!» tuonò. Guzman avanzò a passi rapidi e pesanti, sorprendendoli di colpo. I ragazzi, ammucchiati tutti intorno al più grosso che aveva in pugno la mischia, si bloccarono, lo guardarono con gli occhi spauriti: nel vederlo così alterato, la mano già pronta a richiamare quella bestia che era Golisopod, la maggior parte decise di desistere e se la diede a gambe. Uno di loro però, fra i pochi rimasti, si prese ancora un ultimo istante per stringere la vittima alla collottola, affondando le dita nei suoi capelli rasati, e trascinandolo a sé con uno strattone gli sibilò all’orecchio: «Non credere di poterla fare franca soltanto perché sei il cocco del boss, hai capito?». Guzman lo sentì. Il suo sguardo si fece veleno e col braccio che tremava sollevò in alto l’Ultra Ball frenandosi di fronte al suo viso. «Mollalo subito e vattene», ringhiò. Una smorfia bruta gl’inasprì le sembianze. La recluta si azzardò persino a ricambiare l’occhiata con vile spudoratezza. Poi però spinse via il giovane, e se la svignò in silenzio appresso agli altri. Guzman afferrò il ragazzo per le spalle, osservando il suo viso pallido ricoperto di lividi. Lo sorresse affinché non cadesse e si voltò a scrutare quelli che se ne stavano andando, sputò a terra disgustato. «Allora, pischello», disse dopo, asciugandosi la bocca contro la manica della felpa «Dove avevi detto che abiti, tu?». Quella piccola pulce di Iridio. Per Guzman Iridio era sempre stato una piccola pulce, di quelle fastidiose che ti entrano nell’orecchio e che a fatica riesci a tirar fuori. Troppo orgoglioso di sé e presuntuoso, non aveva mai sottostato alle regole del branco e pretendeva di voler fare ogni cosa di testa sua. Spiccava in mezzo alle altre reclute con prepotenza, e questo a Guzman non piaceva, ma non era dato sapere se fosse perché temeva egli stesso che la sua arroganza potesse minarlo in qualche modo. E tuttavia lo stimava per gli sforzi che versava nel voler diventare più forte e accrescersi in potenza. Dopotutto, chi meglio di un uomo come Guzman avrebbe potuto condurlo a tanto nobile traguardo? Arrivarono al Motel di Akala, lungo il Percorso 8, viaggiando in volo sopra Charizard. Quando il ragazzino però con gesto febbrile estrasse la chiave dalla tasca e la rigirò nella serratura per entrare, da deboli che erano stati fino a quel momento i suoi passi, immediatamente si fecero disperati nel correre dentro la stanza, a raggiungere il tavolo o qualsiasi altra cosa contro cui egli potesse poggiarsi. Si trattenne in piedi a fatica, con le braccia che fremevano nel sostenere il peso del corpo. «Esci, adesso», disse poi, un rivolo di sangue si era seccato e incrostato sulle labbra. Guzman lo guardò, fermo sulla porta. «Sparisci ho detto!» gridò allora Iridio, afferrando il portapenne e cercando di lanciarglielo addosso per cacciarlo via, ma non aveva abbastanza forza e il fiato gli si era affannato di colpo. «Tu te lo scordi», ribatté lui per tutta risposta bloccando con un piede l’oggetto che era caduto sul pavimento rotolando. Scalciandolo da parte, fece il suo ingresso in mezzo alle penne sparse ovunque e lo squadrò: «Te lo scordi proprio», continuò «Il grande Guzman non se ne va via da qui finché non ti sarai dato una sistemata, chiaro? Cristo, guarda come sei ridotto». C’erano voluti diversi minuti prima che Iridio si fosse deciso ad ascoltarlo. A un certo punto Guzman si era innervosito, con uno strattone l’aveva preso e fatto sedere sul letto, litigando con quelle sue braccine piccole e i piedi che tiravano calci nel tentativo di spingerlo via, e gli aveva detto di starsene buono e zitto. Così finalmente era riuscito a guadagnarsi la sua attenzione. Si era fatto indicare dove teneva l’occorrente per le medicazioni e dopo averlo preso si era avvicinato una sedia mettendocisi sopra con le gambe incrociate una sull’altra. Guzman non era proprio nato con l’istinto da crocerossina, e per quanto provasse ad essere delicato nel tamponargli le ferite col disinfettante, i suoi gesti erano bruschi e Iridio a ragione se ne lamentava. Improvvisamente si fece di nuovo intrattabile quando Guzman gli passò una mano in viso per scostare via la frangia di capelli e si ritrasse, lanciando improperi e ripetendo che aveva già fatto abbastanza e che se ne doveva andare, sennò, sennò... Ma poi si era rassegnato, che era inutile convincerlo a desistere, così si lasciò toccare e Guzman scoprì il suo occhio gonfio e livido, che si apriva a malapena. «Ti hanno fatto proprio nero, eh?», osservò. «Il ghiaccio ce l’hai?». «È nel freezer». Allora sembrò che le divergenze si fossero appianate, almeno per poco, sebbene Iridio non avesse smesso di rispondere alle sue domande con quel solito tono freddo e altezzoso da ragazzino ribelle e indomabile. Quando si tolse il felpone per mostrare gli altri lividi e gli acciacchi che aveva sul resto del corpo, Guzman si divertì a prenderlo in giro: «Certo che sei gracile, non si direbbe con tutte le arie che ti dai...». «Ma smettila, senti chi parla, poi». «E con questo che vorresti insinuare? Piuttosto, di’ un po’. Che cosa sarebbe quello?». Con un cenno del capo indicò l’angolo della stanza dove accovacciato sul pavimento stava il Pokémon che Iridio aveva liberato dalla Sfera. Esso rivolse uno sguardo al proprio Allenatore, poi tornò a scrutare fissamente la mole di Guzman che si piegava sul ragazzo a pulirgli i tagli. Le zampe anteriori erano quelle di un insetto, ma il corpo era quello di un cane e aveva una coda di pesce. Sul muso portava una maschera d’acciaio, e pareva piuttosto pesante e stretta, perché Guzman udiva quella creatura ansimare e respirare faticosamente, come se ne fosse soffocata. Egli da una parte ne provava timore, poiché tutto nel suo aspetto gli sembrava costrizione, simile a quella che sentiva lui stesso mentre attraversava i corridoi lunghi e bianchi dei laboratori Æther, ma dall’altra ne era irrimediabilmente affascinato e incuriosito. «Solo per sapere, eh», incalzò «Non ho mai visto un affare del genere prima che arrivassi tu». «Quello non è un affare», ribatté Iridio con disappunto. «E comunque non sono fatti tuoi». «E certo, ti pareva...» sbuffò sollevandosi dalla sua posa scomposta e rimettendo i piedi a terra «Fa niente, me lo dirai un’altra volta. Adesso rivestiti». Mentre Iridio si allungava verso l’armadio per prendere una maglietta pulita, Guzman era chino a raccogliere le penne disseminate sul tappeto e vicino alla porta. Man a mano che le riponeva a posto una per volta, gli venne da pensare che era da tanto che non ne impugnava una per bene nelle dita, e che chissà quanto tempo era passato dall’ultima volta che si era messo a scrivere. La sua grafia era sempre stata pessima. Prima di uscire si rivolse a Iridio per lasciargli un rapido saluto. Poi tuttavia si accorse del rivolo di sangue che continuava a scivolare sulla sua bocca, e si mosse per porgergli un fazzoletto di quelli che teneva in tasca. Fu in quel momento che si accorse delle sue labbra: gli ricordavano quelle di sua madre. E anche gli occhi, e l’espressione un po’ austera del viso. Tutto in Iridio era tanto simile a Samina. Indietreggiò di un passo dicendo che il fazzoletto avrebbe potuto tenerlo. Ma quando posò la mano sulla maniglia della porta, la voce del ragazzino lo bloccò un’altra volta: «Non aspettarti che io ti ringrazi». Guzman sussultò. «Non me ne faccio niente della tua ridicola gentilezza», continuò a dire Iridio «E non ho nemmeno bisogno della tua pietà. Io sono venuto qui perché insieme a Tipo Zero dobbiamo farcela da soli. Non serve che... Non serve che... Insomma, non serve proprio a nulla che tu mi faccia da padre perché ti faccio pena a non averne più uno! Tu non puoi riportarmelo indietro! E non puoi prendere il suo posto. Non puoi prendere il suo posto... Hai capito? Io non ti voglio». Forse era stato perché quelle parole erano uscite dalle stesse labbra che erano quelle di Samina, come anche lo sguardo freddo che Iridio gli aveva rivolto da quell’unico occhio scoperto dalla frangia, che Guzman si era sentito d’improvviso così piccolo e miserabile. Uscendo all’aria aperta, di fronte alla distesa interminabile del mare di Akala, gli era sembrato che tutto si fosse fatto angusto e asfissiante, e che d’un tratto sul suo viso fosse calata una maschera d’acciaio. «Pare che lo abbia perso anni fa. Un incidente, credo. Non me l’ha voluto dire». Le magliette e i pantaloni rigiravano assieme a qualche paio di mutande dentro la lavatrice. Guzman se ne stava seduto sul pavimento con la testa poggiata contro il vetro dell’oblò e li guardava impaziente, in attesa che il lavaggio finisse: era rimasto a corto di vestiti e non aveva nulla di pulito da mettere, così si era dovuto rassegnare e decidersi una buona volta ad accantonare la pigrizia e a passar sopra al suo solito procrastinare incessantemente su tutto quanto. «È così che stanno le cose, allora», disse ad un tratto sovrappensiero. Si voltò leggermente verso Plumeria che nel frattempo svuotava la cesta degli altri panni sporchi, separando i bianchi dai neri, e rimase ad osservarla dal basso. «E perché l’avrebbe detto a te e non a me?» le chiese «Dopotutto il capo qui sono io». «Perché tu sarai pure il capo, ma io sono la sorella maggiore», lo rimbeccò lei «Io mi occupo sempre di tutti. E in ogni caso a te non è mai importato più di tanto di quel ragazzino prima d’ora, non ho ragione? Si può sapere come mai proprio adesso...?». «Perché quello è suo figlio, Plum», mormorò. Il cestello della lavatrice girava, girava. Prima in un verso, poi nell’altro. Guzman si perdeva ad osservare gli schizzi d’acqua insaponata, poi si metteva a contare le gocce che rimanevano sul vetro e dopodiché si allungava a guardare nel buio della zona più profonda, dove la luce della lampada non arrivava, e rincontrava sé stesso nel riflesso della parete opposta, sbiadito e deformato, con quella sua faccia cattiva ma non troppo. Una volta, ricordava, da bambino si divertiva a far finta che l’interno della lavatrice di casa fosse un oceano pieno di Corsola e di Starmie, ed era tutto molto bello, ma ora che era diventato adulto in quell’ammasso di biancheria e di tute lerce non riusciva a scorgere nemmeno il più misero pesce. Per il tempo di un istante rievocò il profumo dei panni che la mamma stendeva in giardino, vicino allo scivolo e agli altri giochi che gli aveva regalato e che erano suoi, solo suoi. A quel punto, inevitabilmente, i pensieri si riversarono su Samina. Samina non gli aveva mai parlato del marito. Non che Guzman si fosse mai preoccupato di chiedergliene: fino al momento in cui Iridio gli aveva gridato contro, non era nemmeno mai esistita l’idea di un marito, di un altro uomo, nella sua mente, che si accostasse alla figura sottile e immacolata di lei. E tuttavia, quel ragazzino un padre doveva pur avercelo. O avercelo avuto, insomma. «Di quella donna?» domandò Plumeria. «Sì», disse lui. E chissà che nome aveva questo marito, e chissà che aspetto. Però non doveva essere un aspetto qualunque, pensò Guzman, se era quello dell’uomo di cui Samina si era innamorata e con cui aveva avuto la bellezza di due figli. Ecco, da quando l’aveva conosciuta, lei era sempre stata la madre, l’unica madre – non c’era mai stato bisogno di un padre. Ora, invece, quella presenza sconosciuta si faceva di colpo palese e ovvia, diveniva via via più definita pur rimanendo impalpabile e invisibile. Con una mano, Guzman strinse un lembo della felpa, come se per un attimo avesse provato l’impulso meccanico di richiuderla e proteggersi. Che poi, proteggersi da cosa? Se tutto pulsava soltanto nella sua testa dentro di sé. Non avrebbe saputo spiegare per quale ragione si sentisse così vulnerabile all’improvviso, di fronte a un’idea, a una scoperta tanto banale. Ed era stupido provare un tale timore dinnanzi a qualcosa che non ha forma, che nemmeno attacca e che non c’è più. Ma proprio perché non c’era più, egli sapeva che quel pensiero l’avrebbe assillato, che sarebbe rimasto soggiogato e sconfitto ai suoi piedi. In quella consapevolezza, la mano di Guzman cominciò a tremare. Poi, però, i suoi occhi si persero di nuovo nell’acqua e nel sapone, e laggiù, nel fondo della lavatrice, gli parve di scorgere qualcosa, ed ebbe un’impressione angosciante, e cioè che quel qualcosa, in effetti, lo stesse osservando. Sembrava – si strofinò gli occhi –, sembrava una medusa. Una medusa? Di colore bianco. Scosse la testa e batté le palpebre perplesso. Subito dopo il cestello ruotò e quando la medusa ritornò in superficie galleggiando, Guzman si accorse che non era affatto una medusa. Sbuffò, un po’ per il sollievo di non essere diventato matto tutto d’un tratto, e un po’ anche perché non capiva che gli fosse appena preso. «Scusa, Plum, è tuo quello?» chiese «Perché è carino, ma io non penso che me lo metto». «Ah, sì», disse lei «Mi serviva un reggiseno pulito e così l’ho infilato tra i tuoi vestiti. Comunque, se vuoi proprio saperlo, non penso ti starebbe tanto male addosso». Plumeria sorrideva, e i suoi occhi erano quelli maliziosi e perfidi di una Salazzle. Lui si limitò soltanto a rivolgerle uno sguardo indispettito e ad alzare le braccia in segno di resa, che non sapeva come controbattere. «Per stavolta passo». Il giorno successivo Guzman si era presentato davanti ai cancelli dell’Æther Paradise con l’intenzione di capirci qualcosa di più, che non ci aveva dormito la notte. Aveva passato l’intera mattinata a rincorrere i camici bianchi e a chiedere di Samina, ma come egli tentava di avvicinarcisi, ella si faceva ancora più lontana e irraggiungibile. L’aveva vista, a un certo punto. Di sfuggita, un istante appena. Poi se ne era andata come sempre. Allora Guzman aveva preso una decisione, che tutto quel che non gli era rivelato l’avrebbe scoperto da solo. E tuttavia, non poteva più permettersi di stare ad osservare semplicemente dall’esterno: se voleva sapere, era necessario che entrasse in quel mondo che gli era estraneo, e doveva penetrarvi fin nel profondo. Mentre scendeva con l’ascensore per addentrarsi nei sotterranei, quel giorno Guzman provò uno strano timore. Che forse, come gli aveva detto Iridio, tutto questo non era davvero affar suo, e che avrebbe fatto meglio a tenersi alla larga da quelle trame nascoste e incomprensibili. Ma ormai aveva già mosso i primi passi dentro i laboratori, e non vi era altro da fare se non continuare ad insistere. Una dopo l’altra, si mise ad esplorare le stanze nelle quali gli era permesso d’entrare. Sotto gli sguardi scettici di quelli che si stava sforzando a chiamare colleghi pur provandone ribrezzo, esaminava da solo scaffali e librerie, cercando di trovare qualcosa che gli potesse essere minimamente utile. Che cos’era ciò che Samina doveva andare a prendere in quel varco che fissava ogni volta? Perché Iridio era scappato? Cos’era quel Pokémon che aveva con sé? E perché si sentiva così terribilmente in soggezione al pensiero di quel padre, di quel marito che era scomparso? Dov’era l’altra bambina? Lei non l’aveva neppure mai vista, e non sapeva nemmeno come si chiamasse. Che avesse delle colpe anch'ella? Si era fatta ormai sera. A Guzman bruciavano gli occhi per lo sforzo, e gli dolevano le spalle. Se ne stava stravaccato su una poltrona, con le tempie che pulsavano per la fatica che aveva compiuto quel giorno, nel tentativo di rilassarsi e calmarsi. Aveva trovato questo computer acceso, dove sul monitor campeggiava la scheda aperta di un blog probabilmente appartenente a un dipendente. Non parevano esserci informazioni in esso che gli potessero tornare interessanti, tuttavia quell’insieme di tracotanza e presunzione che percepiva tra le righe dei post era il passatempo perfetto per distrarsi e riposare la mente per il tempo di qualche minuto. C’era una morsa viscerale e sottile che lo strozzava all’altezza del petto. E allora, quando essa si faceva più forte, leggeva: Un membro della famiglia della direttrice è fuggito portando con sé i risultati delle mie ricerche. Ovviamente mi guarderò bene dal riportare l’incidente alla direttrice per diversi motivi: innanzitutto, il fatto verrebbe considerato un mio errore e attirerei su di me le sue ire... Inoltre, se c’è una cosa che la direttrice detesta è affrontare qualsiasi questione familiare. La morale di questa storia è che, a conti fatti, per mantenere la propria posizione privilegiata l’alterazione dei fatti relativi a questo sfortunato evento è di vitale importanza. «Se c’è una cosa che la direttrice detesta è affrontare qualsiasi questione familiare», ripeté Guzman a mezza voce tra sé e sé. Un vortice di immagini e di parole che aveva incontrato quel giorno si materializzò in modo vago nella sua mente, e pensò che adesso questo atteggiamento di Samina gli fosse in parte comprensibile. Vi erano ancora dei punti, però, che non era in grado di collegare fra loro e che restavano nebulosi. «Che cosa ci fai qui, villano?». La porta d’improvviso si era aperta, e sulla soglia era apparso questo omino di cui Guzman riusciva a distinguere appena il viso oltre gli enormi occhiali che gli coprivano lo sguardo. Nei tratti secchi e asciutti del volto gli parve di percepire un certo fastidio, come se la sua vista lo schifasse. «Bada a come parli, quattrocchi», disse Guzman sollevandosi in tutta la sua possenza e particolarmente offeso «Che non sarò il benvenuto da queste parti, ma non mi faccio scrupoli a ricavarmi il mio spazio sbriciolando tutto quello che ho davanti. Inclusi i vermi come te che non mi degnano di rispetto». «Eppure, dovrebbe esserti abbastanza chiaro che l’unico verme, qui, sei tu», ribatté l’altro con un sorriso viscido sulle labbra, compiaciuto di quel muro che egli si era affrettato a sollevare, forse interpretandolo come un gesto di difesa piuttosto che di minaccia «E faresti bene a tornartene in quell’insulsa bettola che vi siete costruiti tu e quegli altri teppistelli da due soldi che ti vengono dietro laggiù a Poh. Ancora non riesco a capire che cosa ci trovi la direttrice in un essere infimo come te al punto da essersi persuasa a volerti come collaboratore. Dopotutto, voi del Team Skull non sapete far altro che metterci in continuazione i bastoni fra le ruote». «Come osi, rivolgerti così al grande Guzman!». In due falcate scavalcò la scrivania e lo raggiunse, lo strattonò per il colletto del camice e lo scaraventò alla parete, avventandosi contro di lui e sentendo che il suo corpo era talmente sottile e gracile che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a sbriciolarlo per davvero. Ansimando di rabbia, lo sollevò leggermente dal pavimento, e nel rendersi conto di quanto fosse semplice e fin troppo facile accanirsi su di una macchietta del genere, per un attimo sentì il sangue ribollirgli nelle vene e provò un qualche violento, irrefrenabile piacere nel riconoscersi nella propria forza, nella propria potenza. La sua bocca si distese in una smorfia, come estasiata da quella sensazione di superiorità e di dominio. «Io non mi faccio mettere i piedi in testa da uno scarafaggio come te, hai capito? Hai capito?!» gli gridò in faccia, che doveva sentire il suo fiato addosso. Fu terribilmente bello e appagante vedere quell’espressione spaurita e tragica prendere forma sopra quel viso patetico. Ma poi, di colpo, così come l’aveva aggredito, Guzman lasciò andare l’uomo, avvertendo ogni furia abbandonare le mani nerborute, e poi il collo tanto brutalmente tirato a sollevare la testa, e poi la mascella contratta. «Come pensi che Samina prenderebbe tutto quel che mi stai facendo?» l’aveva sentito mormorare, infatti. E allora si era dovuto ritrarre. Subito il senso di colpa aveva cominciato ad affiorare nel suo cuore, in lui, che senso di colpa non versava nei confronti di nessuno. Di nuovo le immagini e le parole presero a vorticargli davanti agli occhi mentre quello gli diceva di andarsene, e Guzman rivide Iridio, le sue labbra e poi quelle di Samina, le ciglia lunghe e severe di lei, la sua figura magra e immacolata che si univa a un altro uomo e si macchiava della sua perdita, uno squarcio luminoso nel cielo tra le stelle della notte, e si sentì soffocare da tutto quanto, come se indossasse una maschera d’acciaio che lo intrappolasse. Corse via, Guzman, e solo una cosa aveva capito. Che c’era un nome che non poteva pronunciare, e quel nome era Paver.  Buongiorno a tutti! Come state? Ecco qui finalmente il secondo capitolo, mi dispiace veramente tanto di aver fatto passare tutto questo tempo. Tra l'altro in Pokémon Ultra Luna sono ancora ferma alla seconda isola in attesa di arrivare da Alyxia, quindi anche lì le cose stanno andando un po' a rilento. Confesso che sto trovando questo seguito/remake ancora più guidato del precedente e la presenza invadente di Rotom si fa sentire parecchio, perciò sto avendo qualche difficoltà a godermelo appieno al momento. Ma comunque, piano piano lo finirò! Per questo capitolo in realtà non ho molto da dire. Ho sempre pensato fosse interessante come nei giochi si sia gestita l'influenza di Samina su Guzman: avete mai fatto caso a come nella Battle Theme di Guzman siano riprese sia la melodia della Fondazione Aether che quella di Samina? Come al solito non posso fare a meno di adorare questo tipo di dettagli secondari... Il post riportato nel testo è ripreso da uno dei computer dei laboratori sotterranei in-game, mentre per quanto riguarda la parte della lavatrice c'era effettivamente questa pubblicità che girava in televisione credo nei primi anni 2000 dove appunto l'interno di una lavatrice si trasformava in un oceano. Da bambina mi rimase particolarmente impressa. Prima di chiudere vorrei ringraziare in maniera speciale Afaneia, BlazePower e Barbra per i loro preziosissimi commenti al capitolo precedente. Per il resto, spero tanto che il capitolo vi sia piaciuto e nel frattempo, come sempre, mando un forte abbraccio a tutti quanti! A presto, Persej |
Capitolo 3
*** Non pensavo che un uomo e una donna soli... ***
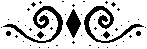 C a p i t o l o 3 : N o n p e n s a v o c h e u n u o m o e u n a d o n n a s o l i . . .
Paver se ne era andato in un giorno di maggio. Questo era quanto gli aveva raccontato Ciceria, capo in seconda della Fondazione Æther accanto a quello che aveva scoperto essere Vicio. Guzman si era imbattuto in lei nel momento in cui era scappato dai laboratori, ed ella vedendolo così agitato l’aveva fermato e gli aveva chiesto cosa gli fosse preso, poi l’aveva condotto in quest’area del centro di recupero dove non era mai stato e che doveva trattarsi a tutti gli effetti della residenza personale di Samina: di lei, in ogni caso, non vi era alcuna traccia.
Una ragazza piuttosto formosa, Ciceria. Guzman era rimasto a osservarla a lungo quando, seduto sul divano del grande salone, gli aveva servito il tè caldo nella tazza. Poi era andata a prendere lo zucchero, e dopo il miele, e insomma per un po’ aveva fatto avanti e indietro tra quella stanza e la cucina, così Guzman ogni volta che la donna se ne andava rimaneva a fissare la porta fino a quando non risbucava fuori, che si sentiva troppo in soggezione ad allungare lo sguardo nella casa di Samina, nelle sue cose – in quei possibili resti del marito e dei figli che ancora le appartenevano. Soprattutto adesso che era venuto a conoscenza dell’intera storia. La sua tazza di tè indugiava imbevuta fra le mani, ormai fredda. Non aveva neppure voglia di berne un piccolo sorso, per cortesia, come gli aveva insegnato a fare sua mamma tanti anni prima da piccolo. Una ragazza piuttosto formosa, Ciceria. Non era il suo tipo di donna, e tuttavia c’era qualcosa di morbido e accogliente nella sua figura che lo attraeva. Persino la sua voce suonava d’un che di tenero, e nei suoi occhi Guzman percepiva una certa inoppugnabile dolcezza. Come di una madre. Ma di una madre che non abbia mai avuto figli propri. Soltanto di altri. «Ora però sarà meglio che tu vada», disse lei ad un tratto, guardando l’orologio «Non vorrei che Samina ti trovasse qui e si arrabbiasse. Sai, ormai oltre a me e Vicio non fa più entrare nessuno... Mi raccomando, non una parola, intesi?». Ciceria si era affrettata a restituirgli le sue cose e con passo svelto l’aveva riaccompagnato all’ingresso della villa. Si era rassicurata di nuovo con mille premure, gli aveva spiegato in poche parole come ritrovare la strada verso i quartieri dell’Æther Paradise e infine con un ultimo saluto aveva lasciato intendere che sarebbe stato bene non farsi più rivedere da quelle parti. Guzman si calcò il cappuccio nero sulla testa e con un gesto brusco delle dita fece capire alla donna che non c’era bisogno di aggiungere altro. Subito dopo la intimò di aprirgli il portone, e se qualcuno in quel momento gli avesse dato della mezza calzetta a vederlo scappare via a quella maniera, probabilmente non sarebbe nemmeno stato poi così tanto in torto. Però tutti quegli oggetti di Samina che lo circondavano, tutti quei suoi ricordi che adesso non poteva più cancellare dalla mente, tutto quanto nella tensione gli si era ammassato come un peso insostenibile sul petto, e non aveva altro desiderio che quello di liberarsene il più presto possibile, nell’aria uggiosa che si respirava sopra i tetti di Poh, oppure prendendosela con qualche ragazzino malcapitato assestando un paio di colpi insieme a Golisopod. «Ecco, ecco! E adesso vai!» incalzò Ciceria, il pomello stretto nelle mani tremanti e sudate mentre si tirava di lato. Guzman rivolse ancora una volta gli occhi alle forme abbondanti di lei e al suo sguardo apprensivo, sempre luminoso di quella sua tenerezza che gli pareva tanto strana. Inforcò le lenti da sole e finalmente uscì per andarsene. «Merda». Non aveva messo che un solo piede sul primo gradino della scalinata. La pioggia gli offuscava a tratti la vista, e in effetti non è che vedesse già granché con gli occhiali scuri addosso. Eppure, quella figura slanciata che aveva davanti non poteva essere nient’altri che Samina, coi suoi capelli biondi e lunghi, la postura aggraziata del corpo e la veste candida, elegante. Era ancora lontana, ma Guzman distinse chiaramente nelle fattezze del suo viso quell’unico occhio verde che teneva scoperto, e quando lo mise più a fuoco, allora capì di essere stato scoperto. Rabbrividì. Neppure Ciceria osava muoversi. Camminava lentamente, come una presenza inquietante che debba da principio insinuarsi a poco a poco prima di manifestarsi nella propria totale atrocità – uno spettro. Samina avanzava, coi piedi leggeri che si adagiavano sull’asfalto bagnato, e non c’era modo di fermarla, né di fuggire. Un ombrellino bianco e rigonfio la riparava dall’acqua, che scivolava in mille gocce lungo la superficie per poi ricadere dalle falde ornate a ricamo. Mentre Guzman vi concentrava sopra la propria attenzione, un miraggio lo colse nella furia della tormenta, e le ciocche di Samina che ondeggiavano nel vento sembrarono scomporsi e tramutarsi in tentacoli bianchi e luminescenti. Strabuzzò gli occhi: era di nuovo quella medusa. Con uno scatto violento si tolse le lenti di dosso, ma di fronte a sé non aveva che Samina, soltanto Samina. Restò a scrutarla turbato, poiché era la seconda volta che quella visione lo colpiva, e non poteva più trattarsi soltanto di una coincidenza. Ma che diamine gli prendeva? La donna l’aveva ormai raggiunto. Ferma all’inizio della scalinata, lo guardava col viso sollevato. Guzman sentì la presa delle dita allentarsi, e gli occhiali caddero a terra bagnandosi. «Direttrice!» esclamò Ciceria, facendosi avanti oltre il portone «Il signor Guzman si era perso, gli ho indicato la strada per tornare indietro... Se ne stava giusto andando». Guzman sentì la mano di lei posarsi sulla sua schiena e spingere delicatamente per spronarlo a partire. Rimase sorpreso dalla cura che percepì in quel gesto tanto semplice. Gliene fu riconoscente, così senza farle perdere altro tempo si sbrigò a raccogliere gli occhiali da terra, ma le dita di Samina furono più rapide delle sue. Quando si risollevò, si accorse che la donna lo stava riparando sotto il proprio ombrello. Samina gli porse le lenti senza pronunciare parola, ed egli restò altrettanto silenzioso a osservarla. Prese gli occhiali: le loro mani vennero a sfiorarsi per un istante. Guzman si voltò e scese la scalinata a passi spediti senza mai guardarsi indietro, già diretto verso l’ascensore. «Te ne vai così, con questa pioggia?» domandò però lei ad un tratto. Si fermò. La sua bocca si arcuò in un sorriso divertito, e all’improvviso la strizza lo abbandonò. «Tu non ci sei mai entrata a Poh, eh, Samina?» replicò, «Queste in confronto sono appena due gocce». «Puoi tornare, se vuoi». Guzman a quelle parole esitò. La guardò negli occhi e si sentì di colpo debole, avvinto nella morsa di quel verde ammaliante. Samina si apprestò ad entrare. Lui le rivolse appena un cenno. Se ne andò. Quella mattina Guzman se ne stava come al solito assiso sul suo trono, circondato da una manica di reclute adoranti, pronte a offrigli i propri servigi e le moine e le preghiere più accorate. Scomposto, con le gambe divaricate a occupare l’intero spazio, la schiena robusta abbandonata di peso contro la spalliera imbottita e sfilacciata – di fatto si trattava di una banalissima poltrona, ormai vecchia, saccheggiata anni prima in una casa del circondario durante le invasioni iniziali di Poh, ma era opinione comune che sotto il sedere di Guzman persino la sedia più becera potesse trasformarsi nel trono più sontuoso ed elegante, perciò nessuno ci aveva mai badato tanto –, era intento a schiamazzare con i suoi mentre si faceva baldoria per l’ultimo colpo andato a segno del Team Skull. Qualcuno finalmente gli porse la bottiglia di vino che aveva fin lì reclamato, la stappò, nel richiamare gli altri ne versò una parte a terra, il resto finì nei bicchieri rotti di quelle mani che si allungavano verso di lui a chiederne almeno un sorso. «Bevetene tutti!» esclamò, piegandosi poi verso i più piccoletti che si erano avvicinati di nascosto da Plumeria «Anche voi, forza, un dito così non vi farà male». All’improvviso dalla porta fecero irruzione due reclute nerborute, di quelle che Guzman aveva messo a guardia dell’ingresso della villa. In mezzo a loro, tenuto stretto per le braccia, stava una terza figura: nel momento in cui egli la riconobbe, dapprima lo assalì un timore sottile, poi, nel notare l’espressione di disagio che campeggiava sopra il suo viso, un ghigno perverso si arricciò sulle sue labbra. «Sei capitato male, eh, Viscido? Benvenuto nel regno di Guzman!». «Il mio nome è Vicio, di grazia! E ti chiederei cortesemente di liberarmi dalle grinfie di questi due bestioni». Detto fatto, bastò uno schioccar di dita che subito Vicio venne abbandonato a terra senza ritegno. Guzman lo guardò divertito pulirsi i vestiti bianchi dalla polvere e dalla sporcizia, poi con un gesto lo esortò a farsi avanti, lasciando da parte la bottiglia. «Dimmi, cos’è che ti porta nella mia lussuosa reggia?» chiese. «Avrei molto da ridire in merito», ribatté schizzinoso, sistemandosi gli occhiali sopra il naso e spingendo via una recluta ubriaca per farsi strada «Ma la direttrice Samina mi ha inviato qui per consegnarti questa missiva». Dalla tasca del camice, Vicio tirò fuori una lettera. Guzman gliela sfilò dalle dita, in trepidante attesa di leggerla. Prima di aprirla, tuttavia, lo afferrò per il colletto e all’orecchio sussurrò: «Hai una bella faccia tosta a sfruttare i bisogni della direttrice come ti fa comodo. Non gli avevi detto niente, vero, del ragazzino e di quell’affare?». Vicio sorrise di un sorriso stavolta effettivamente viscido: «È vero, non le dissi niente. Ma non ti pare di esagerare un po’ troppo con queste insinuazioni? Qualcuno potrebbe venire a saperlo e non approvare». Guzman si sentì nuovamente aggredito, davanti a sé vide lo spettro di Samina – e accanto a lei quello di Paver, senza volto e senza voce, eppure perfetto nella sua inconsistenza – che guardava con occhi rapiti ogni sua mossa sconsiderata. Vicio aveva il coltello dalla parte del manico, e per quanto lo detestasse, Guzman dovette desistere e abbassarsi al suo gioco. Lo scostò via da sé con uno strattone, egli indietreggiò, ma non lo liberò dalla morsa di quello sguardo velenoso e infido che continuava a rivolgergli. Guzman tacque, subendo la sua influenza. Aprì la lettera con una cura che generalmente non gli apparteneva. Trattenendo il foglio gelosamente sul proprio grembo, lesse che Samina lo convocava: era pronta a rivelargli il suo scopo. «Questo è un Ultravarco». Guzman guardava con attenzione l’immagine che Samina gli stava mostrando sul monitor. Cercava di addentrarvisi fino in fondo, ma per quanto potesse sforzare gli occhi non c’era modo di indagare oltre quel bianco pallido e vuoto, luminescente di una luce astrale. Era lì, pensava, che si trovava Paver. Si domandò se avrebbe mai avuto il coraggio di fronteggiarlo, un giorno, nel caso in cui ella l’avesse voluto spedire a recuperarlo. Samina era intenta a spiegare le specifiche di quel portale, cifre, valori, e tuttavia nell’inflessione della voce non vi era alcun accenno di rimprovero o di superbia. Guzman l’ascoltava cercando di starle dietro, assetato di sapere e desideroso di trovare finalmente un senso al proprio incarico. Di tanto in tanto Samina si fermava, rimaneva pensierosa a riflettere e in quei momenti egli la guardava, osservava in silenzio la sua postura rigida e trattenuta farsi impercettibilmente vulnerabile per il tempo di qualche secondo – quando cioè, probabilmente, le memorie dovevano assalirla di colpo tutte assieme ed ella cercava di porvi un freno. Guzman poteva sentire il suo respiro farsi gravoso, sotto il peso di quelle pressioni che continuamente dovevano assillarla. Non si permise mai di farle domande sulla sua vita privata, ma più perché non intendeva sciupare quella sacra barriera che li separava tenendoli nello stesso tempo alla giusta distanza affinché non sfociassero troppo pericolosamente l’uno nell’altra, piuttosto che per il timore di scatenare in quel modo la sua rabbia. Dopo essersi arrestata, poi, Samina ricominciava a parlare, sempre col solito tono basso e serioso. Alle volte si girava verso di Guzman e gli traduceva in parole povere ciò che aveva appena detto, la sua voce si addolciva di un candore materno. Lui gliene era semplicemente grato. Insieme a questo lato più tenero, però, Samina sapeva essere anche una donna estremamente orgogliosa e vendicativa. A Guzman era bastato il loro primo incontro per rendersene conto, eppure in lui permaneva con maggior forza quella sua aura amorevole, si calava ogni volta a scoprirne le sfaccettature. Aveva la strana impressione che al solo vederla il suo cuore in qualche modo si ingentilisse, e che la sua stessa persona in qualche modo ne fosse contagiata. Si crogiolava nell’immagine di lei che chinandosi a terra accoglieva sotto il velo di capelli i Corsola e gli Starmie ad offrirgli il proprio amore. C’erano spesso dei momenti, di cui egli si era già reso conto, in cui Samina d’improvviso svaniva nei meandri dell’Æther Paradise. Guzman scoprì più tardi che in tali occasioni ella si isolava di propria sponte per potersi rintanare nelle sue stanze, tra i suoi oggetti e tra i suoi ricordi, che ancora manteneva vivi davanti a sé. Accadde un giorno, per caso, che se ne ritrovarono a parlare in mezzo a certi discorsi difficili sull’universo e sul creato, sul destino e sulle stelle. Ad un tratto Samina si era alzata, aveva preso nelle mani una cornice. Oltre il vetro, una fotografia: «Mia figlia Lylia». Anche lei se ne era andata, e aveva portato via Cosmog con sé. Con il passare del tempo, quindi, da semplice socio, Guzman divenne il vero e proprio confidente di Samina. Allora era venuto a sapere, stavolta dalla sua stessa voce, delle vicende dei figli e di come ella avesse comunque modo di controllarli nonostante la lontananza, e, ancora, dell'immenso dolore creato dal vuoto lasciato da Paver. I loro rapporti si mantennero comunque piuttosto formali, nessuno accennò mai ad avanzare di un passo. Almeno fino a quando, una sera, come di consueto, Guzman si recò da lei per aggiornarla sugli ultimi dettagli circa l’avanzamento della missione e Samina lo accolse in casa in vestaglia, col viso stanco e provato. Seppure sapesse essere elegante anche in quelle vesti, egli pensò di non averla mai vista così umana prima di allora. Entrò timidamente, chiese notizie di Ciceria. Samina rispose che l’aveva già mandata via. Guzman intuì che non dovesse sentirsi bene e che probabilmente fosse caduta un’altra volta nei suoi momenti di solitudine. Allora provò a offrirsi di togliere il disturbo, ma ella lo trattenne: «Resta», gli disse. Guzman restò. Samina girava per le stanze a spegnere le luci e a chiudere le finestre, a riordinare ossessivamente e con precisione gli oggetti che erano stati utilizzati quel giorno. Egli la seguì, osservando ogni suo gesto e intanto rispondendo senza sosta alle sue domande – ebbe l’impressione che in quella casa il tempo avesse smesso di scorrere e che tutto permanesse in uno stato di quiete assoluta e intoccabile –; quando però fece per entrare in camera da letto, Guzman esitò a lungo di fronte alla porta. Vide gli occhi di Samina incoraggiarlo a varcare quella soglia, e dentro di lui era un brulicare di amore materno e calore sensuale. Sfiorò con lo sguardo la scollatura morbida della vestaglia che si schiudeva sopra il suo seno. Ancora una volta entrò, attraversò un altro confine la cui rottura lo avvicinava sempre più a lei. In un primo momento stette in piedi, misurando l’intera stanza con passi rapidi e nervosi, senza mai riuscire a voltare la testa lì dove Samina si era acquattata, davanti alla toeletta, per struccarsi e ungersi il viso di creme. Parlava, parlava, allungava il discorso con dettagli insignificanti per distrarsi da quella presenza che sentiva pulsare poco lontano da sé. Poi si sedette sul letto, estenuato da quella lotta contro i sensi, ma il profumo di lei impregnato sulle lenzuola saliva al suo naso in tante spirali gradevoli, gli accarezzava le guance ad accenderle di un tepore caldo, mozzandogli il fiato a tratti. Con la testa che girava, Guzman cominciò a perdersi nelle proprie parole, la sua voce s’incagliava nella pausa di un sospiro, e il discorso che aveva tessuto fino a quel momento si sfaldava man mano, ne recuperava il filo di sfuggita per poi riarrestarsi di continuo finché sulla lingua non rimasero che dei nodi grossolani riuniti tra loro in modo scomposto. Alzò gli occhi su Samina, la fissò come a trovare in lei un assenso, una conclusione a quel tormento, eppure lei non fiatava, lasciandolo nel silenzio più vuoto e opprimente, e allora lui era costretto ad andare avanti per riempire quel nulla gigantesco, ma non ce la faceva più – non era mai abbastanza, non sarebbe mai stato abbastanza. Samina era rivolta unicamente al proprio riflesso davanti allo specchio. Si guardava insistentemente, come rapita dall’immagine di sé stessa. Ad un tratto il dischetto di cotone scivolò via dalle sue dita. Cadde prima sul ripiano del mobile, poi finì a terra. Senza una ragione apparente, allora, Samina iniziò a piangere. Guzman udì i suoi gemiti, la vide abbandonarsi sconsolata sul ripiano colmo di boccette, barattoli e vasetti vari, che si struggeva senza pace. Ogni peso parve abbandonarlo di colpo mentre con uno scatto fulmineo si sollevò a scrutarla allarmato. «Che ti prende, Samina?» domandò. «Aiutami», mormorò lei di rimando, tra i singhiozzi che le scuotevano le spalle sottili, coperte appena dalla gran massa di capelli biondi. Oltre di lei, nello specchio, Guzman aveva scorto le sue mani aggraziate andare a coprire con tremenda disperazione gli occhi. Samina si era girata, gli aveva rivolto uno sguardo lucido e straziato, e l’aveva rincorso angosciata, lasciando che la sedia cadesse sul pavimento senza curarsi del rumore. Aveva allungato le dita a ricercare il suo contatto, annaspando come un naufrago che tenti in ogni modo di non soccombere alla marea nera e vorace, si era stretta a lui affondando il viso contro il suo petto, le lacrime calde trapassavano il tessuto della canotta bagnandogli la pelle. «Direttrice Samina!». «Aiutami, Guzman... Aiutami...». All’improvviso ogni distanza era stata rotta, squarciata, le loro mani erano venute a toccarsi e nell’eternità di quell’istante avrebbero continuato ad allacciarsi sempre più fino a collassare l‘una nell’altra disintegrandosi nello sforzo di unirsi, due corpi celesti dalla traiettoria imprecisa e masochista. Guzman non poté far altro che riversarsi su di lei, la accolse nelle proprie braccia, sentendola aggrapparsi con tutte le forze, per trattenerlo vicino e non lasciarlo fuggire. Samina piangeva e sembrava una bambina che avesse perso i genitori, sola di fronte al mondo e impotente. Egli le accarezzò i capelli – perché era quanto di più lontano potesse esserci da una bambina, e lo angosciava. Guzman sapeva dentro di sé cosa significasse essere soli e ripudiati da tutti. La udì gemere e forzare ancora la presa. Le disse all’orecchio che non se ne sarebbe andato – non l’avrebbe abbandonata come avevano fatto gli altri. Nello specchio c’erano le figure di un uomo e di una donna soli, che si venivano incontro e si cercavano. Nel percepire il modo in cui i loro corpi aderivano fra loro, per quanto possibile, a combaciare, Guzman percepì per la prima volta una sensazione diversa, che non era né devozione trascendentale, né desiderio carnale. Rimase ad ascoltarla, nel proprio animo, mentre dispiegava la sua cantilena, e aveva il profumo di Samina. Una nuvola profumata si levava dalla tazza che Guzman teneva nelle mani, appannando il vetro della finestra con il proprio calore. Si stava scaldando le dita a contatto con la ceramica rovente, mentre osservava la pioggia di fuori che perennemente ingrigiva le strade di Poh. Tuttavia, preso com’era dai pensieri, gli veniva troppo complicato focalizzarsi davvero su un dettaglio del paesaggio: allora i suoi occhi vagavano assorti come a ricercare qualcosa che tenesse desta la sua attenzione, ma inevitabilmente finiva sempre per distrarsi, e allora restava fermo a riposare la vista su un punto non ben determinato dell’orizzonte con lo sguardo assente, poggiandosi di spalla contro la parete, rannicchiato un po’ in sé stesso. Plumeria era seduta sul letto a gambe distese, di fronte a lui, gli stava parlando delle ultime scorribande compiute dalle reclute più giovani e di quanto ne andasse fiera, sebbene fosse ancora convinta dovessero imparare a darsi una regolata tra di loro. Piegata sopra i piedi, stava rifinendo minuziosamente un’unghia colorata con il pennellino. L’odore pungente delle boccette di smalto e di acetone aperte arrivava fin nelle narici di Guzman, ed egli avvertiva una leggera nausea, ma non sapeva se fosse per quel profumo acre o per la confusione che le sue riflessioni generavano in lui. Nel dubbio, di tanto in tanto beveva un sorso di Ciocco Skitty per schermarsi con l’aroma del cacao – al diavolo la confezione color confetto ricoperta di micetti amorosi, quell’ammasso di robaccia chimica e pieno di zuccheri era la fine del mondo –, l’assaporava sulla lingua facendo attenzione a non scottarsi. Tra i ricordi, rivide di sfuggita le mani di sua mamma mentre rigirava il cioccolato nel pentolino sopra il fuoco, l’odore dolce che si diffondeva in tutta casa. Guzman inspirò profondamente con il naso sopra il bordo della tazza, lasciandosi riempire il petto dal fumo caldo della bevanda, e riuscì per un istante a rievocare quello stesso profumo. Il discorso si era all’improvviso spostato, senza che se ne fosse accorto, sugli allenamenti di Iridio. Plumeria intanto aveva cambiato piede. Talvolta s’interrompeva per soffiare sopra la vernice e controllarne l’asciugatura. Poi tornava a intingere il pennellino e ricominciava a parlare. «Non vuole saperne di fare amicizia con gli altri», diceva «Continua a fare tutto di testa sua». Guzman sospirò. Ricordò il modo in cui il ragazzo lo aveva cacciato dal suo appartamento e a quanto il suo viso somigliasse terribilmente a quello di Samina. Si accorse che fino a quel momento non aveva fatto altro che pensare a lei incessantemente, e quando se ne rese del tutto conto si sentì in imbarazzo; eppure una strana calma sospesa e ovattata lo tratteneva ancora in una morsa leggera e rassicurante. «Senti, perché non provi a parlarci? Magari se sapesse che lavori per sua madre potrebbe aprirsi un po’». «Ci ho già provato, Plum. È inutile. E comunque lui non deve sapere nulla di questa storia, mi capisci? Sarebbe solo peggio». La ragazza intese. «È anche per lei che se n’è andato, non è vero?» chiese. Guzman annuì, poi si richiuse un’altra volta in quel silenzio distratto. All’improvviso, però: «Ci siamo dati un abbraccio, Plum», disse. Plumeria sollevò lo sguardo su di lui. Il suo viso si era acceso di un’espressione sorpresa nell’udire quel tono di voce così delicato, talmente estraneo a un uomo prepotente come era lui. «Diamine!» esclamò «Un abbraccio! Fa’ attenzione che se continua così rischi di rimanere incinto». Le sue labbra si erano curvate a schernirlo, ma nello stesso tempo le sopracciglia piegate in una riga severa sopra i suoi occhi tradivano una certa apprensione. «Ma la smetti di dire stronzate?». «Non sono stronzate. È quello che mi hanno detto oggi i più piccoletti: se dai un abbraccio a una ragazza potresti rimanere incinto. Senti, Guz, avevamo deciso che per queste cose io mi sarei occupata delle pischelle e tu dei pischelli, ma non mi pare ti ci stia impegnando molto. Guarda che non posso fare la sorella maggiore da sola. Voglio dire, non sono una madre». Se c’era una cosa che Guzman non avrebbe voluto ricordare in quel momento tanto intimo erano i suoi doveri di capo – fosse stato per lui, avrebbe volentieri tralasciato ogni obbligo che la sua figura gli imponeva, ma come al solito la scrupolosità di Plumeria riusciva sempre ad avere la meglio e a riscuoterlo dalla sua negligenza. La liquidò ripromettendole che se ne sarebbe occupato al più presto, lei disse che l’avrebbe proprio voluto vedere, allora lui dovette sforzarsi di essere più convincente e remissivo nei suoi confronti, abbassandosi all’adulazione più sfrenata, fino a che ella non ne fu soddisfatta: eppure, vedeva, i suoi occhi erano ancora socchiusi in un velo sospettoso. Si domandò se davvero le sue occupazioni alla Fondazione Æther lo stessero separando a tal punto dal gruppo come sembrava dalla preoccupazione impressa in quello sguardo. Ma ormai, sentiva, c’era dell’altro che lo richiamava lontano. «Il fatto è che io...», mormorò col cuore in mano, esitando nel dar sfogo ai pensieri. Plumeria si arrestò. Lo guardò. Una goccia di smalto cadde dal pennellino a macchiare le lenzuola bianche. «Io non credevo... Non pensavo che un uomo e una donna soli potessero provare anche questo».  Rieccoci qui, dopo più di un anno, finalmente con un nuovo aggiornamento per questa storia! Come sapete purtroppo sono una persona terribilmente lenta, ma questo mese mi sono messa d’impegno per cercare di tornare in carreggiata e sono davvero soddisfatta del risultato. Vi comunico che siamo giunti praticamente a metà! Il mio proposito (uno dei molti) per il 2020 è riuscire a finirla entro l’anno. Mi spiace averla portata così per le lunghe nonostante fosse una storia più breve del solito... È anche vero che nel frattempo ho scritto altro e non sono proprio rimasta con le mani in mano, e forse c’era anche bisogno che alcuni sentimenti si sedimentassero... Però direi che è giunto il momento di rimettercisi su più seriamente! La scena dell’abbraccio è il perno da cui è nata questa storia: è stato uno dei primissimi pezzi (se non il primo in assoluto) che ho steso. Ritornandoci sopra questo mese ho dovuto riscriverla quasi da capo perché a distanza di tempo non mi convinceva più. Spero vi sia piaciuta tanto quanto per me è importante ♥ Un ringraziamento speciale a Barbra, Afaneia e BlazePower per le loro recensioni al capitolo precedente e per aver messo la storia tra le seguite insieme a Lila May; a Danail, Erika_Harmonia7 e Vale_Balz per averla inserita tra le preferite; e infine ancora a Lila May per averla aggiunta alle ricordate. Grazie di cuore anche a tutti i lettori silenziosi che sono passati a dare un’occhiata! ♥ Un abbraccio forte forte, Persej |
Capitolo 4
*** Io, te e le mie Ultracreature ***
NOTA: Da questo capitolo in poi segnalo la presenza di tematiche delicate. Raccomando di fare attenzione. Buon proseguimento!
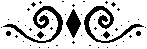 C a p i t o l o 4 : I o , t e e l e m i e U l t r a c r e a t u r e
«Ma poi, che diamine sarebbe un cicisbeo?».
Quando qualche giorno più tardi dopo l’avvenimento – non c’era minuto in cui egli non ripensasse a quell’abbraccio, alle spalle tremanti di lei, alle labbra rosse di pianto che premevano sul collo – Guzman aveva incontrato Vicio nei corridoi della fondazione, gli si era accanito contro con le braccia nerborute, lo aveva preso da parte e si erano rivolti l’uno all’altro cogli occhi piccoli e rabbiosi. «Che vuoi, razza di cicisbeo?» gli aveva detto quello sibilando tra i denti come una serpe. Guzman lo aveva afferrato un’altra volta per il colletto del camice e lo aveva minacciato che se si fosse permesso di infierire ancora nelle questioni private della direttrice lo avrebbe sbriciolato pezzo dopo pezzo con le proprie stesse mani. «Ti hanno beccato con una donna, eh, Guzman?». Iridio lo guardava con un sorrisetto insinuante, da ragazzino malizioso che già sapesse di certe cose, ed egli sentì la stizza fargli avvampare le guance. «Il grande Guzman non si fa beccare da nessuno! Come se gli interessassero le donne degli altri, poi...», ribatté; ma guardando ancora quella bocca fiera e quanto somigliasse a quella di Samina, il senso di colpa lo colse all’improvviso, e si zittì. Seduti uno accanto all’altro, il vento caldo scompigliava loro i capelli. Iridio era tornato dai suoi viaggi da Allenatore soltanto per una piccola sosta e per ritrovarsi con Plumeria, a cui non mancava mai di far avere un resoconto dei propri progressi: la presentazione al Picco Hokulani per la nuova prova era ormai una questione di giorni, e il Giro delle Isole procedeva senza intoppi. Guzman aveva intravisto la sua sagoma oltre le tende della finestra, si era sporto dalla ringhiera del balcone e l’aveva trovato acquattato più in alto su una sporgenza del tetto della mansarda, la Sfera di quel suo strano Pokémon stretta pensosamente nel pugno lasciato cadere tra le gambe incrociate. Era una mattina sorprendentemente limpida, quella; il che in una cittadina come Poh sarebbe stato di cattivo auspicio, se soltanto non avesse offerto quello splendido paesaggio tropicale, per una volta colorato e luminoso. Guzman dentro di sé lo credeva un qualche segno di svolta. «Un cavalier servente», puntualizzò Iridio, che rimaneva pur sempre un ragazzino istruito di buona famiglia «In passato era l’accompagnatore di una nobildonna quando il marito era assente. Spesso era anche il suo amante». «Il suo amante», ripeté Guzman. Certo, adesso era chiaro il motivo per cui Vicio avesse voluto fare quel paragone. La definizione pareva calzare fin troppo. «Però è buffo, sai? Chi te l’ha detto?». «E a te cosa importa?». «Proprio un bel nulla! Ma mi ricorda il modo di parlare di una persona che conoscevo». Sul suo viso di ragazzino cadde all’improvviso un’ombra cupa, gli occhi verdi si offuscarono come che le nuvole scure di Poh si fossero in realtà andate a nascondere nel suo sguardo e adesso volessero tornare a fare capolino, e tutto in lui portava il segno del tempo trascorso, di una maturità ancora acerba ma che di lì a poco avrebbe cominciato timidamente a manifestarsi. I cambiamenti dovevano aver travolto entrambi, pensava Guzman, mentre vedeva il Pokémon – l’affare – di Iridio uscire dalla Sfera e acquattarsi contro le sue ginocchia. Con una leggera sorpresa si accorse che la museruola che indossava si era scalfita in alcuni punti, e che certe giunture erano in procinto di spezzarsi. E dire che era stato clonato con l’esatto intento di resistere alla pressione degli Ultravarchi... Si chiese quanto tempo fosse effettivamente passato da quando aveva cominciato a lavorare per Samina. «Senti mai nostalgia di casa?». Iridio accarezzava il manto ibrido di Tipo Zero. Soffermandosi sul gesto lento con cui passava tra le piume del capo, Guzman percepì un brivido lungo la nuca, ed era il ricordo della mamma che gli pettinava i capelli prima di andare a dormire. «No», disse, e si mise ad arrotolare nel dito un ricciolo bianco che gli scendeva sulla fronte «Avevo poco più della tua età quando sono scappato. Non ci sono più tornato». «Neanch’io ci voglio tornare». Non sarebbe stato il caso, eppure Guzman lì per lì non riuscì a trattenere un sorriso. Da una parte questa piccola pulce pareva assomigliargli più di quanto potesse credere: gli sembrava di rivedersi, lì al suo fianco, con gli abiti stracciati da adolescente ribelle e Wimpod stretto in grembo. Perché quelli come Iridio non erano fatti per stare in gruppo, ma soli con sé stessi. Plumeria avrebbe potuto continuare a fare la sorella maggiore quanto voleva, ma questo alla fine non l’aveva capito – e tuttavia Guzman avrebbe mentito a sé stesso se avesse negato quanto anni addietro la sua compagnia gli fosse stata vitale. «Adesso ho due rivali, persino il nipote di Hala con me non può spuntarla, però...». «Fai tanto il duro, poi mi caschi così sul sentimentale! Com’è possibile?». «Guarda che ti ho visto prima che arrossivi a sentire che vuol dire cicisbeo! E sarei io il sentimentale!». Si raggomitolò dall’altro lato, affondando la testa nella pelliccia raggrinzita di Tipo Zero e ignorando le risate sguaiate di Guzman «Forse... Forse un po’ sì», mormorò poi, prima che l’altro potesse poggiargli il palmo sulla spalla a rabbonirlo. «Guzman, non mi è mai importato nulla di te. Sono entrato nel Team Skull soltanto per me stesso e per diventare forte. Plumeria è una buona ascoltatrice. Però, questa mattina, con te mi trovo bene. È che...». Guzman si chinò paterno verso di lui – paterno, che strana parola da attribuirgli, eppure in qualche modo percepì che non c’era altra maniera in cui potesse descrivere il suo stato d’animo apprensivo di fronte a quel ragazzino e al suo spaesamento, alla confusione che aveva suscitato a posteriori il distacco. «Ti manca tua sorella, non è così?» gli chiese. Iridio gli rese uno sguardo grande e incredulo. «Lylia», disse ancora Guzman. Lesse nella sua espressione quella sorpresa di quando inaspettatamente si viene capiti, e sentir pronunciare quel nome doveva avergli suscitato un qualche pensiero amorevole e lontano, perché Iridio si era ammutolito e stava con gli occhi lucidi a guardare davanti a sé; ma Guzman non fece caso al fatto che subito dopo quello stesso sguardo si fosse improvvisamente freddato. Aveva abbassato la guardia e non era stato abbastanza attento, inavvertitamente aveva lasciato la traccia di una trama che ancora non doveva essere svelata. Guardando l’orologio vide che si era fatta una certa ora, così si alzò sgranchendosi le ossa. «Beh», disse, facendo per avviarsi «adesso devo andare. Però aspetta, prima prendi un po’ di questi». Frugò nella tasca della felpa, e tornato indietro da Iridio gli mise nella mano quel che doveva dargli. «Visto che sai già tutto» puntualizzò, con un ghigno malizioso e furbo sulla bocca. Lui scostò un poco le dita e vedendo il contenuto avvampò d’imbarazzo, scandalizzato notò quanti altri ne avesse con sé nelle tasche. «Allora è vero che sei stato con una donna!» sbottò, balbettando dal nervosismo. «Se non li distribuisco tutti Plumeria mi ammazza» disse, e ancora, andando: «Oggi mi tocca!». Tornato ai piani inferiori Guzman si era diretto in tutta fretta verso la sala principale, e aprendo la porta si era ritrovato le reclute più giovani che già lo aspettavano, sedute per terra in circolo, coi visi serafici dei finti angioletti. La lavagna era tutta scarabocchiata di penini e vulvette, e pensò che Plumeria si sbagliasse, che in realtà quei marmocchi fossero molto più scaltri di loro, e più scaltri ancora persino di quanto erano stati loro da ragazzini; ma d’altra parte glielo aveva promesso, e comunque, dentro di sé, non poteva fare a meno di concordare, che dare un futuro a questi trovatelli senza destino pescati per strada volesse dire anche parlare di questo. Quindi andò, si sedette sulla cattedra, li scrutò uno ad uno: le facce piene di pustole, le ascelle pelose quanto quel po’ di peluria striminzita sopra il labbro che ostentavano in giro col nome di baffi, e poi Guzman si accorse dell’odore pungente che aleggiava tra loro – ma c’era passato anche lui nell’età dello sviluppo, c’era passato anche lui. Reprimendo l’impulso irresistibile di tapparsi il naso, chiese di far aprire le finestre e cominciò a raccontare la sua prima volta. Quando Plumeria entrò nella sua stanza lo ritrovò indaffarato a stirare. Si appoggiò alla porta e a braccia conserte restò a fissarlo, con le labbra che già s’incurvavano in una smorfia scettica. «Li hai distribuiti tutti?» fece, inquisitoria, sollevando un sopracciglio. «Tutti quanti, uno per uno», rispose, facendo vaporizzare il ferro da stiro. «E quelli?» incalzò, indicando il tavolo dove stava ancora un mucchietto cospicuo di preservativi. «Quelli?» ripeté, ripiegando una maglietta e buttandola con noncuranza nell’armadio «Quelli sono per me». Plumeria gli diede uno scappellotto sulla nuca e Guzman se la sghignazzò sotto i baffi. «Ho sequestrato altre bottiglie. Te le metto qui nella libreria come al solito». «Ma non sarai un po’ troppo severa? Secondo me dovresti lasciarli divertire, ogni tanto. Un goccio che potrà mai fare?». «Lo sai che sono la prima a bere quando c’è da divertirsi, ma io di dovermi sorbire il ragazzino che sbratta già alle dieci di mattina non ne voglio sapere. Se vuoi pensarci tu a tenergli ferma la testa sul cesso, prego, fai pure». C’era sempre una nota di aggressività, quando Plumeria e Guzman dovevano rinfacciarsi le cose, e a volte accadeva che si spingessero talmente in là da prendere gusto a litigare, e passavano le ore, anche i giorni, a lanciarsi le frecciatine più subdole. Vi era quasi una sorta di piacere nel dimostrarsi capaci l’un l’altra di predominarsi insieme a vicenda. Tuttavia, non si prendevano mai troppo sul serio, e quella sfida assumeva il carattere di un gioco: talvolta, per farla finita, ingaggiavano uno scontro di fronte alla villa, il giardino decadente si trasformava nell’arena predisposta alla lotta tra Salazzle e Golisopod, e Poh si riempiva di frotte di reclute accanite sia all’una che all’altra fazione. Ma negli ultimi tempi, i loro diverbi si erano fatti più reali, concreti. Non era questo il caso; tuttavia, da quando Guzman aveva iniziato ad assentarsi per le sue mansioni alla Fondazione Æther, certi discorsi avevano preso una piega più profonda, consapevole, anche nel confessarsi i sentimenti più semplici – la sincerità con cui aveva ammesso di essere attratto da Samina era ormai la premessa a qualsiasi preambolo, l’impulso allo svisceramento più interiore, un pezzo alla volta. «Sai che però alla fine mi sono divertito?» disse a un tratto Guzman, intanto che Plumeria risistemava il letto e scuoteva i cuscini. «Mi sembrava una cosa così noiosa... Invece stavano tutti attenti a sentire cosa dicevo, e mi facevano le domande...». «Vorrei che questi ragazzi crescessero consapevoli, e non succubi della loro sessualità. Sono contenta che alla fine ti sia deciso». «Già. Avevi ragione tu». «Cosa gli hai raccontato?». Plumeria stava accovacciata sul letto, e Guzman si girò un istante a guardarla, scivolando con gli occhi sulle sue dita che allisciavano la trapunta. «Nulla di che», disse, e nascondeva un sorriso nel vapore del ferro. Era un bel quadro quello che si era venuto formando questa mattina, e Guzman si sentiva ancor più di buonumore nelle sue faccende domestiche – una volta non ci si sarebbe dedicato nemmeno, e invece eccolo, dopo una manciata di mesi, a fare il casalingo. Vide che gli rimanevano ancora poche altre magliette, così si affrettò a concludere, sebbene in realtà non avesse impegni né programmi per quella giornata. «Mi pare di capire che tu e la signora ci date dentro», riemerse a un tratto la voce di Plumeria, che ancora guardava il tavolo. Guzman vide che stava sorridendo, e all’improvviso si sentì in imbarazzo. Scosse la testa, ripensando alla questione degli amanti e dei cicisbei. «Oh, no», disse, e lo scherzo era finito «No, lei non mi sembra il tipo... E poi non mi pare neanche il caso». Mentre rimetteva a posto le ultime magliette, per qualche ragione le sue dita avevano cominciato a esitare, e Guzman restò per molto tempo di fronte all’armadio aperto, per nascondere il viso da lei. «A proposito», disse, cambiando argomento, ma senza allontanarsene troppo, «Ho parlato con Iridio, prima. Si è confidato con me». Plumeria accolse sorpresa quella notizia. Tuttavia ne sembrava contenta. «Non gliel’hai detto, però». «Non gliel’ho detto». Guzman richiuse l’armadio e andò a mettere in ordine l’asse da stiro. Diede un’occhiata alla stanza pensando a cos’altro avrebbe potuto fare. Dalla finestra entrava un profumo caldo, piacevole, e il modo in cui la luce illuminava quello spazio raccolto gl’infondeva fiducia per quel che sarebbe venuto dopo e che aspettava speranzoso di scoprire. Sul pavimento, i Cristalli Z sparsi fuori dalla cassa dove li custodiva gelosamente scintillavano al chiarore del sole. Si chinò a raccoglierli, e nei ricordi tornò vagamente l’ardore iracondo che lo aveva colto quando li aveva rubati tutti per ripicca sotto gli occhi di Hala, quando si era opposto alla sua nomina a Capitano di tipo Coleottero. Ne strinse uno nella mano, sentendo il cristallo rovente bruciare nel palmo. Non voleva rovinarsi così la giornata, assillato dai ricordi. Ci si abbandonava troppo spesso, e una volta dentro uscirne gli costava una fatica immane, quando e se vi riusciva, perché sempre in ogni caso una voce rimaneva in un angolo della testa e continuava a raccontare, a riavvolgere il nastro del dolore passato e lui restava passivamente ad ascoltarlo. Plumeria gli chiese se sarebbe andato da lei più tardi. Guzman rispose che non lo sapeva. «Perché non vai a guardare un po’ gli allenamenti dei ragazzi?» gli propose allora, «È da molto che non lo fai. Sono sicura che lo apprezzerebbero. Oggi si riunivano al Giardino di Malie, mi hanno detto che volevano catturare qualche insetto». Abbandonando a terra i cristalli, Guzman pensò che fosse una buona idea. Malie lo accolse al suo arrivo sotto l’ombra dei grandi palazzi orientaleggianti. In lontananza brulicava il chiacchiericcio della gente al mercato; oltre quelle voci vi era soltanto il fruscio dei rami al vento e il borbottio dei Toucannon assiepati tra le foglie. Guzman passeggiava con le mani affondate nelle tasche, osservando la calma a lui così estranea di quella città. Impigrito dall’aria calda di quella mattina assolata, socchiudeva di tanto in tanto gli occhi e li riapriva al suono dei campanacci di vetro che tintinnavano nelle verande dei negozi. In quella sensazione sonnolenta lo colse a un tratto una visione allucinante, cui però ormai si era abituato, e senza far caso alla grande medusa bianca che ondeggiava, levitando, dall’altro capo del marciapiede, Guzman aveva continuato ad andare per la sua strada. Il senso di straniamento delle prime volte lo aveva quasi del tutto abbandonato, e quella visione terrificante e assurda si permeava dell’indifferenza della quotidianità. La creatura avanzava, con i tentacoli che si scuotevano nel vento, maestosa e imperturbabile. Dalla sua bocca risuonò un verso stridulo e acuto, simile a uno scampanellio, e allora dalle sue fauci sbucò fuori una piccola sfera fluttuante, luminosa dei colori violacei del crepuscolo. Soltanto allora Guzman si accorse che i tentacoli erano braccia di bambina, nascoste dietro lunghi capelli biondi sciolti in tante ciocche. Terribilmente simile a Samina, una sua miniatura – Lylia. La riconobbe, ricordandosi della fotografia che Samina gli aveva mostrato. Subito si mise in allerta, scrutandola che si allontanava furtiva stringendo forte la tracolla. La creatura che aveva infilato nella borsa doveva trattarsi senza dubbio di Cosmog, il Pokémon che avrebbe aperto l’Ultravarco. Guzman si chiese se la ragazzina fosse sola. Cercò attorno qualcuno che l’accompagnasse. Non c’era nessuno: soltanto lei e Cosmog. L’occasione si presentava perfetta. Senza pensarci un istante la seguì, dimenticandosi dei compagni. Già si prefigurava la gioia di Samina, il compenso che gli avrebbe dato nel momento in cui le avrebbe fatto sapere che la missione era compiuta, e che l’aveva portata a termine da solo. Lylia si stava dirigendo verso la biblioteca. Guzman entrò, ignorando gli sguardi dei bibliotecari che sorpresi di vederlo in un posto del genere lo fissavano insistenti. Nascondendosi dietro le librerie, osservava la ragazzina spingersi sulle punte dei piedi a raggiungere gli scaffali più alti e a scrutare i dorsi dei libri – era così piccina e aggraziata, mentre cercava di fare tutto da sé senza l’aiuto degli altri, tanto quanto sua madre quando metteva a posto le credenze e gli armadi, gli oggetti, i soprammobili. Vagava tra le sezioni come in cerca di qualcosa che già sapesse, ma che non riuscisse a trovare. Non soddisfatta, Lylia salì al piano superiore. Guzman le andò dietro. Raramente era stato in una biblioteca, e quelle poche volte doveva esserci andato perché costretto, nel periodo della scuola. Questo silenzio aveva per lui un che d’innaturale, una calma assorta in cui non era in grado di rispecchiarsi. Ed era difficile seguire le orme della bambina senza dare nell’occhio, mentre gli altri erano seduti e ogni minimo rumore che non fosse lo sfogliare delle pagine destava attenzione. Lylia passava in rassegna una libreria dopo l’altra; ma poi eccola decidersi: prese un libro nelle mani e lesse attentamente il titolo, fece scorrere rapidamente un dito sulla copertina. La borsa trillò, ed ella sussultò, si piegò su di essa ad aprirne una tasca e il suo visetto si arricciò in una smorfia arrabbiata mentre si portava l’indice sulle labbra a fare cenno di silenzio. Il Pokémon – o un’Ultracreatura, ma che differenza faceva? – doveva essere così esaltato da quel posto che probabilmente gli era nuovo che provò a uscire fuori e Lylia si sbrigò a ricacciarlo dentro. Quando si guardò intorno ad assicurarsi che nessuno l’avesse vista, Guzman quasi rischiò di essere scoperto. Nel vederla allontanarsi a cercare un posto dove mettersi a leggere tirò un sospiro di sollievo, allora arraffò un libro a caso e si sedette anche lui a qualche tavolo di distanza, in modo che potesse controllarla e avere una buona visione della stanza nel suo insieme. Aprì il libro. Prese a sfogliarlo con noncuranza, soltanto per dare l’impressione di essere impegnato nella lettura. Sulla pagina che gli si mostrò trovò un’illustrazione di un uomo dagli abiti antichi. Si soffermò a guardarla, e quel parrucchino era semplicemente ridicolo. E quello era forse rossetto? Un cicisbeo, lesse nella didascalia. Questo? Il modello che Vicio gli aveva affibbiato era questo? Il cavalier servitore, o come si chiamava – un effemminato, un travestito! Eppure, lasciando cadere gli occhi sulle righe a leggere qualche parola si ritrovò inaspettatamente coinvolto. La storia di un marito disperso per mare e della moglie che nell’attesa del suo ritorno si legava a un altro uomo aveva degli inequivocabili punti di contatto con ciò che Guzman stava vivendo in quel momento. Si vedeva lui, senza corpo e senza volto, navigare attraverso gli Ultravarchi, e l’universo era un oceano, le stelle isolotti lontani. Finì a tal punto a rispecchiarcisi che si spinse oltre come che tra le pagine vi fosse scritto per similitudine il suo stesso destino, e si scordò momentaneamente del motivo per cui era lì. Abbassò un poco il libro a scrutare di nuovo la ragazzina, ma dovette fare appello a tutta la sua buona volontà per non imprecare nel momento in cui si accorse che il suo posto era vuoto e che il tomo era stato messo in ordine sul carrello. Allora si alzò di scatto, abbandonò la lettura a metà spiegazzando le pagine nello slancio di allontanarsi il più in fretta possibile, e rendendosi conto che ormai Lylia non era più nei paraggi corse di filato a scendere le scale, spintonando i bibliotecari mentre si gettava ad aprire le porte per poter uscire. Guardò attorno esaminando ogni angolo della strada – non poteva essere tanto distante, come aveva potuto lasciarsela sfuggire in un modo così stupido? – ma inutilmente, e intanto il terrore del fallimento cresceva, l’abbraccio di Samina si allentava, col fiato mozzato si spinse verso il Giardino di Malie a cercare rinforzo nei suoi, riapparsi di colpo nei pensieri. L’erba alta si attorcigliava alle gambe, Guzman si dimenava tra gli arbusti per farsi strada mentre sollevando lo sguardo aguzzava gli occhi a ricercare gli scagnozzi, nascosti chissà dove ad allenarsi. Non poteva nemmeno contare di udire il loro solito schiamazzo, perché la calma del giardino attutiva qualunque rumore, e persino il suono dei suoi stessi passi gli giungeva ovattato quando calpestava la terra bruna, soda, umida. Più avanzava, più si ritrovava smarrito, più allo stesso tempo si sentiva di star sprecando del tempo prezioso e che non sarebbe più riuscito a recuperare la ragazzina. Fu tentato di chiamare a sé Golisopod e Masquerain per farsi aiutare nella ricerca. Stava per mettere mano alle Poké Ball quando all’improvviso un’ombra, una sagoma bianca apparve tra la vegetazione. Eccola, era forse lei, col suo vestitino? Guzman tese l’orecchio, in allerta e camuffato in mezzo alle grandi foglie verdi, riparato dalle pesanti ragnatele dei Pokémon Coleottero. Era pronto a gettarsi da solo ad acciuffare la preda, i muscoli delle braccia già si contraevano in un’anticipazione dura a trattenersi. I passi si avvicinavano, con un fruscio rapido e secco lungo l’erba, il bagliore luminoso di quegli abiti chiari si faceva sempre più intenso all’orizzonte. Ecco però che, concentrandosi sull’incedere di quella camminata, Guzman cominciò a un tratto a irrigidirsi – una camminata familiare, la conosceva; nell’attutimento della vegetazione rimbombava nelle orecchie caricandosi di tutto l’astio che aveva soffocato negli anni. Sotto un acero giapponese apparve così, preannunciata dalla sua ombra strisciante lungo la superfice del tronco, la figura slanciata di Kukui, col petto solido e nudo oltre il camice aperto. Guzman agitò prepotente un polso liberandosi dalla morsa robusta in cui uno Spinarak lo aveva intrappolato tessendovi sottilmente la sua tela attorno, con gli occhi si spinse a indagare la fisionomia pompata di lui, odiosa, indecente. Il disagio che quella vista gli suscitò, traboccante di disprezzo, gli diede alla testa, i ricordi presero rapidamente posto offuscando l’immagine della bambina, il suo proposito ultimo – non bastò neppure il tentativo di aggrapparsi al pensiero di Samina, alla sua ricompensa. Invece ebbe la meglio il rancore per il passato, e quindi con uno scatto rabbioso venne allo scoperto, si arrestò in mezzo al sentiero bloccandogli ogni via di fuga, che voleva lo scontro, l’inevitabile resa dei conti. «Kukui!». Non appena Kukui si voltò, Guzman venne colpito dalla possenza del suo corpo bruno, baciato dal sole – sebbene anche Guzman fosse di carnagione abbastanza scura, accanto a lui era sempre sembrato così pallido, insipido. Si sentiva risucchiato da quell’ammasso di muscoli scolpiti nella carne. Dinnanzi alla sua virilità si scopriva un’altra volta impotente, perché Kukui era sempre stato più di lui in tutto, e non ci sarebbe stato verso che l’avrebbe mai lontanamente neppure raggiunto. Questo pensava, mentre lo guardava, e Kukui a sua volta si lasciava scoprire dai suoi occhi, sebbene non ci fosse nulla da svelare. Guzman aveva sempre detestato quell’autocompiacimento, la palese consapevolezza del proprio valore che mostrava impressa nel fisico. Guzman odiava quel corpo, perché gli ricordava tutto ciò che lui non era; l'intera sua vita si era declinata in piena antitesi di ciò in cui Kukui si definiva. Soltanto una cosa avevano condiviso, ed era stata l’essere stati rifiutati entrambi come Capitani. Per il resto avevano costituito due mondi a parte, disgiunti in tutto e per tutto. Ma adesso, che disdetta!, non potevano più riconoscersi nemmeno in quello, perché Kukui era andato avanti e con la mente già pensava alla Lega – perché, perché persino a parole, e nelle idee, doveva superarlo? Non poteva accontentarsi di quel che aveva già ottenuto? Per quale motivo ostinarsi ancora a sminuirlo, perché fargli questa violenza? Rimani dove sei Kukui, non posso controllarti, non posso controllare la superiorità che tu hai su di me. Ribatté – misera protezione, maschera d’invidia, di disagio incolmabile – che una Lega Pokémon sarebbe stata del tutto vana, perché già era palese chi fosse l’Allenatore più forte di Alola, e già con la mano si sosteneva a Golisopod, prefigurandosi lo scontro, la vendetta dell’umiliazione. Intorno si era fatta la folla. Guzman si nutriva di quegli occhi che lo fissavano catalizzando la loro attenzione, e rincarava la dose a istigare Kukui – almeno in questo assecondami, obbediscimi!, gridava dentro di sé. Ma al suo posto si fece avanti un ragazzino, scialbo quanto il Decidueye che aveva con sé. «Non hai le palle, Kukui! Non hai le palle!». Guzman si ritirò alla Residenza Æther, unico luogo dove potesse rintanarsi, nascosto dal mondo, e rendersi irraggiungibile. Preso dalla rabbia per quell’incontro che aveva avuto e che non riusciva a togliersi dalla mente, si sfogava insieme a Golisopod nel piazzale bianco, intanto che Samina si dedicava alle sue faccende in casa. Si era talmente angosciato per quell’evento inaspettato che alla fine aveva perso la ragione e durante lo scontro con Sun si era lasciato sconfiggere con una facilità inaudita, sotto lo sguardo strafottente di Kukui – il suo sorriso bianco e odioso, da uomo preciso e superiore, buono, pungeva come un ago negli occhi ancora adesso soltanto a ripensarci, era il dardo infuocato che Decidueye aveva scagliato nell’armatura di Golisopod. L’umiliazione ritortaglisi addosso bruciava con una violenza che gli faceva scuotere le braccia mentre ordinava al suo Pokémon di rafforzare un attacco, e si accaniva, con la voce e con le membra, a performare quest’odio, l’amarezza invalicabile dell’ennesima prova di essere di fronte a lui inadeguato, misero, perdente. Il cielo aveva preso lentamente a oscurarsi e aveva cominciato a piovere. Non se n’era accorto neppure, tanto era preso a gridare e ricambiare le urla velenose di Golisopod, la furia inviperita con cui sferzava i colpi brandendo i pungiglioni affilati nella tempesta. Samina era uscita correndo a richiamarlo dentro, e soltanto al suono della sua voce Guzman si ridestò. Voltandosi, la guardò avvicinarsi con quell’espressione apprensiva del viso: teneva un panno nelle dita, e subito non appena gli fu di fronte cominciò a passarlo sulle sue guance bagnate, tra i ciuffi di capelli davanti agli occhi. Sentì un lieve calore diffondersi lì dove lei esitava, con delicatezza materna, ad asciugare le gocce di pioggia che scivolavano di continuo sulla pelle oltre le falde del cappuccio. Avrebbe potuto dare la colpa del proprio rossore al freddo o alla fatica, ma non ci sarebbe stato motivo di sprecare la voce per chiarire qualcosa di talmente palese. Erano di nuovo racchiusi l’un l’altra in un abbraccio di quelli silenziosi, che li legava assieme seppure distanti, senza che si cingessero. Samina sorrideva, e anche Guzman, con le labbra storte e screpolate; la seguì oltre il portone dopo aver richiamato Golisopod nella Sfera. Seduto al tavolo della cucina con le gambe scomposte, le andava dietro con gli occhi mentre prendeva il bollitore dalla credenza e lo riempiva d’acqua. Una volta acceso il fuoco, Samina si sedette al suo fianco e di nuovo lo accarezzò tra le ciocche umide. «Faresti meglio a cambiarti», gli disse. «Non ho altro da mettere», fece lui di rimando scrollando le spalle. «È proprio vero che a Poh non ci sei mai stata...» aggiunse poi, affilando le labbra in un sorrisetto beffardo. «No, in effetti no», confessò, allontanando la mano. Guzman pensò che ce l’avrebbe portata volentieri. Insieme a lui non avrebbe dovuto temere nulla, sarebbe stato la sua guida e le avrebbe mostrato le stanze della Villa Losca. Poh non brillava certo quanto ad attrazione turistica, ma col passare degli anni aveva scoperto certi scorci suggestivi, piacevoli nascondigli in cui appostarsi il tempo di qualche ora, e poi la vista dal tetto valeva sempre la pena di quella scalata pericolante, la corsa tra le finestre e i balconi – e qui riapparve davanti ai suoi occhi la sagoma di Iridio stagliata contro il cielo azzurro e i capelli al vento. Samina avrebbe dovuto fare a meno dei tacchi, ma in ogni caso ci sarebbe stato lui dietro a sorreggerla, a evitarle di cadere. Covò per un po’ quella fantasia, arricchendola sempre di nuovi dettagli: le avrebbe preso un ombrellino per ripararla dalla pioggia, magari per coprirla le avrebbe anche dato la sua felpa, si sarebbe chinato a richiudergliela sul petto e poi... Il fischio acuto del bollitore lo riportò bruscamente alla realtà. Samina stava ancora al suo fianco, seduta in silenzio, come non si fosse accorta del rumore. Con voce bassa, all’improvviso, meditabonda, disse: «Forse... Forse ho qualcosa che potrebbe starti». Il percorso che li separava dalla stanza da letto divenne per qualche motivo fonte di turbamento. I tacchi di Samina incedevano con passo svelto lungo il corridoio, e Guzman percepì nei suoi passi un’agitazione febbrile, quasi incontenibile. Provò a dissuaderla, che non ce n’era bisogno, ma ella procedeva spedita, oltrepassando una porta dopo l’altra, come ubbidendo a un istinto che la richiamasse cui non potesse fare a meno di rispondere. Intanto un disagio meschino cominciava a palpitare dentro di lui, facendogli aggrottare le spalle. Il cigolio dell’armadio che subito dopo andarono ad aprire stridette sgradevole nelle orecchie di Guzman, e nel buio in cui erano rimasti poiché nella fretta Samina non si era curata di accendere la luce vibrò tutt’attorno di un tono inquietante. Dalla finestra riverberava appena il grigiore plumbeo di quel pomeriggio tempestoso, contro i vetri picchiavano le gocce di pioggia e in lontananza gorgogliava lo scroscio dell’acqua riversa sui pavimenti marmorei dei giardini grandiosi e ormai solitari – una residenza enorme, e dentro c’erano soltanto loro. Ella rovistava tra gli abiti con una premura inconsueta, esaminando stoffe e bottoni: Guzman attendeva paziente, ma nell’animo già sapeva, intuiva il perché di quei vestiti, come mai fossero ancora lì, intrecciati alle sue dita, e la riprova era in quelle stesse mani, nel desiderio sofferto che le agitava scorrendo da una manica all’altra. L’evidenza bruciò nel petto con una violenza disarmante, nel momento in cui Samina estrasse la gruccia su cui stava appesa una camicia bianca, immacolata, maschile. Nell’afferrarla, egli tentennò, e avrebbe avuto tutte le ragioni di sottrarsi; invece subì senza neppure tentare la ribellione. Samina lo lasciò solo, libero di cambiarsi, e richiuse la porta. A Guzman non rimase altro da fare che assecondarla. Si spogliò un pezzo alla volta, indugiando nel sentire la pelle ancora bagnata scoprirsi e rabbrividire per il freddo. Guardava nello specchio il proprio corpo nudo, e dietro di lui c’era il letto di Samina, che pareva fissarlo come a lanciargli una sfida. Sulla sedia della toeletta lo aspettava la camicia di lui, dell’altro, ripiegata in ordine sul cuscino. I vestiti gli stavano larghi. Dedusse quindi ch’egli dovesse essere stato di corporatura robusta, forse anche più alto – subito la mente tornò a Kukui e al suo torace scoperto, insormontabile – e sebbene una tale differenza da un lato lo consolasse, dall’altro se ne sentiva irrimediabilmente soggiogato, perché con troppa fatica le sue braccia tentavano di sbucare dalle maniche, e i polsi erano fin troppo sottili per coprire la sagoma tracciata dal tessuto: sovrapporsi a quelle forme risultava impossibile, e la sua schiena appariva insolitamente fragile avvolta in quelle pieghe larghe, infinite. Allo stesso tempo pensava di non essersi mai visto così elegante: un senso di straniamento lo avvinse alla testa, vertiginoso e martellante. Giunto in salotto, Samina gli allisciò gli abiti allungandosi con le dita a tracciare i contorni delle sue spalle. Scivolava lungo il petto a disfare e richiudere meglio i bottoni, il colletto, saggiava la forma delle sue braccia. Si era acquietata. La tavola era già stata apparecchiata, il tè servito nelle tazze. «Va meglio, vero? Vieni a scaldarti», disse, indicandogli il divano. Guzman sedette, che non riusciva a tenersi in piedi. Si aspettava di potersi riposare un istante accanto a lei, di porre in sua presenza un rimedio a quell’ansia insopportabile. Samina invece andò ad acquattarsi dietro di lui, con una spazzola cominciò a pettinargli i capelli. «Perché...». «Lascia fare, ti prego». Le sue dita passavano leggere a districare i riccioli bianchi, e Guzman le sentiva sfiorare di tanto in tanto la punta delle orecchie. Ogni volta che si posavano sulle tempie percepiva un’esitazione sottile farle tremare incerte a contatto con la sua pelle: una scintilla eccitata lo invadeva a ogni minimo contatto. Le tazze rimasero intoccate. Un banale pretesto per entrambi. Il disagio lentamente scomparve, come che dalle mani di Samina stillasse un balsamo dolce e rilassante. Guzman si dava tutto a lei e alle sue cure, senza imbarazzo. Il corpo traeva giovamento dal calore che si diffondeva dai vestiti asciutti, e la loro larghezza si avvolse gradualmente a coprirlo, come un grande lenzuolo che Samina veniva a rimboccare di tanto in tanto. «Hai questi bei capelli corvini», disse lei, e suonava sincera, ma c’era una nota di rammarico nella sua voce «Se continui a schiarirteli in questo modo si rovineranno. È un peccato». A quel rimprovero, i pensieri di Guzman si riavvolsero inavvertitamente a rendergli il frammento di un periodo lontano, risalente agli anni dell’adolescenza, e rivide sé stesso di fronte allo specchio con lo sguardo perso mentre stringeva in una mano la bottiglia di ossigeno, indeciso su cosa fare, e nell’altra le forbici. Un senso di pesantezza lo oppresse in tutto il corpo, ma bastò una carezza di Samina a distoglierlo dai ricordi, e allora reclinò stancamente la testa contro il suo petto, consolandosi nel suo calore – quegli anni terribili apparivano di colpo così lontani, adesso, protetto nell’abbraccio di lei. Si lasciò cadere in silenzio ancor più profondamente tra le sue braccia che scendevano a sfiorargli il torace, fino a scomparire nel candore sonnolento di quella sensazione. «Sei tanto buona con me, Samina», sussurrò, che era così vicina. Su una mensola stava la fotografia di Lylia. Seguiva poi quella di Iridio, e accanto ad entrambe un’ultima cornice, abbassata a celarne lo sguardo. «Ma tu cos’è che hai visto in me?» le chiese. «Ho visto...» rispose, e gli disse all’orecchio che uomo forte lo considerasse, la potenza scellerata disposta a tutto pur di farsi valere, «La predisposizione al sacrificio, l’impegno...». Dal beccuccio della brocca del latte pendeva una goccia bianca. Samina propose di andare a riposare. Il maltempo imperversava ancora di fuori e non c’era molto altro che potessero fare. Guzman era rimasto ad ascoltarla estasiato, come un bambino che si acquieti a sentire il parlottio conciliante della madre prima di addormentarsi, le parole più dolci, i ti voglio bene, le fiabe fantastiche. «Riposiamo», ripeté lei accennando ad andare in stanza. «Posso rimanere qui», provò a resistere lui. Ma lei lo guardava con quegl’occhi verdi inebrianti, irresistibili, che un semplice no sarebbe stato pari a un affronto. «Vieni». Un ordine camuffato da preghiera, ma Guzman ormai era troppo affascinato per rendersene conto. Si alzò, abbandonò le Poké Ball sul tavolo lasciandole oscillare sopra la tovaglia ricamata, e la seguì. Non riusciva a decifrare che cosa provasse, mentre le andava dietro, completamente avvinto a quell’influenza che esercitava su di lui. Non poteva ignorare l’eccitazione che ancora una volta si dimostrava in grado di suscitargli, né il caldo soffocante che si diffondeva lungo ogni centimetro di pelle e che gli faceva sudare i palmi delle mani. Mentre chiedeva a Clefairy d’intonare il suo canto, Samina allungò le braccia ad accogliere Guzman contro il proprio seno. Egli si abbandonò a lei, a quelle dita languide che lo attiravano, e si stesero insieme sul letto. Sospirò, colto da un lieve torpore, cullato dalle carezze di lei, che si spingeva a tastargli le spalle e la schiena come a volerselo tenere, così gli sembrava, ancora più vicino nel sonno. E tutta serena Samina si addormentò. Dormire, semplicemente dormire. Se lo impose mentre sentiva allacciato a sé il suo corpo, esitando con la mano poggiata sopra il suo ventre caldo, e poi il suo petto morbido, coi piccoli seni su cui riposava la fronte stanca. Si abbandonò a qualche fantasia, e forse era l’influenza di quei discorsi che aveva fatto ai ragazzi la mattina stessa, la carnalità, l’origine della vita, i misteri inspiegabili dell’esistenza. Tutto si mischiava confusamente intanto che scivolava anche lui lentamente nel sonno, al suono della voce melodiosa di Clefairy. Ma il respiro di Samina lo teneva perennemente in allerta, non riusciva a staccarsene, e lo sentiva sfiorargli i capelli, lì dove esitava la sua mano molle – avvolto completamente in lei, nelle sue spire accoglienti. Guzman permaneva accanto al calore di quel corpo, così vicino, attaccato al suo, e lo percepiva pulsare nelle proprie braccia, nelle proprie mani. Lo colse, mentre scorreva le dita ancora sul suo ventre, il pensiero della nascita, del venire al mondo, e si chiese se questo sentimento assonnato, calmo, che lui provava, fosse rinascita e morte, e non riusciva a scindere le due cose. Perché Samina era per lui promessa di futuro e allo stesso tempo destino tormentoso, un’eterna afflizione. Il conforto di essere riconosciuto da lei suo pari rimaneva per lui una rassicurazione insperata. Udiva ancora la sua voce che soffiava dentro l’orecchio, le adulazioni, e il sentire nuovamente nella memoria la sua bocca sfiorarlo lo eccitò. Ma il sentimento che provava per lei non poteva abbassarsi a mero impulso, poiché lo sentiva migliore, pulito, candido. Una casta adorazione sensuale, per quanto assurdo fosse – non si era mai sentito così prima d’ora, ed era paradossale che proprio lui, uomo rabbioso, appassionato, non si potesse prestare all’atto fisico e che lo considerasse perverso. Samina era icona che non si potesse macchiare, e doveva rimanere intatta nella sua castità effimera. E darsi tutto a lei, votare il suo cuore a questo suo amore che incuteva soggezione era suo piacere e rifugio, distacco dal mondo opprimente. Samina gli aveva ridato in questo modo la vita, il senso dell’esistenza. A lui sarebbe bastato soltanto un bacio, tutto quel che desiderava era un bacio, a sugellare il sacrificio, l’unione a lei. Sollevò un poco il busto per poterla guardare. Le scostò una ciocca di capelli dal viso, poi, trattenendo il respiro, si chinò quatto quatto sulla sua bocca. Le loro labbra stavano appena per toccarsi, quando una sensazione viscida e angosciante lo bloccò all’improvviso. Nello specchio, Guzman vedeva sé stesso ripiegato con desiderio sopra il corpo di lei, poco più in basso le loro gambe intrecciate in una spirale voluttuosa. E lui come un travestito indossava gli abiti di Paver. Nello specchio c’erano le figure di un uomo e di una donna soli, ma il posto che lui ricopriva non poteva essere il suo. Preso dal terrore si scostò da lei. Clefairy sonnecchiava nella sua cuccia, senza accorgersi di nulla. Come un indemoniato Guzman cominciò a togliersi i vestiti, con le dita che tremavano nel timore di essere scoperto, ma ancor di più della violenza che sentiva di aver subito in qualche modo, e tornava ad agitarsi in quegli abiti larghi, infiniti, di cui non riusciva a trovare l’orlo per venirne fuori. Nella foga di rispogliarsi da capo un’altra volta, l’immagine che adesso gli restituiva lo specchio lo attanagliava con una crudeltà inaudita – Samina dormiva, inconsapevole, col viso beato avvolto nelle coperte, mentre lui seminudo fuggiva: scenario che si sarebbe ben potuto accostare ad altri eventi, ad altri momenti. Si disse, nelle settimane seguenti, di aver inteso tutto male e che il disagio che aveva provato doveva essere colpa sua, una suggestione, perché per un istante aveva ceduto a qualcosa di illecito. Al suo ritorno Samina lo riaccolse con il sorriso, e non si adirò quando Guzman le confessò di averle omesso di aver visto Lylia e Cosmog e di esserseli lasciati sfuggire. Gli aveva risposto con la sua solita amabilità, un’amabilità però ora a tratti coercitiva, poiché nei suoi gesti non traspariva più la dolcezza con cui nei giorni precedenti lo aveva cullato. Era tornata la donna fredda della prima notte in cui si erano incontrati, con quell’aria sadica, che tuttavia in qualche modo, forse nel timore ch’egli provava di poter perdere il suo affetto per sempre, lo legava ancor più strettamente a lei, attraendolo in un legame morboso, ossessivo. «Avevi detto che non mi avresti abbandonata, e invece anche tu ti sei sottratto al mio amore!» gli diceva, e lui si chinava ai suoi piedi implorando il suo perdono e le baciava le gambe, compiacendosi di quella sottomissione cui lei lo obbligava. Il fatto che sapesse perfettamente come irretirlo al proprio comando gli suscitava un piacere malsano, e il senso di potenza di questa donna lo affascinava sempre di più, si crogiolava in quel sentimento capriccioso passando dalla gioia più intima quando Samina lo lodava, al tormento più opprimente quando invece lo umiliava. Teneva il suo cuore nelle dita e Guzman le permetteva di farne quel che voleva. Quando Plumeria era venuta a sapere di questo nuovo atteggiamento si era improvvisamente allarmata e aveva cercato di fargli aprire gli occhi, puntualizzando tutti i dubbi che fino a quel momento aveva avuto e che ora trovavano una conferma. Ma Guzman ormai l’ascoltava con distacco, e si limitava a negare, ad accavallare una scusa dietro l’altra e le giustificazioni. «Sei sempre stato un sottone, Guzman, ma così è troppo!» gli ripeteva. Quel suo contraddirlo tuttavia generò l’effetto contrario di renderlo ancora più attaccato a lei, al suo affetto centellinato un poco alla volta. Gli pareva come che lui e Samina costituissero un universo a parte, con le proprie regole, separati dal resto, e che le loro vite acquisissero un senso nell’unico momento in cui varcava le soglie del portone della residenza e si rivedevano, l’uno e l’altra nascosti nella coltre buia delle stanze, soli. Ormai neppure Ciceria e Vicio erano ammessi, e Guzman credeva di essere finalmente riuscito a possedere in qualche modo la sua attenzione, e si confortava di quella vincita apparente, del peso di cui si sentiva investito nell’esistenza di Samina. Una notte, ella gli si accostò e gli disse che aveva qualcosa che doveva mostrargli. Lo condusse nella propria camera attirandolo per un braccio, e Guzman riusciva a percepire le punte delle dita sfiorare il suo petto. In quelle condizioni trattenersi diventava sempre più difficile, e quando alzava gli occhi a incontrare quelli di lei, complici di peccato, il fiato veniva ogni volta a mancare. Li fissava indagando la scintilla impaziente che li illuminava. Capì che qualcosa stava per succedere e che non era preparato ad accusarne il colpo. Samina lo lasciò sulla soglia della porta, addentrandosi nel buio, e Guzman la seguì. La guardò poggiarsi a una parete, in attesa che si avvicinasse, di più, ancora di più. «Voglio mostrarti il mio segreto», gli disse. All’improvviso, una porta si dischiuse dietro di lei: un passaggio nascosto, della cui esistenza Guzman non si era mai accorto. Si accostò a scrutare la luce che proveniva dall’interno, colto da un lieve timore, la paura dell’ignoto. «Vieni», lo chiamò Samina, e di nuovo lo attirò verso di sé, con quel tono carezzevole e inebriante a cui era impossibile opporsi. La luce all’interno del passaggio era talmente forte in contrasto all’oscurità della camera che Guzman sentì gli occhi far male, serrò le palpebre lasciandosi trasportare. Qualcosa gli diceva che di tutto questo non fossero al corrente né Ciceria né tantomeno Vicio, e ritrovarsi solo con lei, in un luogo sconosciuto, inesistente agli altri, per un attimo – era la prima volta che un sentimento del genere appariva nel suo cuore, le aveva sempre perdonato tutto, tutto – provò un’ansia sottile nei suoi confronti. Sentiva la sua presenza di fronte a sé, ma questo adesso non appariva di alcun conforto, e la tentazione di fuggire cresceva; se soltanto Samina non si fosse reclinata ogni volta ad accarezzarlo, a chiamare il suo nome con quel filo di voce, forse stavolta l’avrebbe fatto davvero. Inesorabilmente scendevano, e man mano che avanzavano un vento gelido s’insinuava sotto la felpa. Ingenuamente egli immaginò si stesse compiendo una discesa segreta verso gli inferi. Alla fine di quel percorso non vi era altro che una singola, misera stanza vuota. O almeno così gli pareva, disabituato adesso al buio. Il passaggio continuo dalla luce alla penombra lo disorientava, e la fronte pulsava nello sforzo di riuscire a raccapezzare ogni cosa, di mettere insieme i pezzi. Dovevano trovarsi su di una piattaforma galleggiante, poiché Guzman avvertì una leggera nausea e udiva l’acqua scrosciare, alla base, di un moto ondoso e ipnotico. Quando la sua vista cominciò a riabituarsi, si accorse che Samina si era già allontanata e l’aveva lasciato indietro. Fu costretto a raggiungerla, un’altra volta, ma senza potersi sostenere a lei. Si guardava attorno, scaldandosi un braccio con la mano, cercando di trovare un senso a questa rivelazione. «Allora è qui che tu venivi quando ti isolavi», disse, ragionando su quelle sue sparizioni che sin dall’inizio gli avevano impedito di avvicinarla completamente. «Questo è il mio segreto. Non l’ho condiviso con nessun altro», rispose lei. Samina stava ferma in mezzo alla piattaforma, e lo guardava con occhi sibillini. Mentre le andava incontro, Guzman scorse alcune teche che lo costeggiavano da entrambi i lati. All’iniziò non capì, ma nel momento in cui il loro contenuto gli si fece più preciso, improvvisamente fu colto da un terrore viscerale, e quel freddo che percepiva sul suo intero corpo lo agghiacciò ancor più terribilmente. Di fronte al suo sguardo si dispiegava la visione raccapricciante dei Pokémon ibernati, esposti come cimeli da conservare intatti in uno stadio embrionale, impossibilitati a evolvere. Guzman riusciva a distinguere i frattali di ghiaccio oltre il vetro che lo separava e in mezzo a quel pallore candido i visi muti e quiescenti delle creature. L’istintuale necessità di porsi la domanda di chi fossero quei Pokémon svanì quasi immediatamente, perché troppo palese era l’evidenza che non appartenessero a Samina. Resti di altri, frammenti di un qualcosa d’irrecuperabile preservati intatti nella loro permanenza eterna, incorruttibile. Questo era perciò l’estremo limite cui Samina era in grado di spingersi in quel suo ostinarsi ad accumulare gli affetti per non separarsene più. Guzman l’aveva guardata a lungo, nel suo rituale, ossessivo riordinare gli oggetti in casa, incapace di accettare una disposizione diversa, sempre uguale a sé stessa – in tutti quei mesi non era stato smosso nulla, e nemmeno la sua presenza aveva lasciato una traccia tra le reliquie degli altri, unica cosa viva tra le salme di quelli che non c’erano più. L’aveva osservata con una punta di commozione e pietà per il suo animo solo e sconsolato, ma adesso, ora, il gesto paranoico della sua mano che richiudeva uno scrigno a intrappolare dentro il ricordo si trasformava in turbamento, che Guzman non sapeva acquietare. Fissava Samina nauseato, ma allo stesso tempo, specchiandosi nei suoi occhi impenetrabili, si sentiva avvinto nella sua aura accerchiatrice e potente, consapevole ormai del fatto di essersi addentrato talmente oltre da non potersi più sottrarre a lei. Samina gli mostrò una gabbia, e le cinghie metalliche che la richiudevano Guzman se le sentì addosso. «Se tu mi porterai Cosmog», gli disse, «insieme apriremo l’Ultravarco e libereremo le Ultracreature». «Liberarle?». «Sì. Colmeranno Alola dell’assenza che sento nel mio cuore, e quando mi unirò a loro nell’Ultravarco, l’amore di Paver che mi è stato strappato verrà ricambiato». Paver. Dietro ogni suo gesto rimaneva lo spettro di Paver. Guzman si sentì tradito, un illuso. Per quanto Samina avvicinandosi a lui potesse sfiorarlo, percepiva una distanza inconciliabile tra loro, e l’evidenza che mai, nemmeno fisicamente, avrebbe potuto prendere il suo posto lo mortificò. Le dita avrebbero voluto richiudersi a trattenere il dolore e la rabbia, ma esitavano inermi e molli a mezz’aria, mentre le teche luminose gli mostravano i resti atrofizzati degli amori di Samina. Un freddo glaciale lo irretì, e Guzman non riusciva a focalizzare i pensieri: un vuoto gelido permaneva nella sua mente con una pesantezza ovattata. Soltanto quando le dita di Samina presero a scorrere sul suo viso, un poco di quel ghiaccio si sciolse. «Se mi darai Cosmog, ti porterò con me. Che ne dici, Guzman? Sei l’unico ad esserne davvero degno». Lo accarezzava con le mani sulle labbra e sugli occhi, e nelle orecchie sussurrò: «Saremo io, te e le mie Ultracreature». Non c’era nemmeno bisogno che gli facesse assaggiare il frutto per convincerlo a rimanere con lei, perché Guzman ormai era completamente suo e quella misera consolazione, di essere degno dei suoi piani, era tutto quel che gli sarebbe potuto bastare. Le disse di sì. Ma la gola bruciava, e quando si ritrovò un attimo dopo a correre per le strade di Poh, risalito dagli inferi, si accorse che oltre alla pioggia sulle sue guance scendevano lacrime roventi, colme di rimpianto. All’ombra di Paver, di Kukui e di tutti gli altri, rimaneva un essere insignificante, e si odiava, adesso, per quelle fantasie in cui si era rifugiato – il sorriso di Samina che aveva creduto essere rivolto a sé. Eppure, persino nell’apice della disperazione, soltanto poterle stare accanto, vivere ancora nell’illusione di un qualche suo affetto era tutto quel che desiderava. Ci avrebbe pensato l’indomani, perché la ferita ora faceva troppo male. Bussò alla porta di Plumeria. Senza aspettare una sua risposta, Guzman aprì irruente, e se la ritrovò che, seduta sul letto, tra i peluche di Lapras e Skitty, lo guardava con gli occhi assonnati, in attesa di qualcosa. I capelli sciolti le ricadevano oltre le spalle lungo la canotta del pigiama. La luce della luna che traboccava dalla finestra dietro di lei pareva cingerla in un alone delicato, ed egli restò in silenzio di fronte a quella visione tranquilla, avvertendo la calma scivolare lungo le braccia contratte e i pugni chiusi. Si avvicinò, stanco a sua volta, provato dalla corsa e dalla pioggia che pesava sulla schiena, dalle lacrime cadute dagli occhi. Plumeria passò una mano a scostargli il cappuccio, e poi sui capelli bagnati, e Guzman sapeva che aveva già capito tutto. Con un fazzoletto gli asciugò le guance, si protese in avanti a sfiorargli la bocca con un bacio, ed era il bacio che lui aveva represso con affanno, quello che Samina non gli avrebbe mai concesso. Vi si aggrappò con i denti e con le unghie, tremando di rancore ed eccitazione insieme. S’inginocchiò a Plumeria e la strinse a sé per il resto della notte.  Rieccoci, finalmente! Come state? Ho cercato di concludere questa storia durante lo scorso NaNoWriMo: tra la tesi, la laurea e la sessione invernale (come sempre) mi sono un po’ ridotta all’ultimo con la limatura, ma febbraio avevo promesso nelle note dell'ultima raccolta e febbraio doveva essere! È un capitolo molto problematico, ma spero non vi sia dispiaciuto troppo. Per quanto riguarda il libro che Guzman legge in biblioteca, mi sono riferita al Beppo di Lord Byron, in cui si racconta appunto della relazione tra Laura, moglie del mercante veneziano Beppo disperso in mare, e il suo cicisbeo. In realtà questo nucleo è soltanto un pretesto per fare una satira della società inglese e in effetti la vicenda viene interrotta di continuo per parlare di altro. Mi sarebbe piaciuto fare un accostamento tra questo aspetto e il fatto che Guzman in questo capitolo cambia continuamente idea, pensa una cosa e ne fa un’altra oppure rinuncia, ma non me la sono sentita di citare il poema in modo diretto, quindi lascio soltanto questo spunto in nota. La scena della pioggia riprende il ricordo che Lylia racconta sull’Isola Exeggutor, del periodo in cui Samina non era ancora stata contagiata dalle neurotossine ed evidentemente non aveva ancora sofferto il trauma del distacco da Paver. Riporto la citazione da Pokémon Central Wiki: «C'è una cosa che mi torna in mente ogni volta che guardo la pioggia... Un episodio di quando ero bambina... Ero corsa fuori a cantare e ballare sotto la pioggia, come avevo visto in un film... E mia madre, vedendomi, venne fuori sorpresa, senza nemmeno prendere l'ombrello... Poi si mise a ridere... e cominciò a cantare insieme a me sotto la pioggia...! Quella volta ci prendemmo un bel raffreddore! Dormivamo insieme e io ero così contenta che la svegliavo in continuazione... Se penso invece che ora il suo unico interesse sono le Ultracreature... Poveri Zero e Nebulino... Vorrei tanto aiutarli, ma non c'è niente che io possa fare per loro...». Ci tenevo a chiudere con un chiarimento sull'uso di "travestito". Ho pensato potesse essere un termine presente nel vocabolario (pur revisionato nel Capitolo 2) di Guzman, anche per la concezione binaria, idelizzata e stereotipata che ha in questa storia del maschile e del femminile, e secondariamente per il conflitto irrisolto con gli altri modelli di virilità che gli si impongono davanti. Al di là di questo, ricordiamoci che le parole hanno un peso, e dovremmo sempre usarle e metterle in discussione con consapevolezza. Prometto che non mi faccio aspettare un altro anno! Un abbraccio e a presto ♥ ℘ersej |
Capitolo 5
*** Al varco ***
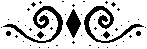 C a p i t o l o 5 : A l v a r c o
Guzman con le donne aveva sempre avuto un rapporto altalenante. Plumeria però era diversa, e spesso si ritrovava a dirle che in realtà era un uomo come lui, a volte per il semplice gusto di farla incazzare, ma in realtà in certi momenti ci credeva veramente. Adorava questa donna tanto decisa e ferma, salda ai propri principi e carica di una forza dirompente, ostinata, la trovava così terribilmente virile, e in questa sua virilità si rispecchiava, vi trovava un punto d’incontro viscerale e intimo sebbene talvolta si ritrovasse a invidiarla.
Nel corso degli anni avevano sempre avuto questo legame avulso da qualunque schema gli si sarebbe potuto apporre, pur coltivando separatamente i loro amori senza mai renderne conto all’uno o all’altra, se non quando c’era bisogno di ragionarci sopra, di capire un sentimento, superare una rottura; un appartenersi a vicenda che nella propria consapevolezza non sfociava mai in dipendenza, come invece accadeva spesso a Guzman nel momento in cui si intratteneva con qualche donna. Plumeria era la sua base sicura. Ancora spossato dal sonno e dal piacere, egli si trattenne a guardare la pelle nuda e bruna di lei, ne sentiva l’odore tutt’attorno e nei ricordi la vedeva tendersi e piegarsi, appena percettibile sotto lo spiraglio di uno spicchio di luna. Quella notte non era stato prestante come al solito, e il motivo era che tra le striature di una ciocca di capelli, nelle curve dei suoi seni, talvolta involontariamente vi aveva apposto l’immagine di Samina, la stessa che accogliendolo al proprio petto non gli aveva concesso il proprio bacio mentre intanto con le gambe si attorcigliava alle sue. Il pensiero di desiderarla martellò sulle sue tempie contratte nello sforzo di scacciarla, soltanto un attimo, perché per un motivo che non sapeva spiegarsi a parole ne era asfissiato, e tuttavia solo aggrappandosi a lei sapeva che avrebbe tratto il respiro. Gli veniva da piangere – ma il grande Guzman non piange mai. Il sole del primo mattino penetrava dalla finestra abbagliando la stanza a soqquadro, le lenzuola accartocciate, i peluche caduti a terra. Un bagliore si poggiò di riflesso contro la finestra sopra il viso di Plumeria. Guzman vide le sue palpebre fremere con le ciglia che scivolavano sopra le guance e i suoi occhi aprirsi nel risveglio. Plumeria si distese su un fianco e portandosi indietro i capelli gli rivolse una smorfia sonnolenta, che aveva però la freschezza di un sorriso. Lo salutò, si avvolse nelle coperte e rimase a guardarlo dal basso raggomitolata al cuscino. Guzman poteva percepire la sagoma dei suoi fianchi oltre le lenzuola e sebbene altre volte ne avrebbe approfittato senza tirarsi indietro, oggi invece c’era questo senso di smarrimento che lo paralizzava – ecco ancora i fianchi di Samina oscillare sul materasso, visione mai veduta eppure inconsapevolmente alimentata ogni notte; l’illusione gli diede la nausea, eppure, di nuovo, allo stesso tempo lo stregava. «Va meglio adesso?» chiese Plumeria stirando la schiena. Allungò la mano a raccogliere il pigiama. Guzman però non la sentiva né la guardava. «Oggi rapiamo la ragazzina», disse. La spalle di Plumeria ebbero un sussulto. Ella si volse a fissarlo. «Mi serve il suo Pokémon. Dobbiamo aprire il portale per l’Ultramondo, io e Samina». Guzman non le aveva mai confidato nei dettagli in che cosa consistessero i suoi servizi per Samina, né l’esistenza delle Ultracreature, di quell’universo sconfinato e astruso che gli si era rivelato una volta messo piede nell’Æther Paradise. Si era generalmente appigliato a dipingerle un’alleanza di convenienza, talvolta un consulto, una compagnia di cui potesse avere bisogno una donna sola. Prese quindi, con la voce che vibrava dentro la gola, ancora arrochita e profonda, a snocciolare qualunque cosa gli apparisse nella mente, i risvolti segreti che erano dietro la fuga di Iridio, la scomparsa di Paver, i Pokémon rubati e quelli dentro le teche – che freddo, che freddo all’improvviso, a stare nudi senza potersi più coprire nelle proprie certezze idealizzate – le vomitò il terrore e insieme l’ossessione palpitante che lo scuoteva al pensiero di poter schiudere finalmente lo squarcio nel cielo stellato che tante volte aveva scrutato dai monitor, il tunnel verso l’infinito che vi si intravedeva dentro. Plumeria ascoltava, seduta accanto a lui, e le sue unghie si aggrappavano talvolta alle lenzuola con tale forza che i suoi polpastrelli sbiancavano. Guzman vedeva le sue mani, ma non riusciva a distinguerle dal flusso di immagini che ormai aveva preso a scorrere davanti ai suoi occhi. Soltanto quando si sollevarono a strattonarlo per una spalla ritornò con fermezza al presente, e allora si accorse dell’espressione contratta di lei, la piega asciutta che le prosciugava la bocca carnosa. «Guzman» e il fatto che lo chiamasse per nome completo mentre erano a letto esprimeva la gravità della situazione. «Stai delirando. Quella donna...». Ma proprio mentr’egli si concentrava ad ascoltare la sua voce, dalla biancheria si sollevava una medusa bianca, ed era all’improvviso immerso da solo nel buio; gli pareva che il suo ombrello rilucesse di una luce misteriosa da cui era attratto. Provò ad allungare una mano per afferrarla, ma le dita di Plumeria furono più rapide nel trattenerlo. «Ho detto tutto a Iridio». Guzman ebbe bisogno di qualche istante per realizzare, come se si fosse per un attimo, un’altra volta, dissociato da tutto. «Ti avevo espressamente detto di non fargliene parola!». «Parliamoci chiaro, Guzman, quella donna ti sta palesemente sfruttando! La situazione ti è sfuggita di mano da un pezzo, e io mi rifiuto di prendere parte alle tue stronzate! L’ho già fatto troppe volte, se non ci arrivi da solo io non so come fartelo capire!». Un rifiuto. La chiusura che trapelava dal suo tono austero mise Guzman sulle difensive, cominciarono a urlare e a litigare, ed egli non poteva accettare che lei per una volta si astenesse dall’offrirgli il suo aiuto, e per quale motivo proprio adesso te ne vai? Non lo vedi che io soffro, che non ho idea di cosa dovrei fare? Perché mi fai questo? Non avevi detto, non avevi fatto, non avevi, tu...? Poi, l’ultima sentenza, perentoria: «Ti ho già detto che non sono una madre!». Plumeria lo cacciò dalla stanza gridandogli di andarsene. Oltre la porta chiusa battevano i peluche che gli lanciava contro per mandarlo via. Guzman ascoltò le sue imprecazioni finché non ne fu saturo. Soltanto quando la sua voce si fu affievolita a spezzettarsi in singhiozzi trovò la forza di incamminarsi lungo il corridoio. Pareva insolitamente tetro, quella mattina, più di quanto la Villa Losca in realtà non fosse. Nelle orecchie gli rimbombava a ogni passo il battito del cuore affannato dallo sforzo di mantenere la calma, e procedeva a tentoni per una strada che all’improvviso gli sembrava sconosciuta. Più avanzava lungo il corridoio e più aveva la percezione di precipitare in un abisso di pensieri malsani, un mulinello di rancore e angoscia lo trascinava in basso alla radice di una rabbia ineluttabile, che cresceva e cresceva. In quel momento Guzman provava una profonda collera, ma non era né per Plumeria, né per Samina. Germinava come una corona di rovi intorno alla sua fronte un fastidio martellante verso sé stesso. Raggiunse in qualche modo la cima della scalinata oltre cui si trovava la sua stanza. Ad un tratto vide, non seppe come, le sue dita macchiate di sangue e i tagli sulle mani, le bottiglie sparse a terra sfracellate e scagliate lontano dalla libreria. Bestemmiò e intanto il dolore che gli soffocava i palmi e le nocche bruciava sempre più forte e concreto. Respirò pesantemente percependo l’odore del proprio sangue affiorare fin dentro alle narici, mentre in fondo alla gola prudeva il pianto che non riusciva a sfogare dagli occhi troppo presi dalla visione dei rivoli rossi, dei vetri sparsi a terra, dei vetri sparsi a terra, i legni e i ferri fatti a pezzi – ma quando, questo, quest’immagine sovrapposta, quando? In un tempo impensabile che si era convinto di aver cancellato. E stava meglio. Intanto che l’adrenalina lo abbandonava e le sue braccia si facevano pesanti, tornava a percepire una quiete inviolata, che gli alleggeriva la testa, e i pensieri ora vuoti, dissolti nella furia, scomparsi. Il dolore acquisiva un senso, una percezione tangibile agli occhi. La rassicurazione di un qualcosa che poteva essere spiegato, analizzato, gestito, risolto. Si pulì le ferite come poté, e tolse da solo i vetri dalla carne, quelli che riusciva a vedere, gli altri li sentiva sotto la cute bruciare in una maniera terribile, ma erano talmente piccoli, talmente profondi, che non era in grado di rimuoverli. Quindi ve li lasciò, e per nascondere tutto coprì le mani nelle bende. Se le fissava avvolte nella garza con un senso di incantamento, rigirandole a poco a poco. Non c’era più niente – solo le guance ancora umide, seppur gli occhi asciutti; come ci si sente dopo aver sfogato un tormento. Tornò sui propri passi, rianalizzando ciò che si era detto di fare e che aveva dimenticato. Lentamente ricordò, rabbrividì nel riportare alla mente le immagini dell’Ultravarco, e decise che sarebbe andato a prendere Cosmog da sé. Non appena uscì dalla villa incrociò lo sguardo di Plumeria che stava facendo l’ennesima ramanzina alle reclute più giovani. Si era accorta delle sue mani fasciate e aveva già capito, Guzman glielo leggeva negli occhi fattisi improvvisamente torvi; ritrasse rapidamente le dita dentro alle tasche, che non voleva farsi vedere anche dagli altri. Plumeria gli si accostò, fissando con insistenza là dove era andato a riparare le mani. Guzman non riusciva a decifrare il suo stato d’animo – come attonita o delusa. Spaventata. «Ti aiuto», gli disse «Ma devi promettermi che una volta portata la ragazzina col Pokémon, tu chiudi qui la faccenda. Se Samina vuole andare nell’Ultramondo, qualsiasi cosa sia, che ci vada da sola. Tu ti sei già sacrificato abbastanza, non puoi permetterle di rovinarti». «D’accordo, Plum». «Guardami negli occhi quando lo dici». Guzman non poteva arrivare a prometterle una cosa del genere, perché ormai dentro di sé aveva già preso una decisione. Ma il suo aiuto era fondamentale, e per la benevolenza di Samina – continuare ad annichilirsi dentro il suo sentimento non corrisposto rimaneva l’unica consolazione – si spinse persino a rompere il legame che aveva con lei. «Te lo prometto». Guzman sedeva sul proprio trono annoiato, con Yungoos sulle ginocchia, lo teneva nella mano e lo accarezzava, lo stritolava al ricordo di un qualcosa passato che però non voleva schiudere – la sua prima lotta. Proprio ora che stava giungendo la fine e ne sentiva scorrere gli attimi, tornava da capo all’inizio, all’albore di un vita stentata e inconcludente. Yungoos guaiva, i suoi occhi si facevano grandi e lacrimosi, brillavano di una lucentezza terrorizzante come pietra cristallina, e questa era purezza. «Non sono mai stato puro», si disse. Un memento. Sun apparve a riprendersi la mangusta. Si compieva uno scambio a sua insaputa, e pure sconfitto Guzman rideva, rideva mentre lui se ne andava. Poco dopo Plumeria fece il suo ingresso accompagnata dalle reclute che schiamazzavano e ghignavano sbeffeggiando il bottino conquistato. Guzman sollevò la schiena dal suo trono e spingendosi in avanti fissò Lylia, la pelle pallida come una bambola di porcellana, fragile, graziosa – la copia in miniatura di Samina. Di nuovo quell’impressione che aveva già avuto nel loro primo incontro gli si rifece concreta, intanto che la guardava intrappolata per un braccio nella morsa di Plumeria – una Salazzle che avesse appena agguantato la sua vittima e si divertisse a frustrarla. Guzman vedeva però negli occhi della compagna che lo sguardo affettato e minaccioso che le stava rivolgendo era una montatura, e si capiva dalla maniera in cui talvolta era colta in fallo ad allentare il controllo sulla ragazzina, cui concedeva per un istante di sfogarsi. Poi Plumeria faceva la voce grossa: «Ti ho detto di farlo uscire, hai capito sì o no?», e tornava a strattonarla. Lylia si dimenava trattenendo le lacrime, le sue guance rosse s’infiammavano sempre più nello sforzo di resistere alle loro imprecazioni. A Guzman ricordava tanto Samina, la sera in cui era scoppiata a piangere e gli era sembrata una bambina sola. Forse anche per questo esitava e si asteneva dall’intervenire. Poi però: «Lylia» la chiamò a un tratto. «Non vogliamo farti del male». Le si accostò cercando di dimostrarsi conciliante, ma nonostante questo la vide bloccarsi e guardarlo spaurita, con questi occhi grandi e verdi che erano anche quelli di Iridio. Ricordò la sensazione che lo aveva colto assieme a lui sul tetto – paterno, il ruolo che non gli apparteneva e che era di Paver. Fitte lancinanti lo colpirono alle mani, e Guzman dovette portarvi conforto riparandole dietro la schiena a massaggiarle. «Non vogliamo farti del male», ripeté, cercando intanto di ignorare il dolore che gli veniva al pensiero del sangue e dei vetri. «E allora lasciatemi stare!» gridò con voce acuta lei. La borsa oscillò contro il suo fianco e si udì il verso del Pokémon tintinnare in segno di protesta. Subito Lylia portò il braccio libero a proteggere l’apertura della tracolla premendovi sopra con forza. Plumeria le diede uno strattone. «Lasciala, Plum», disse «Ci parlo io». Plumeria si voltò sorpresa verso di lui. Liberò la ragazzina poco dopo. Lylia si portò le dita ad accarezzarsi il polso. Appena Guzman si chinò a scrutarla però tornò a proteggere con cura la sua borsa e se la strinse al petto – una cura materna, che a Samina ormai non apparteneva più e che tuttavia da lei in qualche modo doveva aver appreso. «Senti un po’, farfallina», e dava davvero l’impressione angosciante di una farfalla bianca che tremi nella rete di un ragno «Mi dispiace per l’accoglienza indelicata. Certo, con Kukui devi esserti abituata bene. C’è solo una cosa da te che vogliamo ed è Cosmog». «Nebulino, il suo nome è Nebulino! Voi adulti non sapete fare altro che cancellare i nomi degli altri! Le loro identità!». Per qualche ragione tanta sincerità espressa in una frase così semplice lo colpì. Lasciò quindi vagare pensoso gli occhi per un poco, mentre rifletteva, e nello stesso istante si riconobbe dentro lo specchio che stava dietro di loro. La chioma di Lylia prese a crescere e ad allungarsi fino a prendere la forma di quelli di Samina ed egli si rivide di fronte a lei, mentre si spogliava e poi percepiva le sue mani accomodare le pieghe di Paver sopra le spalle, sagomandole a inglobare i suoi interi contorni. La sofferenza prolungata che si acuiva sopra i palmi gli rese l’immagine nello specchio rifratta e spezzata in un ammasso senza senso che erano i vetri rotti distrutti quella mattina, e gli parve di scoprire sé stesso in lacrime, dissolto in tante facce, abominevole. Agguantò d’istinto la ragazzina per le spalle. «Adesso però mi hai proprio rotto!» sibilò. Lylia tentò di liberarsi, si lasciò sfuggire un grido spaventato. Senza rendersene conto Guzman stava conficcando a forza le dita contro la sua pelle – quanto era gracile anche lei, sottile, indifesa, ma di una grazia che Vicio non avrebbe avuto mai. Guzman, che diamine combini? Si fermò, subito si rivolse agli altri. «Plumeria, prendile la borsa, tiralo fuori!». Cosmog schizzò fuori seguito da una cascata di scintille, brillava tra i fumi dei suoi aloni gassosi con una lucentezza fatata. Le reclute si affrettarono a rincorrere il Pokémon, se lo passarono di mano in mano. Plumeria lo racchiuse nelle proprie dita. Ormai era fatta. Prima Yungoos, ora Cosmog. Era come se nelle mani stringesse i fili di un prima e di un dopo, i nessi che lo avevano legato alle persone che aveva incontrato lungo il tempo – ancora dolevano e prudevano, e Guzman lo interpretava come un qualche tipo di punizione, e non capiva per quale ragione proprio adesso doveva ritornargli tutto addosso. Tratteneva la creatura nel palmo per uno dei suoi bracci, percependo la pelle solleticare mentre i suoi vapori fluivano caldi verso l’alto. Cantava. Ininterrottamente cantava con quella sua vocina stridula di campanelli stonati, come che anziché provare soggezione si divertisse nell’essere trattenuto dalla sua presa violenta, ma in realtà tremolante, nervosa e insicura, poi piegava la testa a guardare l’espressione seccata di Guzman e sorrideva. Lui ricambiava la sua occhiata per un breve istante e distoglieva lo sguardo, esasperato da quella gioia prorompente, fastidiosa. Cosmog era di fatto una piccola palletta fluttuante e fastidiosa, nel suo complesso, ai suoi occhi ora che l’osservava da vicino. E si chiedeva scettico se davvero un essere del genere, che Samina gli aveva dipinto come meraviglioso, incredibile, fantastico, possedesse il potere di evocare il portale per l’Ultramondo. Proprio mentre pensava a lei, la vide aprire la portiera del velivolo che aveva inviato loro dalla fondazione per recuperarli alla Villa Losca e raggiungerlo. «L’hai preso», disse, e i suoi occhi si rischiararono di cupidigia, allungò le mani a toccare Cosmog, che però spaventato si rincantucciò contro Guzman. «Tra poco, insieme...». Intanto Plumeria usciva dall’abitacolo trascinandosi Lylia da parte. Le reclute che avevano voluto unirsi alla missione la seguirono fuori, vennero accolte con sufficienza dagli scienziati Æther, impettiti con le solite visiere impenetrabili a mascherare i volti. Strappato dalle dita di Guzman senza preavviso, Cosmog venne costretto a forza nelle catene e intrappolato nella gabbia per lui progettata, sotto gli occhi impotenti della ragazzina che intanto guardava la scena in silenzio, ormai fin troppo satura per potersi spingere a ribellarsi ancora. Egli intanto, ascoltando in sottofondo lo strepitio del Pokémon imprigionato, cominciava a provare una leggera apprensione mentre osservava Plumeria rivolgersi per la prima volta a Samina, e viceversa. Le loro figure cozzavano senza che potessero trovare una conciliazione, e Guzman si ritrovava a soppesare le loro voci, i loro toni, a riconoscerne le cadenze che risultavano assieme e che singolarmente non era finora stato in grado di individuare. C’era una freddezza meccanica, nelle loro parole, una ostilità malcelata nell’indifferenza con cui si scrutavano, Samina dall’alto del suo privilegio, Plumeria dal basso nel suo orgoglio più umile e spartano. Tra di loro la bambina, avviluppata, schiacciata, nelle loro dita, costretta con lo sguardo a terra, silenziosa, arrendevole. Per pietà Guzman la prese e la portò via. La condusse nella stanza di Samina. La lasciò accomodarsi e avrebbe scommesso che sarebbe scoppiata a piangere non appena avrebbe richiuso la porta dietro di loro, invece Lylia resisteva, con un coraggio ostinato, più grande e saldo di quanto Guzman avrebbe potuto immaginare in un corpo così piccolo. E da una parte pensava che forse, l’essere ricondotta in questo modo alla residenza non fosse in realtà per lei cosa insolita, che anzi, nella calma con cui si accovacciava sul letto, tutta composta, precisa, ci fosse invece una consuetudine, una monotonia messa in atto con un ritmo cadenzato da battute ben definite e consapevoli. Fu probabilmente perché in soggezione per questo autocontrollo quasi sterile, impassibile, in un frangente di pericolo e disperazione, che senza riflettere le disse che sarebbe rimasto a fare da guardia e che sarebbe stato meglio per lei non muoversi, men che meno tentare di scappare. Non ebbe in risposta alcuna reazione. Cominciò quindi uno scontro teso, di un silenzio prolungato ed estenuante, finché: «Questi, sai, li ho scelti per lei». Lylia si stringeva nelle piccole dita i lembi della gonna, si allisciava i vestiti, per noia si avvoltolava i veli e i nastri tra le mani. Guardò Guzman, di una occhiata lunga e prudente. Egli la fissava, seduto alla toeletta, a cavalcioni sulla sedia, le braccia incrociate sopra la spalliera, stanco. «Anche tu hai indossato abiti non tuoi. E lo hai fatto per lei», sentenziò Lylia, la voce ferma, piatta. Guzman rabbrividì. Sedeva di fatto lì dove erano stati quel giorno i panni di Paver, le spoglie con cui si era travestito a rubare il suo posto. «Non è vero», disse «Non è vero, non sono stato io a sceglierli». «Ma anche così, l’averlo scelto o meno avrebbe davvero importanza? Lo abbiamo fatto, e questo è ciò che rimane». Scorsero nella mente come visioni lontane gli abiti consumati da ragazzino, le polo appese ad asciugare al sole nel giardino coi giochi, i pesci nella lavatrice, le tute slargate, rattoppate, sfilacciate, un nodo alla gola, il letto di Samina, le gambe intrecciate. «È per questa ragione che prima hai avuto paura. E mi hai aggredita». «Zitta! Zitta, stai zitta!». Il pianto che non era riuscito a far affiorare quella mattina sembrava tornare di prepotenza a gonfiargli il petto, e sentiva che adesso fluiva senza che potesse porvi un freno. Nel sollevare gli occhi si avvide tuttavia che in realtà a piangere era lei, e che, nello stringersi a lui, lo sosteneva. «Per favore, restituiscimi Nebulino», gli chiese, con espressione lucida e commossa. Samina venne poco dopo; Guzman si ritrasse, si congedò, e oltrepassò la porta coi singhiozzi della bambina che ronzavano nell’orecchio, mentre sentiva sua madre parlare e chiamarla figlia degenere. Uscito dalla villa sorprese Plumeria rannicchiata con le gambe scomposte su un gradino dirimpetto al piazzale, e rifletteva tra sé e sé a voce sul modo in cui Samina dava gli ordini, su quel suo fare autoritario nei confronti dei suoi, imperturbabile, come avesse sotto controllo qualunque cosa nelle proprie dita, potente. Ella si accorse della sua presenza, si tirò in piedi e lo squadrò. «Adesso capisco per quale motivo sei così attratto da quella donna», disse. «Lei è tutto quello che vorresti essere tu». Guzman tacque, e sebbene non ci avesse mai pensato davvero prima d’ora, sembrava che Plumeria avesse centrato il punto. «Beh, basta», disse ancora lei all’improvviso saltando giù dalla scalinata «Quello che dovevo fare l’ho fatto. Adesso sta a te. Io me ne vado, questo posto mi dà la nausea. Voi, forza, alzatevi!». Ma le reclute volevano rimanere con Guzman, allettate e ringalluzzite dal compito importante che gli era stato chiesto di svolgere. Plumeria ebbe da ribattere, ma capendo che ormai non c’era più nulla da fare rinunciò: «Come vi pare», concluse, e si avviò lungo il viale assolato, che bruciava sotto il sole in tutta la sua aridità. Guzman la guardò allontanarsi. Rimase a fissarla finché non raggiunse l’ascensore. Plumeria non si voltò. Gli rimase soltanto l’immagine della sua schiena contratta dalla rabbia – ed era così diversa da quella sinuosa che aveva intravisto nella notte. Samina era riapparsa alla porta. L’aveva richiamato dentro e Guzman aveva dovuto abbandonare le reclute a sé stesse, intimando loro di stare in allerta e tenere la guardia, che un contrattacco sarebbe sicuramente avvenuto e sarebbe stato imminente. Arrivati in salotto, Samina chiese a Guzman di sedersi sul divano. Prima d’ora in quella casa erano sempre stati da soli, completamente saturi l’uno in compagnia dell’altra, adesso invece non era possibile ignorare la presenza degli scagnozzi di fuori – e di là, chiusa in stanza, Guzman credeva di udire ancora la ragazzina singhiozzare, i suoi sospiri stanchi e disillusi. «Lasciami guarire le tue ferite», disse lei, cominciando a svolgere le bende sulle sue mani. Guzman si sentì denudare a mostrare una vergogna, una debolezza che ella non doveva svelare. Non appena il primo taglio venne scoperto, ritrasse istintivamente le dita. «Io non volevo...» disse. «Sst», lo zittì lei, rassicurante. Guzman cedette. Samina prese ad accarezzare i lividi sulle sue nocche, scorrendo lungo l’intero dorso di una mano. Guzman sentiva che lì dove la pelle si era scorticata ancora bruciava a contatto con l’aria, e il sangue rappreso lo raccapricciava. Ma lei invece esplorava con solerzia ogni rossore, e vi portava conforto col proprio tocco leggero. Mentre gli rigirava il palmo, nel distendersi della carne una ferita si riaprì. Samina si portò la sua mano alle labbra e ve la premette sopra. L’estrema dedizione con cui si curava di lui lo impietosiva, e assieme si sentiva commosso, restò con il fiato mozzato a scrutare il sacrificio di ungersi la bocca col suo stesso sangue. Sentì che in quel modo si sugellava un patto vitale tra di loro. Mentre lei premeva la bocca, poteva sfiorarle con le dita la guancia e i capelli, e la delicatezza di quella visione lo colpì al punto da arrivare a trovare qualcosa di disgustoso sensuale, e non capiva più nulla, nell’apice della follia cui Samina si dimostrava capace di condurlo. A un tratto, lo scoppio improvviso del pianto della bambina lo distolse dalle malizie di Samina, e si tirò indietro, piegò un poco la testa ad ascoltare quel lamento. «Forse dovremmo...», tentò di dire. Si accorse che Samina lo fissava, probabilmente attendendo che finisse di parlare. Nel vedere la sua bocca sporca di una chiazza rossastra, gli parve per un attimo di scorgerla adesso sotto una luce maligna, come una vampira che succhi sangue. Lo schiamazzo crescente delle reclute fuori, intanto, lo richiamava ancora a distogliere la mente da quei suoi vagheggiamenti. Samina terminò di medicarlo, gli richiuse rapidamente le bende. «Va’», gli disse «Di Lylia mi occupo io». Guzman avrebbe voluto dirle di non essere cattiva, ma tacque anche quello. Si diresse all’ingresso e varcata la porta notò all’orizzonte una certa confusione tra i suoi scagnozzi, che si erano fatti più agitati. «Che diavolo vi prende?». «Iridio, Guzman! Sta arrivando insieme a due ragazzini!». «Due ragazzini?». «I suoi amichetti, il nipote di Hala e quell’altro figlioccio di Kukui». Guzman vide per un attimo l’immagine di Hala e di Kukui materializzarsi davanti ai propri occhi, e pensò che l’avrebbe fatta finita, che l’apertura dell’Ultravarco gli avrebbe dato finalmente quel senso di riscatto che da anni ricercava. Ma bisognava stare attenti e non abbassare la guardia. «Quelli della Æther che fanno?». «Se ne sta occupando Vicio. Guzman, che cosa facciamo noi?». Di Vicio Guzman non poteva fidarsi e poi non aveva messo in conto che Ciceria senza dubbio sarebbe stata dalla parte dei ragazzini, troppo buona per sottostare alle violenze di quel giorno. Non bastò neppure il tempo per elaborare una strategia, che già in lontananza si apriva l’ingresso al piano e tre figure minute facevano la loro entrata nel piazzale. «Quel coglione di Vicio», sibilò Guzman tra i denti. Poi vide Iridio che sollevava la testa a guardarsi intorno con gli occhi infuocati. Incrociò il suo sguardo e si atteggiò sopra la scalinata preparandosi a fronteggiarlo. Iridio correva verso di lui, e nei suoi pugni serrati Guzman percepiva tutta l’ira che doveva scuoterlo dentro. Nello scontrarsi sempre più pressante dei loro occhi ebbe inizio la lotta. Tipo Zero uscì di volata dalla Sfera, schizzò a prendere la rincorsa nel piazzale bianco, ma Golisopod fu più rapido nel parare l’urto e gli oppose una feroce Schermaglia – la prima devastante impressione di cui Guzman adorava fare sfoggio nei suoi scontri. Iridio incitava a non cedere, Guzman rincarava la dose e Golisopod si faceva sempre più subdolo e prepotente. Lo scagliava lontano con le scintille che scoppiavano nello stridore delle loro armature che collidevano una addosso all’altra. Tipo Zero si riavvicinava ogni volta a frantumargli la corazza coi propri artigli acuminati, lo colpiva a testate, cozzando il metallo della propria museruola, disperatamente nello sforzo di urtarlo, di causargli dolore, stremato, col proprio stesso sangue che schizzava dalle fratture della maschera. Soltanto allora, sopraffatto dalle percosse, Golisopod parve tentennare. Per un attimo si ebbe una tregua, un momento di silenzio. «Prima scappi di casa...» rifletté Guzman ad alta voce «Poi entri a far parte del Team Skull per diventare più forte... E se ti fossi limitato a questo mi saresti pure andato a genio. Ma opporti così a tua madre è davvero troppo! Non sopporto chi non porta rispetto ai genitori!». Iridio batté un piede a terra, gli gridò: «Parli proprio tu che da tua madre non ci sei più tornato!». Sollevò un braccio a intimare Tipo Zero di tornare all’attacco. Il Pokémon si mosse sulle zampe affaticate dalla lotta. Golisopod tornava in posizione, mantenendo il sangue freddo, al contrario di Guzman che nel frattempo alzava la voce a esortarlo con rabbia, e forse erano proprio l’odio e lo sconcerto nella realizzazione di essere entrambi due scappati di casa e nient’altro, con aspirazioni che non avrebbero portato che a una completa disfatta. Tanto opprimenti erano la furia e la stanchezza che bastò un ultimo colpo ad atterrare Tipo Zero, e Guzman distrusse le speranze di Iridio con la stessa facilità con cui avrebbe potuto sbriciolare della terra infeconda nelle dita. Il Pokémon si contorse sotto la mole di Golisopod, sforzandosi di liberarsi, fiatava, graffiava. La museruola, rotta e consumata, traballava sul suo muso tra le giunture pericolanti e instabili. Un ultimo sibilo vi spirò prima che perdesse completamente i sensi. Tipo Zero si accasciò a terra urtando di peso sul pavimento imbrattato di sangue e sudore. Golisopod scostò con lentezza gli artigli affilati, e Guzman si sorprese della gentilezza di quel gesto, come volesse accompagnarlo a ricadere sul suolo senza arrecargli altro dolore o umiliazione. Si rivolse a Iridio e lo vide tremare, visibilmente scosso dalla disfatta, mentre si cacciava un braccio a coprire gli occhi. «Tutti questi anni di solitudine non mi hanno portato a niente...», lo sentì mormorare da lontano con la voce soffocata, e quelle parole risuonarono acute anche dentro di lui. Man mano che si liberava della tensione dello scontro, Guzman si soffermava con sempre maggiore attenzione su questa immagine triste, di un Iridio insolitamente fragile. Gli parve di rispecchiarsi nelle lumeggiature dei suoi capelli biondi, per un attimo bruni e scarmigliati, e di rivedersi coi vestiti strappati e Wimpod tra le braccia. Golisopod si stava intanto affiancando per farsi rimettere in sesto: nella fiacchezza con cui si piegava verso di lui a ricevere le sue cure, Guzman ebbe come la sensazione che il suo Pokémon stesse pensando la stessa cosa. Mentre passava una mano a saggiare gli squarci sulla sua corazza provò una fitta conosciuta, ed era quella assopita del sentimento della solitudine, che tanto tempo addietro li aveva legati indissolubilmente. Nelle orecchie riecheggiava il pianto di Lylia, e gli occhi lucidi di lei erano gli stessi di Iridio ora. In quel momento accorse Sun, con il suo Decidueye già pronto fuori dalla Poké Ball a vendicare il compagno. Nel momento in cui posò gli occhi sull’arco e sulle frecce del Pokémon, Guzman avvertì un capogiro, e sapeva già che di fronte ai suoi dardi infuocati Golisopod sarebbe stato di nuovo incapace di difendersi. Accolse tuttavia il ragazzino coi migliori ossequi, sfogando tutta la violenza di cui potesse essere capace. Nella foga dello scontro percepì nel proprio respiro affannoso l’ira passata che lo aveva invaso di fronte a Kukui, nelle lotte senza soluzione – gli somigliava. Lungo il nastro consumato che si riavvolgeva in continuazione quel giorno al suo sguardo, una malinconia crescente lo colpiva a tratti nel petto, e gli sembrava sempre di più che presto avrebbe detto addio a tutto quanto. Non si risparmiò, neppure nei frangenti più critici, di fronte alle mosse più subdole. Sollevava le braccia come a scagliare lui stesso i colpi, prendendo la mira e ruotando tutto il corpo ad accompagnare l’attacco in backswing, e si sentiva leggiadro col sangue che pompava al cervello e gli dava alla testa. Non bastò. Richiamò a sé Golisopod e si fece di lato a lasciar passare il ragazzino: mentre correva dentro gridando il nome di Lylia, Guzman sorrise, ed era strano, un sorriso arrendevole, eppure soddisfatto. Iridio lo guardava, ancora immobile oltre il terreno di battaglia. Arrivò un altro bambino che Guzman non aveva mai visto prima, ma che dai tratti riuscì a ricollegare ad Hala. «Iridio! Va tutto bene?». «Lasciami perdere, Hau». «Smettila di fare l’altezzoso. Guarda che a me non la dai a bere. Aspetta, curo i tuoi Pokémon. Ecco. Ora sei a posto. Insieme siamo arrivati e insieme ne usciremo, mi hai capito?». Hau prese Iridio per mano e strinse le sue dita come a infondergli coraggio. Anche Guzman doveva aver fatto esperienza di un qualcosa del genere tempo addietro. Lo stesso ciuffo di capelli spettinato che Hau aveva sulla testa, una volta sbucava da una cuffietta viola – ormai stava già perdendo tutto e riportare il suo viso, la sua schiena rivolta a lui ora per sempre sarebbe stato un rammarico inutile. Mentre si avvicinava al portone Hau si accorse della presenza di Guzman, invalicabile, incorniciata tra gli stipiti. Egli gli lasciò campo libero, indicando dietro di sé con un sorrisaccio cattivo. «Passa, prima che cambi idea». Hau trasalì. Evitando di incrociare lo sguardo di Guzman li precedette dentro. Egli rimase in cima alla scalinata a osservare Iridio che risaliva un gradino alla volta. Quando furono uno accanto all’altro, gli disse: «Parli tanto di solitudine, ma non ti accorgi delle persone che hai intorno». Il ragazzo sollevò la testa, come si fosse risvegliato da una assorta riflessione. «Io mi fidavo», confessò. Poi entrò. I palmi di Guzman presero improvvisamente a bruciare un’altra volta, ma non c’era tempo per farsi prendere dai sentimentalismi. Dopo era successo tutto rapidamente, al punto che non aveva avuto modo di raccapezzarcisi, se non quando, di fronte al portale, Samina si era rivolta a lui: abbagliata dalla luce dell’Ultravarco pareva risplendere di un pallore inquietante, come la medusa bianca che ne era uscita – «Nihilego!» la chiamava, «Nihilego!» – ed ella si stagliava entro i confini della mandorla in cui si era squarciato lo spazio come una divinità. Risucchiato assieme a lei dentro il varco, aveva dovuto coprirsi gli occhi troppo sensibili alla luce delle stelle e delle comete che sfrecciavano attorno a loro. Si era sentito privato di ogni peso, e fluttuava senza poter porre un controllo alla propria traiettoria, trascinato in un vorticoso scintillio di luci psichedelico e terrificante. Non appena aveva potuto tastare nuovamente una superficie di sostegno sotto i propri piedi, bruscamente era stato inghiottito dal buio. La prima sensazione che provò fu di freddo. Poi il peso del proprio corpo, liberandosi della leggerezza che aveva acquisito attraverso il tunnel spazio-dimensionale, si fece a poco a poco più gravoso e insopportabile, e l’aria era scarsa. Guzman respirava a fatica. La testa girava, ed era come se le sue membra fossero in balia di una corrente ondosa. Alzando leggermente lo sguardo e ritrovandosi di fronte le Ultracreature che galleggiavano coi loro grossi cappucci bianchi per l’atmosfera, ebbe la reale percezione di stare affogando in un abisso profondo, rischiarato appena dai cristalli e dai coralli che ricoprivano ovunque le pareti della conca in cui erano atterrati e dal varco ancora aperto dietro di loro. Samina si mosse, arrancando leggermente sopra i tacchi. Si accostò a uno spuntone di roccia luminosa e vi poggiò la mano per sorreggersi. Guzman la vedeva ansimare sotto la morsa di quel corpetto che le avvolgeva troppo stretto il petto. Avanzò di un passo per raggiungerla, ma dovette trattenersi indietro poiché lo sforzo di quel sollevare appena una singola gamba lo sfiancò, i muscoli indolenziti. La luce del portale prese lentamente ad affievolirsi. L’oscurità della caverna parve pian piano cominciare a divorare quel poco di visione che riuscivano ad afferrare. Nel momento in cui il varco si richiuse completamente alle loro spalle, Guzman sentì la testa vorticare ancora di più, l’aria mancante cominciò a premere dentro ai polmoni. Si sbracciò a raggiungere le ultime scintille che ancora sfavillavano lì dove lo squarcio era stato, ma non cavò altro che polvere. «Non possiamo tornare indietro», sibilò, e allora rimase a scrutare spaesato davanti a sé, ancora faticando ad abituare la vista al buio. Il verso stridulo di un Nihilego lo atterrì all’improvviso. Sollevando la testa lo vide puntarli e avvicinarsi, ed era sempre più grosso e terrificante. Samina accorse a stringere la manica di Guzman con una mano: «Seguimi», gli disse, ed egli si accorse dell’impellenza con cui cercava suo malgrado di tirarlo via. E tuttavia quello di Samina non era il tentativo di allontanarsi e di salvarsi, quanto quello di esplorare celermente ogni anfratto di quel luogo. Ai loro passi, bolle di vetro si sollevavano lentamente tra le rocce, ondeggiando nell’aria per poi incrinarsi e scoppiare in frammenti affilati. Guzman tentava allora di proteggersi, ma Samina non sembrava affatto turbata e continuava a muoversi incurante dei pericoli che li circondavano. C’era nei suoi occhi una scintilla morbosa e man mano che continuavano a camminare Guzman cominciò a provarne terrore, ma ancor più forte sarebbe stato quello di separarsi da lei. Man mano che gli occhi si abituavano e anche il corpo ricominciava a sostenere il peso di quella gravità estranea, si palesò poco alla volta la terribile evidenza che quello spazio che era parso nel buio tanto vasto era in realtà minuscolo e ristretto, e questo gettò Guzman in una costrizione ancora più insopportabile. Samina cercava, inesorabilmente, tracce di un qualcosa che non si poteva trovare, e si spostava da un estremo all’altro del percorso. Guzman ad un tratto la prese, esasperato dall’ossessione con cui si muoveva avanti e indietro in quel corridoio asfissiante, al punto da provarne la nausea. «È inutile, Samina», le disse. «Siamo soli. Non c’è nient’altro in questo posto». Samina vagò ancora con gli occhi, esaminando avidamente i luccichii tra gli spuntoni e le conchiglie arroccate alle pareti. Provò a liberarsi, ma Guzman le si oppose, e presero a gridarsi l’uno contro l’altra. Poi Samina tacque come rassegnata, prese a osservare silenziosamente un’Ultracreatura che nuotava torreggiando sopra di loro. «Allora, se non posso più fare niente... Voglio dare a loro il mio amore e unirmi con loro. Voglio congiungermi con Nihilego e sublimare l’amore di Paver che mi è stato strappato». «Smettila! Smettila di ripetere quel nome! Lui non è qui e non tornerà! Non c’è nulla a questo mondo per cui valga la pena di correre un simile rischio. Se tu me lo permettessi... Se è questo ciò che ti manca, sarei disposto a darti tutto il mio amore. Il mio cuore è tuo, Samina! Ma ti prego, ti prego non andare!». Guzman distolse lo sguardo. Non aveva il coraggio di rivolgerlo a lei. Tentò di trattenerla il più possibile nella presa delle proprie mani, ma sentì, inequivocabilmente, le sue spalle scivolargli sotto le dita nella decisione di allontanarsi. Nel momento in cui la sua presenza si fu del tutto disgiunta da lui, Guzman lasciò cadere le braccia, e restò immobile, con le scarpe impiantate nella sabbia, incapace di muoversi. Samina aveva scelto. Lui era di nuovo solo, insignificante dentro un mondo sconosciuto. Samina delirava e parlava di un uomo che si era unito a Clefairy; i suoi vaneggiamenti rimbombavano nella spelonca, si rincorrevano e si acuivano assieme in una cantilena assillante. Sempre più in lei si faceva definita la folle convinzione di potersi fondere con quelle creature che ondeggiandole attorno la corteggiavano, adulandola con le loro carezze, gli strepiti pungenti. Egli l’ascoltava, rannicchiato in un angolo, dopo aver tentato di sottrarsi alla sua voce – inutile fuggire, inutile isolarsi, inutile, inutile. Si alzò rabbrividendo, mosso da uno scatto d’impazienza. Per quanto tempo era rimasto ad aspettare che si acquietasse? Quanto aveva atteso in un segnale, un’apparizione – qualcosa, che gli mostrasse di non aver esitato invano? E gli sembrava di perdere la percezione di tutto, persino di sé stesso. Avendo sentito il grido che gli ribolliva dentro soffocato nelle interiora, una creatura gli si era accostata pietosa. Guzman la fissò, e non c’era altro desiderio ormai che quello di disintegrarsi, di essere divorato, dissolto, annullato. Pensò che forse il suo destino dovesse essere questo, e che le sue visioni non volevano altro che condurlo qui – distruzione assoluta. Presto i Nihilego presero ad ammassarsi accanto al primo che era venuto, tutti insieme a poco a poco lo accerchiarono. Colmo di rabbia e di dolore, si gettò su di loro a rincorrerli, incontrò i loro tentacoli freddi, vitrei, ma nel momento in cui uno di loro lo prese e cominciò a stringersi lungo il suo collo, il corpo non rispose al pericolo. Guzman si guardò, provò a guardarsi, a riprendere controllo dei propri movimenti, in un ultimo insperato slancio ad aggrapparsi ancora alla vita, e sentì una paura viscerale nel rendersi conto che tutto era buio, paralizzato da uno spasimo nel cervello. Senza respiro, soffocando, boccheggiava, urlava, la sua voce fu nulla, nulla – non respiro, non respiro. E gli parve intanto di addormentarsi.  Ciao a tutt* e bentornat*! Come va? Ammetto che nella rielaborazione della trama di Sole/Luna di questi capitoli ho avuto difficoltà con la presenza dell* protagonista, perché mi sono resa conto che la risoluzione di tutti i conflitti tra i personaggi (Guzman-Kukui, Iridio-Guzman, e ovviamente il conflitto chiave Lylia-Samina) avviene o comunque è portata avanti per intercessione di l*i, cosa che nel contesto immersivo videoludico funziona, nella scrittura narrativa un po’ meno... è molto facilona come idea, però ho pensato di sfruttare Sun come replica di Kukui, anche se mi interessava di più la lotta con Iridio. In Ultra Sole/Luna questo Ultramondo si chiama Ultrabisso, perciò ho provato a rievocare in qualche modo questo concetto, spero vi sia sembrato convincente. Ormai siamo quasi alla fine, nel prossimo capitolo vedremo la risoluzione conclusiva e torneremo al presente. Cosa riserverà l’Ultramondo per Guzman? In attesa di scoprirlo, spero che l’aggiornamento di oggi vi sia piaciuto e vi mando un abbraccio enorme! A presto e buon Ferragosto (in anticipo) ♥ ℘ersej |