Night Without Boundaries
(/viewuser.php?uid=311300)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Uno ***
Capitolo 2: *** Due ***
Capitolo 3: *** Epilogo ***
Capitolo 1
*** Uno ***
Spazio d’Autore: Dubito fortemente di riuscire a correggere e pubblicare il secondo - e ultimo - capitolo entro questa sera, dunque approfitto di questo per augurarvi una notte tremenda.
Buon Halloween! 26.10.23 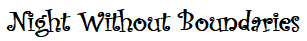 Non credere a niente di quello che senti, e solo alla metà di ciò che vedi.
- Edgar A. Poe I.
Ai lati delle strade, le zucche intagliate le sorridevano sornione, arroganti e accusatrici. ‘‘Egoista, ecco cosa sei’’, sembravano sussurrare malignamente. Waverly non era egoista, non lo era mai stata e non si era mai considerata tale. Eppure quei ghigni luminosi insistevano. Abbassò gli occhi sulle foglie marce e bagnate, sugli stivali che le calpestavano con indolente rabbia, che la portavano lungo il viale della città in cui era cresciuta, lontano dall’estranea che chiamava sorella. Lei non era un’egoista. La guancia pulsava, gli occhi punti dalle lacrime. Intirizzita, si strinse nella grande giacca bianca cercando di scaldarsi, affondò le mani nelle tasche, aprì e strinse i pungi. La pelle e i muscoli delle gambe si ribellavano al freddo, la rimproveravano per quei jeans troppo aderenti e sottili; ma non smisero di condurla. Condurla dove? Waverly non lo sapeva; sapeva solo di non volersi fermare, sapeva solo che la distanza fra lei e Wynonna non era ancora sufficiente. Waverly ci aveva provato. Aveva provato con tutte le sue forze a far funzionare quella serata, a renderla spensierata e allegra, diversa dalle altre. Un paio di giorni prima aveva acquistato delle zucche; erano ortaggi che erano stati amati, baciati da molte piogge e da soli clementi, lo sapevano, l’avevano sentito, per questo erano così belle e pasciute. Non le aveva acquistate al supermercato, era andata da un contadino. Le aveva pagate più del dovuto. Non se ne era pentita. Ora se ne pentiva; ora che il fantasma di quella più grande e arancione le compariva davanti agli occhi col suo polposo cervello sparso sul pavimento della cucina. ‘‘Oops’’, aveva detto Wynonna, inespressiva eppur compiaciuta, ‘‘non penso ce la farà.’’ ‘‘Non è divertente’’, aveva ringhiato Waverly in risposta. Era stato un suono rabbioso ma trattenuto; trattenuto forse dalla speranza che magari si poteva rimediare, far finta di nulla e ricominciare, intagliare la successiva, insieme. ‘‘Lo sarebbe, se tu fossi dotata di un minimo senso dell’umorismo’’, aveva ribattuto Wynonna, portandosi la bottiglia alle labbra mentre Waverly cercava qualcosa con cui cominciare a pulire, mentre si chiedeva se sarebbe riuscita a salvarne qualcosa o se il suo posto fosse ormai solo la spazzatura. ‘‘Era divertente.’’ Non era divertente. Wynonna era sempre stata una bambina speciale, maledettamente intelligente e sensibile; davvero troppo sensibile. Sua madre glielo aveva ripetuto fino al giorno prima di morire. Charleen parlava a Waverly come se fosse lei quella più grande, quella che doveva capire, essere paziente e matura. Parlava della primogenita come fosse un giglio straordinario, troppo delicato per qualsiasi clima; qualcosa che forse ogni ventisette anni sarebbe sbocciato per una notte e avrebbe incantato il mondo con la sua rara bellezza; il suo inestimabile, unico Fiore della Pazienza. Qualcosa che avrebbe cambiato tutto, fino a sovvertire le complesse leggi dell’Universo. E Waverly ci aveva creduto. Aveva creduto che sua sorella fosse la prescelta per qualcosa di grande, immenso e inimmaginabile. L’aveva accettato e aveva accettato di non essere lei, l’eletta; l’aveva fatto senza rammarico, senza invidia e senza rabbia. La rabbia era adesso, adesso che aveva scoperto che loro madre non si era mai sbagliata. Wynonna era unica e avrebbe potuto davvero cambiare il mondo; sapeva leggere nel cuore della gente e quello che leggeva sembrava farla soffrire, sembrava umiliarla e indebolirla, come se avesse ribrezzo della natura umana. Ma anche lei era umana. E il dono una maledizione, un fardello troppo pesante per un corpo fatto di carne e ossa. E provava rabbia Waverly, provava tanta rabbia e le ragioni erano diverse, poche ma potenti. L’odore avvolgente, invitante delle ghiottonerie alla zucca, alle castagne e alle patate dolci le solleticò il naso, le ricordò che non aveva cenato. Ma le ricordò soprattutto la seconda zucca sul pavimento, la risata sguaiata e perduta di sua sorella, i suoi occhi che l’accusavano di essere come tutti gli altri: demoni venuti a turbare il suo sonno e la sua veglia. «Non sono un demone», confidò alle foglie morte, «sono solo stanca.» I pensieri le avevano offuscato la mente e la vista, ma le gambe, seppur scontente, l’avevano condotta da qualche parte, forse nel tentativo di consolarla. E forse c’erano riuscite. L’Oceano sembrava un gigantesco specchio nero, sconfinato e misterioso; cupo e custode di chissà quale segreto. Rifletteva la luna piena, così grande da dare l’impressione che stesse per entrare in collisione con la Terra. O forse era l’Oceano che cercava di rapirla, di rubarla al nero dell’Universo per trascinarsela nel nero dei suoi abissi, di farla sua, per sempre. Per un attimo, più fugace di un battito di ciglia, Waverly si chiese se quell’enorme massa d’acqua salata e gelida potesse desiderare anche lei; lei che si sarebbe lasciata prendere. Solo per un momento. Poi avrebbe lottato e sarebbe tornata alla vita, perché Waverly amava la vita, anche se essa è un’amante capricciosa e, forse troppo spesso, crudele. Si mise seduta a poca distanza dal bagnasciuga, dove le onde non sarebbero riuscite a raggiungerla; non ancora. La sabbia era gelida, dolorosa a contatto con le carni, oltre lo strato di tessuto troppo leggero. Raccolse un po’ di sabbia e la guardò scivolarle via dalle dita, aiutata da gravità e vento. Una lacrima nacque tra le ciglia socchiuse, rotolò sulla guancia e cadde da qualche parte, nascosta dall’ombra del suo corpo. ‘‘Lo sai’’, le aveva detto una volta Wynonna, con le lacrime agli occhi, ‘‘i granelli di sabbia, tutti quanti, non potranno mai eguagliare, neppure avvicinarsi al numero di corpi celesti che stanno lassù’’ e aveva indicato il cielo notturno. Aveva pianto e non c’era stato modo di consolarla. Ma lei non era triste, non quando guardava il Firmamento: era commossa da un’immensità, da una bellezza che sapeva che non sarebbe mai riuscita a comprendere. ‘‘Eppure’’, aveva ripreso, ‘‘tutta l’energia un giorno si esaurirà: l’Universo si spegnerà e morirà nel gelo e nel silenzio, come un vecchio che lasci questo mondo senza rimorsi ma pieno di rimpianti.’’ Questo la rendeva triste. No: la straziava, le dilaniava l’anima e le penetrava il petto, scavava e le graffiava crudelmente il cuore, che non poteva fermarsi. ‘‘Non succederà che fra miliardi e miliardi e miliardi di anni’’, le aveva ricordato Waverly. Wynonna aveva abbassato gli occhi, solo quelli, il mento ancora indirizzato alla fonte della sua felicità e del suo dolore. L’aveva guardata per un tempo troppo lungo, troppo freddo. L’aveva guardata come se non la riconoscesse, con crudeltà e biasimo. ‘‘Tu non capisci...’’ aveva mormorato in ultimo, scandendo le parole lentamente, come se le costassero fatica, come se facessero male. «No, Wynonna, io non ti capisco...» mormorò all’Oceano. E sinceramente, per l’ennesima volta, cercò di capire perché gli occhi di sua sorella vomitavano lacrime amare come bile ogni volta che contemplava l’esistenza, anche quella più lontana e inafferrabile. Un’esistenza di cui non sarebbe mai stata testimone né martire. Invece lei, Waverly, era lì, nell’esistenza di Wynonna, nel suo mondo, nel suo presente, vittima di sbalzi d’umore che sembravano privi di logica, solo crudeli. Guardò l’Oceano come fosse il volto di un sapiente, di un saggio erudito che avesse capito ogni cosa, che avesse le risposte a domande non ancora formulate dall’essere umano. Gli chiese se desiderasse rapire sua sorella, se nel fondo di quel nero senza suoni, ci fosse per Wynonna la possibilità di trovare pace. Perché forse solo la morte avrebbe potuto salvarla da se stessa. Waverly indugiò su quel pensiero violento e freddo che le rimandava l’immagine del volto di sua sorella, pallido e gonfio come la luna, inespressivo, inerte e gelido. Si chiese se la sua faccia sarebbe stata ancora in grado di esprimere quel dolore e quel disprezzo, una volta che il cuore si fosse fermato. Il grido acuto e festoso di un bambino la salvò dalla tortura che si stava infliggendo; una tortura che forse la consolava, forse la distruggeva. Entrambe le cose. Tese l’orecchio, lasciò che il vento conducesse a lei quei suoni pieni di vita e aspettative, di illusioni e gioie. Erano distanti, oltre la sabbia, oltre i blocchi di cemento, aldilà degli alberi, su un viale pieno di porte a cui chiedere: ‘‘Dolcetto o Scherzetto?’’. Wynonna amava quel rituale: le piaceva osservare i volti che si schiudevano per lei, mascherati o puliti, gioiosi e complici o apatici e un po’ scocciati. Le piaceva scrutare dentro quegli occhi famigliari o estranei, le piaceva anche se a volte provava dolore, tanto dolore. Poi aveva smesso di piacerle. Poi l’alcol aveva cominciato a sostituire il calore umano nella sua pancia. Aveva smesso di guardare le persone negli occhi; lentamente, aveva smesso di contemplare la loro esistenza. Per Wynonna, ormai, esisteva quell’unica entità che le scendeva lungo la gola, che ormai non bruciava più, che le faceva provare un po’ di dolore al pettorale sinistro, alle costole; durava poco quel dolore e veniva subito ricompensato, guarito e spinto nel fondo di un’incoscienza senza sogni. Waverly provò il desiderio di alzarsi, di raggiungere il viale alberato e unirsi a quei bambini, un po’ in disparte, da brava adulta disillusa, e pensare: Dolcetto o Scherzetto?, senza dirlo, forse muovendo appena le labbra prima di stenderle, piegarle all’insù in risposta al sorriso o al cenno di un altro adulto. Provò il desiderio di ripetere l’esperimento che Wynonna aveva fatto in quinta elementare, quando si era messa a distruggere le zucche e ogni decorazione che aveva incontrato: voleva sapere cosa sarebbe successo, quanto forti sarebbero stati rabbia, tristezza, odio o perdono. Lei non l’aveva mai spaccata, una zucca, neppure per sbaglio; quella volta era rimasta a guardare, attonita. Era scappata ogni volta che l’aveva fatto Wynonna, un secondo dopo, senza mai farsi vedere, senza mai sbagliare, senza mai rallentarla o tradirla. Senza mai permettere alle sue piccole gambe di separare Wynonna da ciò che desiderava. Era stata una brava ombra, proprio una brava, piccola ombra. Rimase seduta a contemplare l’inganno che non era infinito. Una folata di vento le sospinse sul viso una ciocca di capelli; un filamento ramato si incagliò fra le labbra, come un filo in attesa della cruna di un ago. D’istinto alzò una mano e voltò il viso, per liberarsi di quel solletico. Fu allora che la vide. Era una figura alta, slanciata, così sottile da sembrare quasi una sagoma di cartonato. Le lunghe braccia tenute lungo i fianchi, dove le mani scomparivano nell’elegante giacca nera, simile a un tabarro ottocentesco, ma più adatto a fasciare e rispettare un corpo femminile. I capelli dovevano essere rossi, un rosso quasi volgare, ma sufficientemente scuro e spento da non esserlo davvero. Sotto i raggi della luna, le ciocche brillavano di riflessi viola e argentei. Capelli bagnati. Waverly provò un brivido; presto, però, si accorse che si trattava di un ricordo: non aveva più freddo. La donna contemplava l’Oceano come aveva fatto Waverly fino a un momento prima: sembrava porre domande a cui, però, sarebbe rimasta volentieri sorda. Era solenne ed eterea; quello sembrava il suo posto, come lo era quello di un polena sulla prua di un veliero antico. Waverly si chiese se, voltandosi, la donna avrebbe pensato lo stesso di lei. Se lo chiese senza una ragione, senza desiderio, accolse semplicemente il pensiero, come accoglieva quelli che non riguardavano sua sorella, e lo lasciò esistere, sfogare e morire. La guardò ancora per qualche momento, sentendosi di troppo, il terzo incomodo in una conversazione fra amanti, ancora troppo giovani e innamorati dell’idea dell’altro per poterne cogliere i difetti che un giorno avrebbero amato o odiato. Entrambe le cose, se avessero lasciato che la tenerezza del tempo smussasse istinti e desideri, illusioni e pretese. Aveva pensato per la prima volta all’amore che invecchia cinque anni prima. Stava contemplando Il Bacio di Klimt e non riusciva a lasciare la tela: l’aveva trovata violenta, troppo violenta. Ma era un violenza che colpiva solo lei; lei che non impersonava nessuno dei due, che non conosceva la sensazione di essere avvolta e colmata da una passione che non può attendere. La donna si era avvicinata, le era rimasta al fianco come se fossero giunte lì insieme, come se non ci fosse bisogno di parlare, perché non c’era imbarazzo. Alla fine aveva rotto quel silenzio. ‘‘Siamo sempre in ginocchio’’, aveva commentato. ‘‘Noi donne, intendo’’, aveva aggiunto, voltando appena la testa, lentamente, fermando gli occhi sulla guancia di Waverly. Waverly si era trattenuta dal dirle che pensava che anche lui fosse in ginocchio, perché dubitava che quello rappresentato potesse allontanarsi dall’idea dell’uomo virile e predatorio, suggerito dalle possenti spalle e dalla posa quasi rapace che racchiudeva la sua amante. Non poteva essere così basso. Si era limitata a un sorriso, senza voltarsi, senza reagire davvero. Anche la donna aveva sorriso, soffiando lentamente l’aria della narici, come a schermirsi, ma con un’indulgenza che le era propria, complice. Studiandola con la coda dell’occhio, Waverly aveva capito che la sua interlocutrice doveva aver passato i cinquanta, avviandosi verso il cambio della prima cifra. Le luci bianche, troppo forti della galleria, però, erano state clementi e non erano riuscite a inquinare una bellezza che rifiutava ancora di sfiorire. Quella notte, contemplando il soffitto dal letto di quella sconosciuta, Waverly si era chiesta come sarebbe stato se al mattino si fosse fermata per fare colazione insieme, se le colazioni sarebbero diventate pranzi e cene. Avrebbe continuato ad apprezzare quegli occhi scuri, quando la pelle avrebbe ceduto e li avrebbe un po’ nascosti, quando il tempo li avrebbe resi opachi e spenti? Avrebbe continuato a trovare giovamento in quel corpo morbido, forse già troppo rilassato? Si era chiesta se sarebbe riuscita a perdonare l’amarezza che quella donna aveva nei confronti del mondo, quella disillusione quasi tossica, vittimistica. Aveva raccolto i suoi vestiti, silenziosa come un fantasma, come l’intrusa che era in quella dimora. Aveva fatto colazione in un bar, lontano dalla galleria, lontano da quell’appartamento che non l’avrebbe mai più rivista. Sorrise alla donna che continuava a contemplare le acque con l’immobilità di chi non abbia nessuna guerra da combattere, non col corpo. Le aveva sorriso e si era chiesta perché fosse riuscita a risvegliarle quel ricordo così sepolto nella coscienza, sbiadito come se si fosse trattato solo di un sogno. Distolse lo sguardo e la lasciò all’intimità che si stava ritagliando, senza più cercare di origliare le parole mute che forse rivolgeva alle onde. Col crescere della luna era cresciuta anche la trepidazione dell’Oceano, che ora sembrava una bestia ferita che si dimeni, che brami la carne che non può raggiungere. Waverly si alzò prima che l’onda potesse ghermirla. Camminò all’indietro, quasi avesse paura che la fiera potesse avventarsi su di lei a tradimento. Oramai abbastanza distante, si voltò a guardare la sconosciuta per rivolgerle un saluto silenzioso, un addio solitario, solo suo; per ringraziarla della compagnia che non sapeva di averle tenuto, che ignorava come il conforto che le aveva gentilmente, inconsapevolmente regalato. Inaspettatamente incontrò i suoi occhi, che da quella distanza erano solo due scintille senza iride o pupilla, solo il riflesso della luna. Waverly rimase ferma e la guardò come fosse l’unica cosa possibile, giusta. La donna dai capelli rossi e bagnati fece lo stesso. Poi, quasi con troppa violenza, voltò la testa alla sua sinistra, come se qualcuno le si fosse avvicinato d’improvviso. Su quella spiaggia c’erano solo loro due, e la donna se ne convinse abbastanza in fretta. Tornò a concentrarsi su Waverly, questa volta quasi con stupore e, in pari tempo, con una specie di consapevolezza tutta sua. Waverly alzò una mano, accennando un saluto. La donna non ricambiò, ma sembrò sorridere. Tornò a contemplare l’orizzonte come se l’Oceano l’avesse richiamata, geloso delle attenzioni che stava dando a qualcuno diverso da lui. La corrente di risacca le bagnava le scarpe di tela e l’orlo dei pantaloni, come se davvero cercasse le sue attenzioni, come se volesse trascinarla con sé negli abissi. A lei non sembrava dispiacere, forse lo desiderava. Waverly tornò indietro, vicino al confine fra sabbia e acqua. Finse di cercare qualcosa fra i granelli, finse di trovarlo e raccoglierlo. Tirò fuori il pacchetto delle sigarette e ne accese una. Sperava di attirare l’attenzione di quella donna, che forse si sarebbe avvicinata: aveva l’aria di una bisognosa di nicotina. Non se ne era andata, si accorse, per quel gesto non ricambiato, non speculare. Desiderava ancora gli occhi della donna su di sé, perché quel sorriso non era stato abbastanza, ma era stato magnetico. Forse lo aveva solo immaginato. Forse desiderava solo indispettire l’Oceano, derubarlo. «La notte senza confini. La chiamano così, vero?» Alla fine la donna si era avvicinata, aveva annullato la distanza fra loro e doveva averlo fatto troppo vicina al bagnasciuga, perché la sabbia non conservava l’eredità dei suoi passi. Si era fermata a una distanza che le consentiva di farsi udire senza alzare la voce e che, nel contempo, non risultava invadente. Waverly pensò che la sua voce le fosse giunta gradevole e inattesa, come la festa di un compleanno che si credeva dimenticato. Era stato un suono triste, acuto ma morbido, un po’ infantile ma invecchiato da una dolore che Waverly non conosceva, che non riusciva a indovinare. Che non era sicura di voler conoscere. «Dicono che in questa notte il mondo dei vivi e quello dei morti si mescoli», annuì, aspirando e soffiando fuori fumo e fiato, che si condensarono nell’aria salmastra e gelida che non le feriva più le carni. Avrebbe voluto voltarsi e guardarla, appropriarsi dei suoi lineamenti, scoprire il colore dei suoi occhi, sapere se l’avrebbe trovata bella o se, invece, ci avrebbe visto qualcosa di sgradevole o grottesco. «Dicono così», soggiunse, senza lasciare l’immenso specchio nero. Aveva aggiunto quell’inutile appendice forse all’unico scopo di non lasciare che il silenzio occupasse troppo spazio fra loro. «Dicono così», le fece eco la donna; un’eco che quasi si perse nel vento, rischiando di non raggiungere Waverly. Forse anche lei voleva opporsi all’assenza di suoni. «Fumi?» «Ho smesso», rispose garbatamente. Non si era mossa, continuava a tenere le mani infilate nelle tasche e gli occhi sull’Oceano. Waverly dischiuse le labbra, cercando altre parole. Dalla sua bocca uscì solo il fumo che aveva aspirato dal filtro sottile. Presto si accontentò della presenza silente al suo fianco: mitigava la sua solitudine. Era abbastanza. Il vento cambiò d’improvviso, spingendo verso Waverly l’odore della donna: sale e alcol. Ebbe la certezza di riconoscere la marca di whisky scadente, lo stesso che acquistava sua sorella. La immaginò camminare sul filo dell’acqua come un equilibrista che avesse perso la padronanza della sua arte. Le dita strette attorno alla bottiglia nel cui fondo aveva cercato una risposta; ormai vuota, l’aveva scagliata nell’Oceano e l’aveva seguita, forse perché era caduta anche lei, sbilanciata dal gesto rabbioso. O forse aveva tentato di annegare le sue sofferenze in un bottiglia più grande, una che non l’avrebbe restituita alla vita col mal di testa. Una che non l’avrebbe restituita affatto. Non c’era riuscita, non ne aveva avuto il coraggio, e allora era andata nel panico e gattonato e strisciato fino alla salvezza. Immaginò fosse rimasta lì, fradicia, insistendo nella contemplazione di quanto era avvenuto, rivivendo se stessa come un feticcio posseduto da una forza sovrannaturale, maligna. Qualcosa che col senno di poi, non più annebbiato, aveva stentato a riconoscere, forse addirittura a comprendere, come un folle che rinsavisca d’improvviso, costretto a fare i conti con un se stesso sconosciuto. Una paura estemporanea le mozzò il respiro. Il Bacio di Klimt. Violenza. La mente di Waverly aveva indagato ed esplorato oltre, ma la verità era che quella donna non l’aveva indotta a pensare all’amore e al tempo, né alla passione di una notte. Forse un sistema di difesa l’aveva spinta oltre il dipinto, oltre le sensazioni che le aveva inferto. Oltre la verità, oltre la voce dell’istinto. La guancia sinistra pulsò, ricordò il dorso della mano di Wynonna. Forse anche quella donna l’avrebbe colpita. Forse progettava di afferrarla e di spingerle la testa sott’acqua; forse era questo che vedeva nelle acque: una violenza immotivata, alcolica, troppo simile a quella che forse aveva avuto per se stessa. Si voltò a guardarla, come volesse sfidarla a mettere in atto il suo orrifico progetto. Ma il viso, nascosto dai lunghi capelli grondanti d’acqua, rimase rivolto davanti a sé, non ricambiò la curiosità, non accettò la sfida. Non aveva finito il suo discorso con l’Oceano. L’odore divenne insopportabile. La figura di Wynonna sostituì quella della donna alta. Gli occhi color del cielo di sua sorella si inzupparono di una rabbia triste, di un odio pietoso. «Buon Halloween», mormorò a mo' di saluto. Si voltò e cominciò ad allontanarsi, sentendo che il freddo ricominciava a morderla. Non sarebbe stata vittima anche della rabbia di quella sconosciuta, della sua frustrazione. Della sua violenza. Quella del sangue del suo sangue le era sufficiente. «Sono Nicole.» Waverly si fermò, si voltò e riscoprì il colore dei suoi occhi. I tratti, che la distanza prima e i capelli poi avevano nascosto, non erano grotteschi, ma anzi delicati e armoniosi. Famigliari. Non c’era nulla di violento in Nicole.
N.d.A: Il Fiore della Pazienza è un giglio che sboccia in realtà ogni sette anni; il ventisette era un riferimento alla serie. |
Capitolo 2
*** Due ***
Spazio d’Autore: I capitoli totali saranno in realtà tre: sarebbe stato troppo lungo e pesante.
II. Waverly impiegò qualche secondo a riconoscerla davvero. «Nicole...» Pronunciare quel nome le diede uno strano brivido, come quando da bambina faceva qualcosa che non avrebbe dovuto. «... la figlia della fioraia, giusto?» Aveva fatto in modo di renderla una domanda, solo per educazione. Sapeva benissimo chi aveva davanti. La porta dei ricordi si era spalancata e ogni cosa si stava riversando sulla sabbia, come quando si apre uno sgabuzzino troppo ingombro e disordinato senza le dovute precauzioni. Fu investita e sommersa da immagini e suoni che stentò a sentire come suoi, come se appartenessero a un’altra adolescente, a un’altra Waverly. Nicole strinse le labbra; somigliò a un sorriso. E quel sorriso inghiottì quei quindici anni, li annullò. Ogni venerdì pomeriggio, Charleen e Waverly si recavano al negozio della signora Dubois. La Tulipe Indigo era un grazioso agglomerato di mattoni e vetrine, luminoso anfitrione di infinite varietà di piante e fiori, autoctoni o esotici. Che si desiderassero delle rose rosse per conquistare un innamorato o delle camelie per impreziosire l’ambiente, La Tulipe Indigo era la risposta, la prima scelta di ogni abitante della città. Charleen aveva sepolto il suo innamorato appena il mese prima e da decorare c’era solo la sua lapide di marmo nero. Anche per il funerale si era rivolta alla signora Dubois che, seppur con pochissimo preavviso, aveva preparato e consegnato i fiori per la camera ardente, per la chiesa e aveva realizzato una grande corona funebre, sobria ed elegante, come era nei desideri della madre di Waverly. ‘‘Buon pomeriggio, signora Earp’’, aveva salutato cordialmente la fioraia, accennando quasi un inchino col capo. Negli anni, l’accento francese si era mescolato a quello del posto, dando vita a suoni peculiari e melodici. ‘‘Buon pomeriggio, signora Dubois’’, aveva ricambiato Charleen, con la stessa cortesia ma con la testa ferma, fieramente alta. Waverly trovava divertenti quegli scambi: le ricordavano vecchi film con dame ridicolmente vestite. ‘‘La lavanda è più rigogliosa che mai’’, aveva detto la signora Dubois. Consigliava sempre di aggiungere qualche stelo di lavanda perché, come aveva spiegato a Waverly, la lavanda dice ‘il tuo ricordo è la mia unica felicità’. Waverly aveva sperato la memoria del padre morto non fosse l’unica felicità della sua vita; si era vergognata di quel pensiero e aveva pianto. ‘‘E’ cominciata la primavera’’, aveva detto Charleen, che si era rivolta alla pianta di ciclamini appoggiati sull’angolo del piccolo bancone, come a enfatizzare la sua affermazione. ‘‘Desidero qualcosa che dica che è primavera. Niente colori troppo accesi, ti prego.’’ Mentre le due donne si accordavano suoi componenti del bouquet con cui omaggiare la memoria del morto, Waverly, come ogni volta, aveva cercato con gli occhi Patte. L’aveva trovato subito: era acciambellato fra due vasi di monstera deliciosa; faceva le fusa al raggio di sole che filtrava dalla vetrata rivolta a ovest e che gli arrivava sul pancino. Si era messa seduta sulle caviglie e aveva cominciato a coccolarlo delicatamente, per non disturbare il suo riposo. ‘‘Attenta, potrebbe cavarti gli occhi!’’ Waverly si era alzata troppo bruscamente e aveva rischiato di perdere l’equilibrio, spaventando Patte, che era scappato a cercare rifugio in quella selva di vasi e fiori. Aveva alzato la testa, scoprendo la fonte dello scherzo un po’ meschino. Una ragazza molto alta era sbucata dalla porta che portava al magazzino e da lì, aveva ipotizzato Waverly, si raggiungevano le scale che portavano al piano superiore, dove c’era l’appartamento della signora Dubois. ‘‘Nicole, je t'en prie!’’, l’aveva sgridata la signora Dubois, con una nota di rassegnazione troppo importante nella voce; poi si era rivolta dolcemente a Waverly: ‘‘Monsieur Patte non ti farebbe mai qualcosa del genere, chérie.’’ Infine, alla signora Earp: ‘‘Diciassette anni sprecati, parola mia! La tua ne ha dodici, ricordo bene?’’ ‘‘Ne compirà tredici la settimana prossima’’, aveva confermato Charleen, che aveva subito colto l’occasione per introdurre Wynonna nel discorso. Chi meglio di una fioraia avrebbe potuto comprendere e apprezzare le prodezze del suo giglio? Invero, chiunque sembrava esistere quasi unicamente in relazione a Wynonna, agli occhi di sua madre; anche l’altra figlia, il cui unico scopo sembrava quello di rendersi conto di chi aveva occupato quello stesso ventre tre anni prima di lei. Peccato avesse dovuto aspettare tanto per incontrarla. Quale spreco. Waverly le aveva sentite appena e subito aveva smesso di ascoltarle: la sua attenzione era tutta per la nuova arrivata. Era la quarta volta entrava da La Tulipe Indigo, ma era la prima volta che vedeva Nicole; non sapeva e non si era neppure chiesta se la fioraia avesse figli. Nel frattempo, Nicole aveva annullato la piccola distanza che la separava dal bancone. Senza salutare e senza degnare Waverly di altre attenzioni, si era seduta sulla sedia girevole e aveva posato i piedi accanto al registratore di cassa. Aprendo il libro che aveva tenuto sotto braccio fino a quel momento, si era immersa in un mondo il cui l’accesso sembrava vietato, addirittura impossibile a chiunque altro; ragion per cui Waverly aveva trovato tutto il tempo di studiarla indisturbatamente. Aveva i capelli turchini; su chiunque altro quel colore sarebbe stato parecchio ridicolo, ma Waverly aveva ritenuto che Nicole lo rendesse figo, perché lei era davvero figa. Aveva pensato che dovesse essere una delle ragazze più popolari del liceo, probabilmente la più popolare, e che ogni giorno i suoi compagni litigassero e venissero alle mani, pur di vincere l’onore di sedersi accanto a lei in mensa o di invitarla alle loro feste. Le curate sopracciglia castano chiaro facevano da arco a due occhi nocciola caldo, senza trucco, che si muovevano solo per inseguire le lettere stampate. L’angolo sinistro della sua bocca spuntava da oltre la copertina del libro, in un sorriso indeciso se essere diverto o indignato. Waverly aveva desiderato che Nicole schiudesse le labbra e parlasse ancora: a causa dello spavento non ricordava il suono della sua voce, e questo le aveva quasi fatto spuntare lacrime di vergogna e di rabbia. Le braccia, martoriate da tagli e scottature, che esibiva come fossero dei trofei, spuntavano da una felpa nera senza maniche, troppo grande ma sicuramente comodissima, e terminavano in dita affusolate, ornate da uno smalto nero, molto opaco e rovinato. Quando aveva mosso la mano dal fianco del libro, Waverly aveva pensato che Nicole l’avrebbe usata per voltare pagina. Invece la mano era andata giù e aveva sollevato l’orlo della felpa e, complici gli slip portati troppo bassi, erano stati rivelati dei peli castani e il tatuaggio di una farfalla nera, in stile tribale. Il prurito doveva essersi spostato più in alto, e così la felpa era stata sollevata fino a rivelare i bordi di un reggiseno viola scuro. Sul costato sinistro, accanto a un ventre piatto, forse troppo incavato, c’era un altro tatuaggio, molto più grande ed elaborato. Rappresentava un uomo muscoloso, nudo, seduto a cavalcioni sul dorso di un toro imbizzarrito, che versava dell’acqua da una brocca; sopra di loro, un sole o una luna, formata da due pesci, uno nero con l’occhio bianco e l’altro bianco con l’occhio nero, come lo Yin e lo Yang. Waverly, seppur affascinata, aveva però riportato l’attenzione sul tessuto viola, che lasciava intuire la forma dei seni. Era riuscita a non perdersi neppure un dettaglio: il top del bancone era di legno, ma il corpo di vetro trasparente. Si era convinta che Nicole lo avesse fatto di proposito. La mano di Nicole era tornata sul libro e Waverly alla realtà della stanza. Si era guardata attorno, terrorizzata dall’idea di incontrare il viso scandalizzato e arrabbiato di sua madre o quello della signora Dubois. Ma le due donne si erano spostate in un altro angolo del negozio, dove la fioraia stava componendo il bouquet da portare sulla tomba del signor Earp. Aveva riportato gli occhi su Nicole, ordinandole mentalmente di guardarla, di chiederle scusa. Chiederle scusa per ogni cosa: per essere così bella, per essere più grande, per quel fastidio vagamente famigliare eppure inedito che ora sentiva fra le gambe. Ma le labbra di Nicole erano rimaste chiuse, i suoi occhi sulle pagine; e Waverly non aveva trovato il coraggio di rivolgerle la parola. Sembrava una donna matura, bella e impossibile, così fiera ora che era immersa in quella lettura dall’aria esotica e complicata. Aveva dubitato potesse essere la stessa persona che poco prima le aveva rivolto quelle parole insensate, un po’ meschine. Un’ora dopo, in ginocchio davanti alla tomba di suo padre, Waverly non aveva pregato, non gli aveva parlato e non aveva pianto; aveva continuato a pensare a Nicole, ai suoi capelli, al suo viso, ai suoi occhi, ai suoi tagli, a suoi tatuaggi. Anche la notte, protetta dal buio e dall’intimità della sua cameretta, aveva pensato a Nicole; aveva fantasticato su di lei mentre mandava via il fastidio. L’aveva odiata con tutte le sue forze per essersi imposta così nella sua mente, per non averla invitata nel suo mondo, per aver cambiato il significato a quei venerdì pomeriggio. Per non averla resa reale, semplicemente guardandola. L’aveva odiata perché lei soffriva le pene di un amore nuovo, giovane e insensato, mentre Nicole sapeva a malapena della sua esistenza. Per i successivi tre anni, Waverly aveva atteso il venerdì come se fosse Natale. Nicole era diventata la sua ossessione: scriveva il suo nome ovunque, anche sui diari, sui quaderni e sul banco di scuola, decorandolo con fiorellini, stelline e cuoricini; fantasticava di parlarle e di dichiararle il suo amore, un amore che Nicole avrebbe ricambiato con trasporto e tenerezza. A un certo punto, la signora Dubois aveva avuto un incidente e la sua gamba era rimasta quasi del tutto paralizzata: Nicole l’aveva praticamente sostituita. Waverly non aveva provato vergogna per la gioia che le aveva riempito il petto: Nicole sarebbe stata presente ogni venerdì e non le avrebbe mai più spezzato il cuore con la sua assenza. Ma Nicole, in tutti quegli anni, in tutti quei venerdì, aveva rivolto a Waverly poche parole, sempre le stesse: ‘‘Ciao’’, ‘‘Il resto’’, ‘‘Arrivederci’’; e lei non aveva mai osato pretendere di più, non ne aveva mai avuto il coraggio. Poi, un venerdì che sembrava uguale a tutti gli altri, Waverly e Charleen avevano trovato il negozio chiuso, svuotato. Il cartello VENDESI risaltava contro quel vuoto con troppa violenza, come se quelle lettere fossero mani protese, pronte a strapparle il cuore dal petto. Il mese successivo La Tulipe Indigo era diventato un negozio di scarpe. E Waverly non aveva più rivisto Nicole. «Sei diventata una donna», commentò Nicole quando Waverly tornò al suo fianco, spoglia di ogni paura, ma col cuore leggermente veloce e il respiro affannato, a causa della corsa nei ricordi. «Ai miei occhi, tu sei sempre stata una donna. Lo eri prima del tempo.» Nicole non si offese. «Ho sempre amato bruciare le tappe», annuì. Il volto era ovviamente maturato, ma non sembrava rispecchiare gli anni che avrebbe dovuto avere, come se il tempo, a un certo punto, si fosse dimenticato di carezzarlo e di inciderci le tacche dei giorni, dei mesi e degli anni. Si chiese se la trovasse ancora bella. Sì, assolutamente. Anche con quell’aria sofferente e trascurata, Nicole era ancora bellissima. Desiderò innamorarsi di nuovo di lei. Si chiese se avesse mai smesso di esserlo. No, assolutamente. Neppure il tempo può uccidere il primo amore; può solo addomesticarlo. Si scoprì a desiderare che Nicole compiesse una follia, che le proponesse di fuggire insieme. Avrebbe accettato, sapendo di mentire. Per qualche settimana si sarebbe rifugiata in quella bugia. Avrebbe permesso a Nicole di farla sentire di nuovo ragazzina. Viva. Poi le avrebbe spezzato il cuore e le avrebbe nuovamente detto addio. Contemplò quei pensieri senza chiedersi perché fossero arrivati; non le importava. Li guardo allontanarsi e svanire, inghiottiti dalle onde. «Non ero sicura fossi davvero tu», disse Nicole, infrangendo di nuovo la barriera del silenzio. «Io lo ero.» Sul suo viso comparve un sorriso mesto, maturo. «Avevo una cotta per te.» Alla confessione non seguì nessun imbarazzo, forse solo il desiderio di dirle che pensava non le fosse ancora passata. «Veramente?» Waverly accolse la nota d’ironia con un altro sorriso. Si frugò nelle tasche e si accese un’altra sigaretta: di solito ne fumava una o due al giorno, ma si sentiva irrequieta, anche se era quasi piacevole. «Questa è la conversazione più lunga che abbiamo mai avuto», notò. Nella sua mente si scontravano ancora ricordi e pensieri un po’ intrusivi. «Anche prima non sembravi intenzionata a parlarmi. Perché mi hai detto chi eri?» Nicole alzò leggermente le spalle, quasi involontariamente. «Volevo sapere se il mio nome avrebbe suscitato una reazione.» «L’ha fatto.» Le sorrise, come a chiederle di non badarci; poi: «Sei sempre stata un po’ eccentrica, forse per questo riuscisti a sconvolgere la mia giovane mente. Ma il bagno al 31 di ottobre, nell’Oceano, non ti sembra un tantino eccessivo? Non senti freddo?» «Non sento nulla», rispose spontaneamente. Cercò di rimediare: «No, non sento freddo. Grazie per averlo chiesto.» Abbassò un momento lo sguardo e, riportandolo negli occhi di Waverly: «Perché non mi hai mai detto che ti piacevo?» «Lo sapevi.» «Sì. Ma perché non me lo hai mai detto?» Questa volta fu Waverly ad alzare le spalle. «Mi facevi paura: ti vedevo come qualcosa di... irraggiungibile.» «Eppure, eccoci qua.» «Già», annuì, e prese tempo aspirando e soffiando fuori il fumo. «Non pensavo che ti avrei mai rivista. E’ strano farlo così.» «Piacevole o spiacevole?» «Strano», ripeté, perché non sapeva rispondere alla domanda di Nicole. «Per te?» «Decisamente piacevole.» «Come sta tua madre, la signora Dubois?» «Non la vedo da anni.» Guardò per un momento la luna, poi abbassò di nuovo lo sguardo su Waverly: «La tua?» «Con papà, mi piace pensare.» «Mi dispiace.» Waverly annuì e mormorò un «grazie». «Brutta serata?» La guancia di Waverly pulsò in risposta allo sguardo di Nicole. Prima che potesse dire qualcosa, lei aggiunse, rapidamente: «Scusa, non sono affari miei.» «E’ stata mia sorella, dopo che l’ho mandata a farsi fottere e ho minacciato di non farmi più vedere. Ti ricordi di lei?» «La ragazza che mi guardava come se avesse voluto farmi un’autopsia: come potrei dimenticarlo? Mi diede i brividi. Quel giorno tua mamma aveva la febbre - giusto? - per quello ti accompagnò lei. Fu l’unica volta che la vidi. Abitate ancora insieme?» Waverly annuì. «E a te va bene così?» Ho paura che se me ne andassi davvero, lei si taglierebbe le vene nella vasca da bagno; per questo non posso fuggire con te, pensò. Disse invece: «Perché sei venuta qui?» «Qui o da nessun’altra parte. Tu?» «Avevo paura del coltello con cui stavo intagliando la zucca, l’ultima sopravvissuta. Avevo paura di piantarglielo nel petto.» «Mediti spesso di uccidere tua sorella?», chiese, e dalla sua voce non trapelarono emozioni, solo genuina curiosità. «Qualche volta.» Spense la sigaretta sulla sabbia e si mise il mozzicone in tasca. «Forse aspetto che sia lei a uccidere me.» «Ne sarebbe capace?» «Non lo so. Non conosco quella donna.» «Possiamo cambiare discorso, se vuoi.» «E perché mai?» Rise amaramente. «A volte mi domando se io esista davvero, o se sia solo un suo riflesso opaco, troppo smorto per avere davvero un’identità mia.» Nicole spostò l’attenzione sull’Oceano. Forse il silenzio sarebbe tornato troppo denso e avrebbe cancellato i suoni che avevano rimbalzato fra di loro. Forse era tempo di voltarsi e non tornare indietro. «A volte mi domando qualcosa di simile», disse infine; e Waverly capì che non era ancora tempo di dire addio. «Sei incredibilmente reale», aggiunse, voltandosi e sorridendole delicatamente. Avrebbe voluto ricambiare, ma si accorse che sarebbe stata una bugia: Nicole era lì, al suo fianco, ma, esattamente come allora, sembrava irraggiungibile, inafferrabile. Solo il sogno di una ragazzina. «Posso confessarti una cosa?» «Certo», disse, sollevata, perché ormai il tempo l’aveva liberata dall’obbligo di rispondere alla precedente affermazione di Nicole. «Ho voglia di piangere. Non riesco a ricordare l’ultima volta che l’ho fatto, che mi sono abbandonata a un pianto liberatorio. Tu ricordi la tua ultima volta?» Waverly impiegò qualche secondo ad accettare che quelle parole fossero giunte da Nicole. «Fallo, sfogati. Non ti giudicherò», disse infine. «Scusa. Non so perché l’ho detto.» «Perché siamo tutti crudeli, siamo tutti dei mostri, tutti noi costringiamo a piangere la gente.» * Si voltò a guardarla e, per un momento fugace, la rivide diciassettenne. «Ricordi?» Nicole socchiuse gli occhi e inclinò leggermente la testa d’un lato. «Dostoevskij...?», tentò dopo qualche secondo. Waverly annuì lentamente, permettendo ai pensieri di diventare parole. «Stavi leggendo I fratelli Karamazov, quando ti ho conosciuta. Supplicai mia madre di comprarmelo; rifiutò. La signorina Tremblay, la bibliotecaria, non ha mai più rivisto quel volume. E’ diventato il tesoro della mia adolescenza; l’ho letto e riletto fino a consumarlo, ma non credo di averlo mai davvero capito.» «Non so quali fossero i miei pensieri, al tempo: eri più piccola di me; all’inizio, davvero troppo piccola per me», confidò. «Ma ricordo che la tua presenza mi confortava, esattamente come sta facendo adesso. Ogni venerdì sentivo i tuoi occhi addosso, li percepivo come una forza fisica su ogni mio movimento. Mi piaceva, mi faceva sentire importante, tangibile.» Tornò al discorso precedente, forse troppo bruscamente, togliendo alla Waverly adolescente quel piccolo momento di gloria: «Penso che quel libro, che quella frase in particolare fosse un monito. Sì, ne sono convinta. Quando i miei occhi ci passarono sopra, pensai semplicemente che fosse una bella frase, adatta a un tatuaggio. Ora mi chiedo quanto pesanti sarebbero le lacrime di coloro che ho ferito, se potessi raccoglierle tutte. Mi chiedo se potrei annegarmici.» In sincronia, come se fossero ballerine intente a seguire una coreografia, si voltarono verso l’Oceano. I capelli e gli abiti di Nicole gocciolavano ancora, come se fosse appena riemersa dal soggetto delle loro riflessioni. «Sei caduta?» «Davvero troppo in profondità.» «Mi chiedo se sarò in grado di riemergere anch’io, dall’abisso in cui mi trovo...» mormorò, dopo aver soppesato le parole di Nicole. «Ce la farai. In un modo o in un altro.» «In un modo o nell’altro...» «Tornerai a trovarmi?», chiese Nicole, la cui voce era incerta come le timide luci arrivate ad annunciare che l’alba non era lontana. La notte era trascorsa come un sogno, troppo breve e incontrollabile. Waverly non rispose, impegnata ad analizzare la peculiarità con la quale Nicole aveva scelto le parole. «Lo farai?», insisté. Guardava l’orizzonte come se si aspettasse che da un momento all’altro ne sarebbe spuntato un mostro. Ma l’Oceano celava solo il sole. «Posso lasciarti il mio numero di telefono, così mi dici dove venire», propose. Nicole scosse lentamente la testa, sconsolata. «Non so dove vivi...» Per qualche ragione, le sue stesse parole le diedero un brivido. «Non so come ritrovarti», aggiunse subito, tentando di cancellare la sensazione. «Ho solo bisogno di sapere se posso ancora esistere per te. Se ne ho ancora il diritto.» Sembrò un guaito. Con profondi tristezza e rammarico, Waverly pensò che la mente di Nicole fosse irrimediabilmente danneggiata dall’alcol, esattamente come quella di Wynonna. Il momento di lucidità, dato paradossalmente dalla sostanza, era finito, le cicatrici riaperte come bocche assettate. Provò un fastidio che quasi la soffocò, una rabbia simile a quella di quel tempo lontano. La odiò. Rivide il Bacio di Klimt; quell’oro eccessivo, violento come il sole che stava nascendo per uccidere quel loro momento. Odiò anche lui. «Devo andare. Sono preoccupata per mia sorella...» Nicole annuì piano e gli occhi le si fecero grandi d’orrore. La bestia stava per emergere. «Mi ha fatto piacere rivederti», disse, voltandosi e puntando verso la linea d’alberi in lontananza. Questa volta non sarebbe tornata indietro. Era tempo dell’ultimo addio. «Non ci sarebbe il peso delle tue lacrime, Waverly. Se avessimo avuto entrambe più coraggio, non ti avrei mai fatta piangere.» Waverly si voltò. Il primo raggio di sole l’abbagliò e l’aria fredda la ferì come se mille aghi le si fossero piantati nei pori. Subito dopo, il suo corpo sperimentò il brivido di un gelo che nessun inverno avrebbe mai potuto eguagliare. Nicole era scomparsa. --- N.d.A: * Non sono sicura che la citazione appartenga all’opera che ho indicato: non sono riuscita a verificarlo. Se qualcuno fosse in grado di confermare o correggermi, non esiti. Grazie :) |
Capitolo 3
*** Epilogo ***
III.
Waverly rimase immobile; gli occhi fissi sull’Oceano e il petto pieno di piccoli fiocchi argentei. Aveva sempre prestato attenzione al suo corpo, a come gli stimoli esterni, fisici o astratti, lo facessero sentire, cosa le facessero provare. I fiocchi argentei simboleggiavano il panico; una paura diversa da quella che fa sobbalzare le persone o che le fa scappare: quella, per Waverly, era un’onda verde chiaro su uno sfondo nero, improvvisa, che vedeva poi, quando ci ripensava, dopo essersi messa al sicuro. I fiocchi avevano la tendenza a trasformarsi in chiodi, in attesa che un martello invisibile inchiodasse i piedi al terreno. Quel martello era sempre puntuale e non sbagliava mai un colpo. Aveva provato quella sensazione solo due volte, prima. Per espresso desiderio di Charleen, il funerale del signor Earp si era svolto a bara aperta. ‘‘Che possa vedere i volti affranti di coloro che l’hanno amato”, aveva detto. Waverly non voleva avvicinarsi, non voleva vederlo. Aveva paura dei morti. Aveva paura di vedere suo padre morto. Sua madre non le aveva lasciato scelta. Le sue parole erano strisciate fino alle orecchie della ragazzina e avevano avvelenato il denso, precario silenzio degli spazi chiusi ma troppo ampi. Il gelido vento di febbraio, che spirava dal grande portone della chiesa, lasciato spalancato come una bocca ammonitrice, cosicché ognuno si sentisse obbligato a porgere sinceri rispetti, aveva sostituito le mani di Charleen e aveva spinto Waverly attraverso la navata, passo dopo passo. Il suo cuore aveva accelerato, centimetro dopo centimetro; si era convinta che l’eco dei suoi battiti stesse colpendo tutti i presenti come enormi palle di cannone, che li stesse assordando come stava assordando lei. Gli occhi avevano scavalcato le sottili pareti di legno scuro, rivestite da morbido tessuto imbottito color crema. Era rimasta in attesa, come quando lui si appisolava sul divano e attendeva che lei lo svegliasse per cenare. Il signor Earp non aveva riaperto gli occhi e non le aveva sorriso. Quell’espressione era vuota, senza significato, come se la faccia fosse stata resettata e non fosse più in grado di accoglierne neppure una, di espressione. Qualche sporadico fiocco d’argento aveva cominciato a cadere, troppo debolmente, come una giornata d’inverno che non ci creda abbastanza. Waverly aveva cercato nelle rughe del volto di suo padre le cicatrici di cinquant’anni di risate, di sorrisi allegri, tristi e falsi, di pianti sconsolati, ilari e iracondi. Non ve n’era traccia. Non si era arresa e aveva indagato ancora, intenzionata a riconoscere in quel pallore un riflesso di se stessa. Era stato un errore; forse il primo, più grande errore della sua giovane vita. I suoi occhi avevano trovato e seguito i contorni tondeggianti che deturpavano la tempia senza colore, dove i capelli erano stati piantati nel cranio, spinti dal piombo. Sono stanco, diceva il bigliettino che aveva lasciato. Doveva essere stato davvero molto stanco, perché aveva scelto il sonno più lungo, quello che la vita aveva solo brevemente interrotto. La bufera era esplosa come se non avesse aspettato altro; il martello aveva piantato l’ultimo chiodo prima che Waverly potesse accorgersi della sua presenza. Non aveva potuto muoversi. Non aveva potuto fuggire. Anche le lacrime erano rimaste congelate dietro gli occhi, da qualche parte nella profondità del suo Io. Con orrore, aveva pensato che, se non fossero riusciti a rimuoverla di peso, avrebbero scelto di seppellirla con suo padre. Era stato un pensiero illogico, ma del resto il terrore non è quasi mai un intellettuale; è una bestia che comprende solo una lingua e a volte la fraintende: l’istinto. “Non è papà”, aveva detto Wynonna, che era arrivata senza farsi udire, che aveva aumentato l’intensità dei fiocchi per poi placarli un poco. “Quella è solo carne, come quella che si compra al supermercato. Prima erano mucche e maiali, ora sono solo cibo. Quello è solo cibo per vermi.” Le aveva baciato i capelli. Col naso ancora premuto contro il suo viso, aveva ribadito: “Non è papà.” Dal quel momento non sarebbe più riuscita a mangiare la carne, neppure a guardarla. Ma i suoi piedi erano liberi. L’avevano condotta indietro, verso il genitore sbagliato. “Non ti ho vista pregare”, aveva detto Charleen. “Torna da tuo padre e chiedi a Dio di avere cura di lui.” Waverly le aveva spiegato che quello non era più suo padre, aveva riportato le parole di Wynonna, sicura che sua madre avrebbe compreso, perché Wynonna non poteva sbagliarsi. Lo schiaffo era esploso in quella cassa di marmo come lo sparo che l’aveva svegliata tre notti prima. Charleen aveva alzato di nuovo il braccio, ignorando i mormorii e gli sguardi che si erano posati attoniti e oltraggiati sulla scena. Non era riuscita a colpire Waverly una seconda volta: Wynonna le aveva afferrato il braccio. “Non toccarla”, aveva ordinato a sua madre, con la faccia e il tono di un genitore che riprenda un figlio troppo ottuso, impegnato a tormentare una creatura. Charleen aveva accolto il volto del suo giglio tra le mani che sapevano essere amorevoli solo per lei; le aveva sorriso e le aveva ricordato quanto fosse sensibile, quanto fosse speciale. Wynonna si era sottratta al contatto, aveva preso per mano Waverly e insieme avevano lasciato la chiesa. “Ci sono io”, le aveva detto, stringendo la piccola mano nella sua, che appariva già troppo grande, troppo stanca. La seconda volta che i fiocchi d’argento avevano turbinato violenti nel suo petto, era stata proprio quando aveva creduto che Wynonna non ci fosse più. L’aveva trovata sul letto solo per metà: la fronte sosteneva il resto del corpo nella larga pozza di vomito, sul tappeto. Era rimasta a guardarla senza riuscire a muovere un muscolo, senza essere sicura di nulla, neppure di respirare. Poi, dopo un’eternità troppo densa e crudele, Wynonna aveva tossito e si era ritratta con una smorfia, disgustata dal frutto degli errori in cui era immersa. “Non ce la faccio più”, aveva detto Waverly, quando aveva ritenuto che sua sorella potesse sentirla. “Prendimi dell’acqua”, aveva gracchiato in risposta. Waverly non si era mossa; non perché non ne fosse ancora in grado, semplicemente perché quell’immagine era troppo misera e sbagliata per poter essere ignorata. “Non ce la faccio più”, aveva ripetuto. “Ho appena seppellito nostra madre!”, aveva urlato Wynonna. “Dammi tregua, cazzo!” “Io ho seppellito nostra madre”, le aveva ricordato. “E’ stato due settimane fa, in caso tu avessi perso il conto delle bottiglie.” Aveva sospirato, cercando di ricacciare indietro le lacrime. “Mi chiedo dove troverò la forza per seppellire te. Se sarò disposta a non lasciarti marcire sul pavimento.” Wynonna era strisciata giù dal letto, senza curarsi dello schifo con cui si stava imbrattando le mani e i vestiti. Dopo un paio di tentativi si era messa in piedi, aveva raggiunto Waverly e le si era fermata davanti. L’aveva guardata un momento negli occhi, solo per un breve istante; poi aveva abbassato lo sguardo sulla sua bocca, come se avesse voluto controllare che quelle parole fossero uscite da lì. Infine aveva chiuso gli occhi e appoggiato la fronte a quella di Waverly. “Dimmi che mi vuoi bene”, aveva mormorato. Anche Waverly aveva chiuso gli occhi. Aveva lottato per ignorare l’olezzo emanato da sua sorella e il vomito che le inumidiva la fronte. “Se il mio amore avesse potuto qualcosa, a quest’ora saresti immune alla vita.” Aveva riaperto gli occhi e se n’era andata. Dalla stanza accanto, aveva ascoltato il pianto di sua sorella, i suoi latrati. Aveva pianto anche lei, piano, senza farsi sentire neppure da se stessa. Aveva venticinque anni, ma la sensazione di essere nell’inverno della vita. Waverly si lasciò cadere, trovandosi ancora una volta seduta sulla sabbia. Il suo corpo, digiuno, provato da una notte insonne e dal gelo che ora lo attanagliava con ferocia, come a vendicarsi per essere stato neutralizzato da una forza superiore, non era riuscito a reggere il turbinio di fiocchi. Anche se fosse stato possibile salvare Nicole, Waverly non ci sarebbe riuscita: i chiodi erano oltre la sabbia, troppo in profondità. «Non è possibile...» trovò la forza di mormorare. Era possibile eccome, e lei aveva accettato la verità prima ancora di contemplarla. La scia di indizi palesi era troppo lunga, troppo esplicita. Lo sapeva da principio, aveva solo scelto di razionalizzare, di rendere comprensibile e famigliare qualcosa che non lo era abbastanza. «Non è possibile», si ostinò a mentire, quasi le sue parole potessero modificare la realtà. Non potevano più farlo: ormai, la notte senza confini si era conclusa, le sue regole dissolte al sole. L’Oceano richiamò a sé nubi scure, come uno stregone che richiami le sue ombre. Quella nuova oscurità era troppo luminosa; ma Waverly sapeva che, anche in caso contrario, le onde non le avrebbero restituito Nicole. Aveva smesso di mentire. Le lacrime avevano cominciato a rigarle il viso; non sapeva quando, sapeva solo di non voler ingigantire la prigione d’acqua e sale: le asciugò e lottò affinché non ne nascessero altre. Fallì. La cosa la fece arrabbiare. Si rese conto di essere sempre arrabbiata, sempre incazzata con tutto e tutti. Si rese conto di provare odio più volte di quante volesse ammettere. Delle cinque emozioni, una soltanto. Di tutti i sentimenti, solo quello. Tirò fuori il cellulare: aveva bisogno di sapere.
Le risuonarono nella mente le parole di Nicole: ‘‘Mi piaceva, mi faceva sentire importante, tangibile.’’ Tangibile. «Eri un fantasma molto prima di morire.» La mente adulta aveva cominciato a correggere quella adolescenziale, a rivelarle i dettagli, gli indizi della verità. Niente volti festosi di liceali ubriachi e intenti a pomiciare; nessun salotto scosso da musica troppo alta, strabordante di alcol, di sostanze e cibo spazzatura. Una sola persona; una piccola stanza da bagno. Le braccia protese; la lametta che scorre sulla pelle, la lacera; il lavandino sporco di rivoli e gocce rosse. Una richiesta d’aiuto o d’attenzione? Un dolore fisico per sopire quello dell’anima? Portali dai quali far sgorgare i demoni e le loro voci? Forse tutto quanto. Una magrezza per nulla sexy, eccessiva: un corpo consumato e debole. Tatuaggi in sostituzione di lividi mai maturati, ma non per questo assenti. «Mi dispiace tanto, Nicole.» Il pianto da mesto si fece violento, la scosse come i tuoni scuotevano il cielo, in lontananza. Forse il suo pianto non aveva senso, ma chi poteva deciderlo? Accolse la tristezza con gioia, gustandosi le emozioni e le lacrime come fossero dolciumi. Osservò l’Oceano, agitato, iroso, forse perché il segreto non era più tale. Quella furia contrastava con lei, che ora era calma, che aveva capito e accettato quel nuovo dolore. Quando i due mondi si erano mescolati e separati ancora, qualcosa era rimasto dal lato opposto, oltre il confine ora solido e invalicabile: le menzogne.
La sera prima non aveva recuperato le chiavi, le aveva lasciate sul mobiletto d’ingresso: non c’erano state le forze per contemplare qualcosa di diverso dall’uscire di lì. Waverly valutò per un momento il campanello, chiedendosi quanti ditini l’avessero pigiato invano, rendono l’aspettativa delusione. La lucina ora inutile, sfarfallante, sembrò suggerirle qualcosa. Abbassò la maniglia, scoprendo che il campanello non le aveva mentito: la porta era aperta. Entrò e respirò l’odore famigliare, più intenso e denso ora che il suo naso non l’accoglieva da ore. Ogni casa ha un suo odore: è un miscuglio di tanti mobili, oggetti, vernici, persone e abitudini. Quella casa odorava di vecchi mobili, di libri, di detersivo per piatti, di legno, di Waverly e di alcol. Una nota dolce, famigliare ma fuori posto la condusse in cucina. I cadaveri delle due zucche giacevano sul pavimento, dove li aveva lasciati; la terza, sull’isola di radica, la guardava col suo unico occhio, trafitto dal coltello che non aveva finito il lavoro. Tornò a quelle a terra, rivide le mani tremanti di Wynonna, riascoltò la battuta che non aveva divertito davvero nessuno. «Dopo», disse, come fossero esseri senzienti. «Forse dopo.» Uscì dalla cucina e si voltò verso le scale. Non le salì: un altro odore, quello che cercava, le indicò la giusta direzione. Wynonna giaceva sul divano del salotto, sorda agli schiamazzi di Shaggy e Scooby-Doo, che si contendevano un biscottino fuori da un castello dall’aria sinistra e magica. Li guardò per un po’, rapita e consolata da dinamiche non più così estranee, ma neppure famigliari. Riportò gli occhi su Wynonna e lì li lasciò. Una ciocca di capelli, neri come l’ala di un corvo, le nascondeva tre quarti del viso, lasciando però esposta la bocca, da cui colava un piccolo rivolo di saliva. «Ti odio.» Wynonna si mosse appena, come se una mosca le avesse solleticato il naso. Non era ancora del tutto sveglia, ma il suo cervello doveva aver registrato qualcosa, se non la voce, la presenza. «Ti odio», ripeté quando gli occhi freddi come la brina si posarono su di lei. «Buongiorno anche a te», bofonchiò Wynonna, tirandosi su a sedere e cercando con le dita la bottiglia vuota per tre quarti, ai piedi del divano. Riuscì solo a stringerle il collo. Il calcio di Waverly le fece mollare la presa e scaraventò la bottiglia contro la TV, proprio quando la maschera del villain di turno stava per essere rimossa e l’identità rivelata. «Che cazzo, Waverly!», esplose, scrollando la mano che era stata colpita e balzando in piedi. «Che cazzo!» Waverly l’afferrò per le spalle e la spinse, facendola ricadere sui cuscini. I suoi palmi conservarono il ricordo delle sue ossa, del peso quasi inesistente di quel corpo gonfio d’alcol e autocommiserazione. «Ti odio!», ribadì, graffiandosi la gola. «Guarda che ho capito.» Spostò lo sguardo sul televisore senza vita, e un ghigno demente le sollevò gli angoli della bocca: «Vorrei tanto sapere perché odiavi anche lui, però.» «Smettila con queste battutine di merda! Smettila! Non sei divertente e non c’è alcuna tensione da stemperare: qui è dove trova il suo apice!» Wynonna aprì la bocca per ribattere. Evidentemente, però, le lacrime che erano spuntate negli occhi di sua sorella la convinsero a desistere. «Chiedimi perché ti odio», disse, tirando su col naso e ricacciando dignitosamente le lacrime indietro. «Chiedimelo, Wynonna.» La donna aprì le braccia, come a dire che la cosa fosse ovvia. «Perché?», chiese comunque, decidendo di assecondarla. «Perché mi odi?» «Secondo te?» «Non credo che funzioni in questo modo, sai? Anzi, sono piuttosto sicura che-» «Sai qual è la verità?», la interruppe. «Che non conosco le regole del giochino che stai mettendo su?» Waverly la ignorò. «La verità, Wynonna, è che tu non sei speciale.» Per un minuto o forse per un’eternità, le parole aleggiarono fra di loro. Il corpo di Wynonna si era irrigidito e rilassato come se si fosse appena tolta una grossa spina dal piede. Il suo volto, invece, non aveva ancora deciso come reagire: tremolava, andava a scatti, come se gli fosse impossibile decidere quale espressione ospitare, quale emozione o quale sentimento manifestare. Erano parole che potevano fungere da punto fermo, senza altri capoversi. Racchiudevano il senso di ogni cosa. Era la verità che sconfigge la menzogna. Ma Waverly non aveva finito. «Nostra madre era folle, completamente fuori di testa. Ti ha riempito... No: ci ha riempito la testa di stronzate per anni. Ha riempito la mia testa di merda e menzogne! Ha rovinato la vita di ogni singolo componente di questa famiglia. Papà, tu e io: tutti vittime della sua follia! Se tu fossi speciale, te ne saresti accorta, avresti fatto qualcosa! Invece guardati: vittima delle menzogne che la tua assoluta normalità non è riuscita a contemplare mai!» Si portò una mano alla fronte, come se il cranio stesse per aprirsi. «Ti odio perché è troppo tardi per odiare lei.» Il volto di Wynonna aveva scelto un’espressione, ma Waverly non riuscì a decifrarla. Puntò il dito fra la finestra e il televisore morto, come se, voltandosi, entrambe avessero potuto vedere il soggetto: «Sai perché non le ho mai detto che mi piaceva?» «Non sono neppure sicura di chi stiamo parlando», ammise, con assoluta pacatezza. Sembrava un naufrago che si fosse arreso all’attesa, ma su un’isola ospitale e piena di viveri. «Pensandoci, però, credo di aver capito: chi altri, se non lei? No? Il suo nome era ovunque, letteralmente: sulla porta della doccia, sugli specchi, sui tovaglioli che scarabocchiavi invece di mangiare. Davvero, ovunque. Felice che negli anni il tuo fare ossessivo si sia calmato.» «Dillo. Di’ il suo nome. Voglio che risuoni in questa stanza, voglio che tu lo renda reale.» Wynonna sospirò e si mise dritta, come se si stesse preparando a qualcosa di topico. «Perché non hai mai detto a Nicole che ti piaceva?» Il volto di Waverly si stropicciò come una cartaccia in attesa del cestino, i suoi occhi vomitarono lacrime troppo grosse per essere trattenute. «Perché io non sono mai stata speciale!», guaì. «Perché io ero la figlia sbagliata, la ragazzina stupida il cui unico compito era quello di annaffiare il tuo vaso! Perché solo qualcuno come te avrebbe potuto pensare di poter esistere per Nicole!» Provò a calmarsi. «La verità, però, è che non c’era nulla di speciale neppure in lei: Nicole era perduta quanto, se non più di noi due...» Sorrise, ma la sua bocca non gradì l’iniziativa: venne fuori lo storpio di un ghigno triste. «E’ tutto assolutamente così sbagliato.» «Lo è...» annuì. Si alzò lentamente, come se avesse paura di farla scappare. «Mi dispiace tanto, Waverly», sussurrò, e avanzò piano verso di lei. «Mi dispiace», disse ancora, tergendo la lacrima dalla guancia che la sera prima aveva colpito. Waverly lasciò che le mani di sua sorella la toccassero senza ferirla; si godette il calore famigliare e la fragilità che aveva imparato a riconoscere nei suoi nervi e nei suoi muscoli. Poi le afferrò i polsi, bloccandola anche con lo sguardo. «Se la settimana prossima non sarai nella clinica di cui abbiamo parlato, non disturbarti a cercarmi. L’appuntamento sarà il prossimo Halloween, in riva all’Oceano: se non ti farai aiutare, mi potrai rivedere solo là, solo una notte all’anno.» Si staccò da lei e puntò alla porta che conduceva nell’atrio. «Sono seria.» «Di cosa stai parlando? Dove stai andando?» «A cercare un fiore da donare agli abissi.»
«Una volta, mentre parlavi con la vedova Lee, ti sentii dire che il tuo fiore preferito era la margherita.» Sorrise, girandoselo fra le dita e studiando i petali bianchi. «Fino a quel momento avevo trovato le margherite insulse, i più bruttini tra i fiori. Credo che ora siano anche i miei preferiti. Aspetterò il nostro prossimo appuntamento per chiederti cosa dicono le margherite.» Alzò lo sguardo sull’orizzonte, senza guardare nulla di specifico, non l’Oceano e neppure la luna piena. «Non so se puoi sentirmi, Nicole. Ma se puoi, sappi che ho intenzione di andare a fondo... alle tue parole. Capire se potremmo trovarci simpatiche e innamorarci davvero.» Avanzò verso l’acqua e si mise in ginocchio, senza preoccuparsi del gelo che cominciava a dilaniarla. Poggiò il fiore e lo guardò salpare. «Non so quando, ma so che un giorno la morte rivelerà ciò che la vita ha nascosto...» ... perché agli occhi di Morte nessuno è speciale.
|