Foulard - Trattato sui Sensi
(/viewuser.php?uid=127372)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Parte prima - De Gustibus ***
Capitolo 2: *** Parte seconda - De Naribus ***
Capitolo 3: *** Parte terza - De Auribus ***
Capitolo 4: *** Parte quarta - De Tactu ***
Capitolo 5: *** Parte quinta - De Visu ***
Capitolo 1
*** Parte prima - De Gustibus ***
|
Inizio col dire, "EFP, ma quanto
mi sei mancato" ** Vi avviso già adesso, non potrò dedicarmi a lavori troppo impegnativi, ma vedrò di fare del mio meglio ** Questa è una trama che ho in testa da tempo e proprio ieri ho gettato l'amo al largo per ripescarla e porla sotto revisione *mode professoressa on*. Saranno giusto cinque capitoletti, forse sei. Spero con il cuore che vi piaccia e che io riesca a trasmettervi tutto l'amore che provo per Saint Seiya e per questa coppia che le giovani fan sbavose - lol - hanno creato. Questa fic mi è stata ispirata dalla canzone di cui ho scritto un brano qui sotto *mostra con ditino* Vi invito ad ascoltarla ** Buona lettura **
Dew_ "In good old times, remember, my friend
Sciolgo il nodo. Lo faccio piano, con un cert'atteggiamento colpevole, come se alle mie dita
proprio non interessino i pensieri che mi inquinano la mente. So che lui non
vorrebbe, e ciò che sto facendo mi è dettato più dall'istinto che dalla
razionalità. Alzo lo sguardo su mio padre mentre stringo nel pugno i lembi del
foulard. Forse mi aspetto una sua reazione, Sto ancora accarezzando quel fazzoletto di seta quando le mie gambe hanno già mosso i primi passi. Tre mesi prima Artigliai con così tanta rabbia la cornice d'argento che per un istante
ebbi quasi paura di incrinarla; e la stessa sensazione l'ebbe molto
probabilmente mio padre, perché il suo sopracciglio destro si arcuò un poco in
quell'espressione che odiavo. Era la tipica faccia di un genitore che sa di
aver sbagliato, una di quelle che ti fanno sentire prepotentemente nel giusto.
Ma più che nel giusto, in quel momento mi sentivo una bestia. - No. Non puoi - gli soffiai addosso. - Ma... - Quel biondo qui dentro non ci entra. Mentalmente rettificai, biondino. Biondo ero io, perché
"biondo" è un aggettivo superiore. Un ragazzo biondo è un ragazzo
conteso. Invece Shaka Mudaliar era solo un biondino e nient'altro. Detestavo
tutto di lui: l'atteggiamento, l'abbigliamento, il nome. E i capelli, troppo
lunghi per un ragazzo, più luminosi dei miei. Il subconscio mi suggeriva che
tutto sommato la mia fosse solamente invidia e non odio, ma il mio orgoglio
aveva soffocato con arroganza tutte queste fastidiose vocine interiori. E le
stava soffocando anche quel pomeriggio d'agosto, mentre l'afa oppressiva di
Bristol boccheggiava sulle finestre spalancate della mia stanza. - Te l'ho detto papà, io quello qui non lo voglio. - Aiolia, sei grande ormai. Ti chiedo solo un po' di comprensione. Lo sbirciai di traverso. - Comprensione per un cieco? Sai che proposta
interessante... Il sopracciglio di mio padre tremò pericolosamente. Si stava arrabbiando, e
io - Quel ragazzo è cieco dalla nascita, figliolo – mi disse. - Questo non c'entra. -
Quello che voglio farti capire è che... con il tempo mi sono
affezionato
a lui. I Mudaliar sono sempre rimasti una famiglia di grandi musicisti,
e
Shaka, così come i suoi genitori, ha sempre coltivato la
passione per la
musica. Ora suo padre e sua madre sono passati a miglior vita, e
nonostante lui abbia vent'anni ha bisogno d'essere seguito. Lo capisci,
questo? Negai con il capo. Mi sentii idiota, perché quel gesto mi parve più un
brivido causato dal senso di colpa che un no vero e proprio. Sulle prime non
dissi nulla. La verità era che avevo paura. Solo quattro mesi prima avevo perso il mio
fratello maggiore Aiolos. Lui sì che era un grande. Era stato lui a comprarmi
tutti i poster del Bristol Rovers Football Club, era stato lui a regalarmi
tutti i dischi dei leggendari fratelli Young. E quel dannato incidente d'auto
se l'era portato via. Non avevo voglia di avere un nuovo fratello. La verità era questa. Scarna,
semplice, bastarda, ma sincera. - Papà - incominciai in tono magro, senza alzare gli occhi, - io... non ne
ho voglia. Lo sai. Stavolta fu lui a concedersi qualche attimo di silenzio. Poi mi sfilò la
cornice d'argento dalle mani, giocando d'astuzia su quel mio momento di
fiacchezza, e la mise da parte, sul mobile vicino al letto. La foto di Aiolos
ora mi sorrideva da lì. - Significa accettare gli eventi. Lui vorrebbe la tua felicità, figliolo;
non certo che spendessi la vita incollato ad una cornice d'argento -,
e abbozzò un sorriso che io evitai di incrociare. Solo colsi la sua grossa mano
spelacchiarmi i capelli biondi in un digiuno gesto d'affetto e la sponda del
letto distendersi quando lui si alzò. Uscì senza aggiungere alcun'altra parola
sulla questione. La differenza era che io in quel momento non avevo nemmeno voglia di aggiungere un pensiero. Mio padre andò a prenderlo alla stazione e io non andai con lui. Non avevo
voglia di uscire, ecco perché. Ma quanto mi amavo. I tentativi di ingannare l'ansia mi andarono a genio finché non sentii il
rullare secco delle ruote sulla ghiaia. Non era necessario correre alla
finestra per vedere, mi bastava la visione della Bmw nera che si arrestava sul
vialetto per destinare al rogo tutte quelle mie maschere di tranquillità.
Buttai sul mobile il libro di scienze e mi tuffai sul divano, agguantai il
telecomando, no anzi, che stavo facendo?, rovistai sotto al tavolino di vetro,
braccai un giornaletto qualunque, distesi i piedi sui cuscini, poco
appropriato, sul bracciolo, gettai un braccio lungo lo schienale, aprii la rivista. La sferzata delle pagine corrispose con lo zap! gelido della
chiave nella serratura. Angus Young aiutami tu. Più passi. Due persone. Forse una con tre gambe. (Aiolia ma dico?, sei impazzito? Da quando esiste gente con tre gambe?) Mi sentivo così idiota a dover accettare questi miei ragionamenti assurdi,
ma l'importante era tenere gli occhi fissi sulla rivista. Come gambe non erano
male. E poi accidenti, non ero mai stato un grande ammiratore delle donne coi
reggicalze, ma quelli lì rossi... abbinati alla mutandina color pesca... Ancora oggi non credo che la vecchiaia si porterà via la gran figura (di merda) che feci quel giorno. Ripresi il totale controllo delle mie capacità
deduttive solo quando buttai il giornaletto dietro al divano in un giostrare rabbioso
di pagine translucide. Non era necessaria una laurea per capire che mio padre
si era trattenuto dal mollare la mandibola in seguito a quel che s'era trovato
davanti: suo figlio minore, rettifico Aiolia "il Biondo" Iracà,
intento a spogliare con gli occhi le già seminude modelle di una rivista di
intimo femminile. In realtà era solo un inserto, ma in ogni caso restava sempre
il fatto che si trattava di un certo argomento. Avere vent'anni non autorizza a
certi comportamenti, non quando si è figli di un avvocato noto in mezza
Inghilterra. Non feci alcuno sforzo a sfoderare un sorrisetto da bravo ragazzo, dato che
quando serviva un alibi credibile ero un ottimo improvvisatore. Eppure,
nonostante mi sforzassi di non farci caso, avvertii la sgradevole sensazione
d'essere arrossito. Dio non me ne voglia, ma per una volta ringraziai il cielo che Shaka Mudaliar fosse cieco. Accadde questo il primo giorno che il biondino si presentò a casa mia. Era
lì sull'uscio del salotto, occhi chiusi, espressione serafica ed
imperturbabile, quel caldo pomeriggio d'agosto. Era lì e ci sarebbe rimasto per
tre mesi. Ancora ricordo i suoi abiti di flanella bianchi, i suoi lunghi
capelli d'oro, la sua immobilità. Mi sembrò uno di quegli adesivi
attacca-stacca che se ne stanno fermi per anni sulla stessa pagina. (Attacca-stacca Shaka Mudaliar! Sarà felice di visitare la carta
translucida del paesaggio-bosco! Che ne dici di staccarlo e spostarlo nel
paesaggio-spiaggia?) Questi pensieri mi fecero quasi ridere, ma mi trattenni e mi limitai a
quella mia espressione ebete cui ero ricorso per fronteggiare l'imbarazzo.
Conoscevo il biondino da forse due anni, da quando mio padre aveva incominciato
ad invitarlo a casa per pranzo. Questo perché così come file e file di ragazzi
si affollano nei cinema, noi Iracà ci affollavamo - "mi facevano
affollare", nel caso esista una forma passiva - nei teatri; e nei teatri
di Bristol molto spesso si organizzavano serate di musica classica. A onor di cronaca, Shaka Mudaliar era un pianista nato. Il fatto che fosse
cieco non gli aveva proibito di mettere la dita sui tasti e di lasciarli lì per
anni ed anni ancora. Odiavo ammetterlo, ma suonava da spaccare. So bene
che il termine è più affibbiabile a musica di ben altro tipo, ma allora,
invasato com'ero da AC/DC, Reverendo e compagnia bella, non potevo trovare
altri termini per esprimere quanto in realtà apprezzassi il suo stile. Ma
questo non l'avrei mai ammesso. Neanche buttato al rogo mi avrebbero sputato
quest'altra verità. Decisi di lasciare da parte i pensieri attacca-stacca quando mio
padre mi invitò con un cenno della mano ad avvicinarmi. Scivolai via dal
divano, quatto quatto, piccolo piccolo, e zampettai timidamente finché non mi
trovai di fronte a lui. E di fronte a quell'altro. Sapevo che non poteva
vedermi, ma per una ragione più profana del profano stesso la sensazione che mi
spiasse mi punzecchiava i nervi. Mi metteva quasi suggestione. - Shaka - incominciò mio padre, con quel suo bel tono d'avvocato d'altri
tempi, - presumo tu ti ricordi di mio figlio Aiolia, uhm? - . In tutta risposta lui accennò a un sorriso pallido e disse, in un tono che
faceva invidia alla parola dei pesci: - Certo che sì - . Mi sembrò già tanto che avesse detto quello. Per come lo conoscevo io,
avevo già messo in conto le frasi senza senso con cui ogni tanto farciva le
discussioni a tavola, sommando ad esse i "sì" e i "no" che
precedevano quasi sempre un silenzio di tomba. Dove c'era lui c'era imbarazzo.
Oh questo l'avevo capito bene. Decisi di tirare un nuovo sorrisetto che fosse
il più credibile possibile, e mio padre, che aspettava solo un mio cenno di
vita, sembrò appagato da questo mio sforzo. -
Perfetto ragazzo - buttò lì dopo quella breve e concisa
(ri)presentazione, - allora posso lasciare a te la valigia,
Aiolia? - S...sì - mi affrettai con cinque secondi di ritardo, pescando con lo
sguardo una valigia rossa appoggiata contro lo stipite. - A me, sì. Agguantai una delle cinghie del bagaglio e mi caricai tutto sulla spalla.
In un primo momento gioii della speranza di poter salire da solo le scale, di
mollare il fardello in qualche angolo della stanza degli ospiti e di scendere
in meno di due minuti pronto ad arraffare le scarpe di tennis ed uscire di
casa. Avrei scaricato a mio padre Shaka Mudaliar almeno fino a sera, che dico?,
notte fonda. E invece no. Quando mossi il primo passo verso il primo gradino, il biondino aveva già
colto il mio movimento e si era voltato per seguirmi. Perspicace. - Attento a non fare movimenti bruschi - lo sentii dire quando feci per
piantare il piede sulla scala, - ci sono dentro oggetti fragili. Non so cosa mi passò per la testa, ma approfittando del fatto che mio padre
era già in salotto ghiacciai Shaka Mudaliar con lo sguardo più truce che mai
avessi mai dedicato a qualcuno in vita mia. Si era appena trasferito nel mio regno (nostro, ormai) e già si permetteva di correggermi? Il leone più anziano si tiene il
proprio territorio, si sa; se poi ne arrivava uno giovane con
l'intenzione di soppiantarlo, il re avrebbe rivendicato il suo status di
sovrano. Mi fermai sul primo gradino con le dita aggrappate al corrimano come
se impugnassero l'elsa della spada che avrei voluto sfoderare e piantargli in
corpo. - Mudaliar - lo ammonii in tono misurato, - non so se andremo mai
d'accordo, e se hai intenzione di creare nuove leggi qui dentro, sappi che
questa tua proposta di governo non può esistere. I bagagli li ho sempre portati
io, per tutti gli ospiti che ha avuto mio padre, e non vedo perché dovrei farmi
cadere proprio il tuo. In tutta risposta ricevetti quel suo placido sorriso. La differenza fu che
stavolta colsi anche un velo di ironia sul suo viso, e ciò mi convinse che sì,
quel nuovo coinquilino mi avrebbe reso la vita ancor più difficile di quanto lo
fosse già. Non diedi retta al suo silenzio e ripresi a salire i gradini a
grandi balzi, con l'atteggiamento del leone che guizza sugli spuntoni di roccia
per dominare il territorio dall'alto. Il mio giovane ed inesperto avversario
politico sarebbe stato ancora in fondo, oh sì, incapace di muovere un solo
passo se non accompagnato. D'altronde era cieco, e i ciechi hanno un pessimo
rapporto con scale sconosciute. Shaka Mudaliar non era mai salito al primo
piano di casa mia. E invece il sorriso trionfante mi morì in faccia quando dalla vetta vidi il
nuovo coinquilino a metà del percorso. (Buttagli la valigia addosso, Aiolia, buttagliela addosso e vedrai che
rotolerà già, lui e i suoi dannati capelli biondi) Scartai quello sleale pensiero e lo aspettai in cima alle scale, mentre la
mia mente voleva percorrere il corridoio, buttare da qualche parte il bagaglio
e uscire di casa, tutto ancor prima che il biondino avesse varcato l'ultimo
gradino. Ma il mio corpo rimaneva lì. La conseguenza era la scomoda sensazione
d'essere stato plagiato persino nel modo di pensare. Stavo ancora combattendo
tra ragione astratta e ragione fisica quando Shaka mi raggiunse; o meglio,
tentò di farlo, perché in un battito di ciglia rischiò di scivolare quando
poggiò male il piede sul pianerottolo. Lo agguantai per il polso prima che potesse esibirsi nel triplo salto
mortale giù per le scale. Il tuffo sarebbe stato da record se non l'avessi
braccato in tempo. Dopo un momento di batticuore, tirò un sospiro e si issò
completamente vicino a me: - Grazie Iracà... Grazie. Risposi con una smorfia che voleva bensì essere un abbozzato "di
nulla", poi mi ricaricai il bagaglio sulla spalla. Fu in quel momento che
Shaka Mudaliar mi prese a braccetto infilando il braccio attorno al mio con
un'astuzia forse ereditata dai vent'anni da cieco, e mi sorrise candido quando
avvertì il mio brivido contrario a quest'iniziativa. - Se ti dà fastidio, dimmelo - mormorò in tono innocuo. E io, tenendo per me un gorgoglio infastidito, scossi il capo dicendo: -
No, tranquillo. Hai fatto bene. In fondo al cuore nutrivo però l'insano pensiero che l'avessi salvato dalla caduta solo per non fargli vincere l'oro nelle Olimpiadi di Caduta Libera dalle Scale. Io non avevo mai vinto una medaglia d'oro, e lui non poteva permettersi in nessun modo di superarmi. Neanche in una gara di tuffo acrobatico. Finalmente buttai la valigia sul letto della camera per gli ospiti. In
quell'attimo mi resi conto di quanto i miei piani di abbandono nei confronti di
Mudaliar fossero insensati. Non seppi descrivere il sentimento che mi convinse
a restare a casa con lui quel pomeriggio, ma più avanti, in un futuro non
troppo lontano, l'avrei definito affetto, quella razza di affetto quasi
obbligato che si prova per chi è destinato a vivere con te. In ogni caso
accantonai nella mente le scarpe da tennis e tutto il resto e rimasi lì con lui. Per prima cosa disfammo il bagaglio. Shaka si era seduto sul letto e mi
guardava (Aiolia, ma allora sei proprio scemo. I ciechi non vedono!) ...sì, mi guardava senza muovere un muscolo. Sulle sue labbra color pesca
si era allungato un sorriso deliziato. Era sereno ed io ero sereno per la sua
serenità. - Scusa se metto le mani tra le tue cose, ma... - Tranquillo, Iracà. Grazie infinite, invece. Gli scoccai un'occhiata e ripresi a frugare fra i suoi vestiti. Divisi i
pantaloni dalle maglie e da tutto il resto disponendo gli abiti sul letto come
se avessi indetto a casa mia un mercato dell'usato. A dire il vero non aveva
con sé molto. - Papà mi ha detto che puoi usare i miei vestiti, per il momento - mi
affrettai, punto da questo ricordo, - e che tra qualche giorno, o non so, tra
un po' andremo a fare compere per trovarti qualcosa di più appropriato. Tanto
abbiamo la stessa taglia, anche se sono un poco più robusto non fa niente. - Fa niente, hai ragione - mi rispose. Si alzò e piano piano, misurando i
passi, riuscì a raggiungere il balcone. Per un attimo ebbi il timore che
volesse ritentare il record di Caduta Libera, ma quando vidi che afferrava il
cornicione e si limitava a crogiolarsi al sole, il mio animo tirò un sospiro di
sollievo. Lo spiai ancora qualche secondo, poi ripresi con il mio lavoro. Ed eccolo, che spuntava da sotto un guazzabuglio di camicie di flanella. Un
foulard verde raggomitolato in un angolo, timido nella bianca luce d'estate,
che se ne stava a fissarmi dal suo nero nascondiglio. Lo acciuffai senza tante
grazie e me lo distesi davanti agli occhi. La morbida brezza di Bristol lo
abbracciava in sinuosi movimenti. - Mudaliar - dissi, e lui si voltò verso di me, avvertendo nel mio tono una
nota di dubbio, - e questo dove lo metto? - "Questo" sarebbe...? - Un foulard. Un foulard di seta verde. Dove vuoi che te lo metta? - Non è mio. Aggrottai le sopracciglia. - Ma era nel tuo bagaglio. - Sì, ma non è mio. Non so come ci è finito dentro - E detto questo si
rivolse ancora all'afa d'Inghilterra, lasciando che le dita della bella
stagione gli pettinassero i capelli. Io rimasi dietro di lui come un ebete. Il
foulard si dimenava come un infante capriccioso e io non sapevo dove accidenti
piazzarlo. Buttarlo nell'armadio sarebbe stato volgare, schiacciarlo
nell'angolo di qualche cassetto ancora peggio. Era seta, e la seta va trattata
con un certo riguardo. - Tienilo tu - disse d'un tratto Shaka Mudaliar, senza voltarsi. - Tienilo
pure. Sentivo che stava sorridendo. Nel suo tono colsi quasi una vena di
cordialità. Decisi di non dir nulla e mi legai il fazzoletto attorno al collo.
Non penso siano mai esistiti cowboys con foulard verdi, ma poco mi importava:
sbirciando la mia immagine riflessa allo specchio vidi che non stavo nemmeno
tanto male. Mi donava. - Be', grazie - mi scappò dalle labbra, e rituffai le mani nel bagaglio per
ignorare il formicolio alle dita. L'imbarazzo d'aver ringraziato il giovane
leone che minacciava il mio terriotorio mi costò anche un molesto calore al
volto. Lui non poteva vederlo, di questo ero certo. Forse lo avvertì nel silenzio
che seguì. Ma preferivo non dare una risposta a questo mio dubbio. Così Shaka Mudaliar e quel foulard verde entrarono nella mia vita.
Nel salotto di casa Iracà... *Sorseggia tranquillamente del thè inglese* Very good u.ù Ecco a voi il primo capitolo di questo mio tentativo di trama. Spero d'aver aperto questo mio secondo sbarco su EFP attirando la vostra attenzione ** Come detto prima, è una storia che ho ripescato dai meandri della memoria. Mi piace l'idea che alcuni (mwahahah forse non solo due u.u") dei nostri amati Saints vengano inseriti in ambienti nuovi ed attuali, come mi piace sperimentare ambientazioni e comportamenti OOC. Spero che quest'idea piaccia anche a voi ** Il nostro Aiolia sopporterà il nuovo coinquilino? (checcari chessono ** *sbava sbava*) Vi lascio con questo interrogativo e con il primo capitolo ^^ Aggiornerò in settimana gente ** A presto °° Dew_ 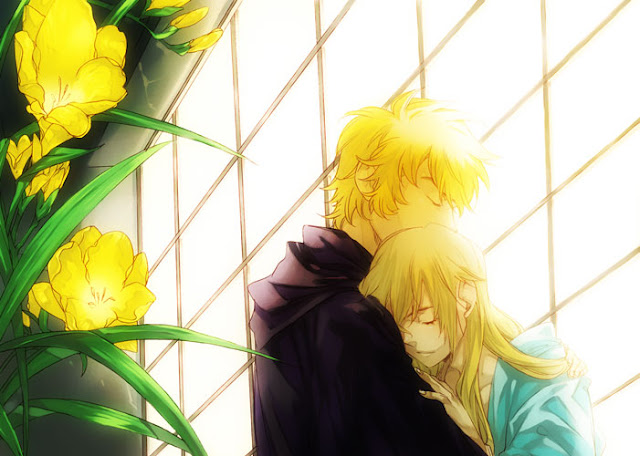 |
Capitolo 2
*** Parte seconda - De Naribus ***
|
Parte seconda - De naribus
Un grosso labrador
color panna schizzò fuori dal salotto con la lingua all'aria e
una frusta al posto della coda. Subito, con un singulto strozzato dalla
sorpresa, mi aggrappai al corrimano e guizzai indietro, di nuovo sui
gradini, crocifiggendo con quel gesto l'ormai remoto torpore del sonno.
Rimasi lì, avvinghiato al legno di quercia come un gatto
in cima ad un albero da cui non riesce più a scendere.
Quell'essere dal fiato asprigno aprì le mastodontiche mascelle e
abbaiò; poi eccolo a raccogliere le zampe posteriori e zompare
verso di me con la grinta di un glizzy in calore.
Mi ribaltai sotto quel peso non certo prevedibile e ruzzolai sulla schiena, le dita ancora artigliate allo scorrimano in un comico tentativo di ancoraggio. Il bel cucciolotto mi era sopra dopo aver scavalcato sgraziatamente le mie ginocchia. Quello che mi investì fu un odore insopportabilmente ingombrante. Il labrador, ignorando il mio grugnito di disapprovazione, cominciò a schiacciarmi il naso umido sotto al mento. E poi la lingua. Un'orrenda, viscida striscia rosa che mi si spalmò platealmente in faccia. - Per piacere, che schifo...! Afferrai il gradino dietro di me e mi spinsi via passandomi incessantemente il braccio libero sulla guancia. Il cagnaccio fece per arrampicarmisi di nuovo sopra, ma un guaito offeso mi annunciò che qualcun altro lo stavo trascinando via dal mio corpo. - Lia, a te proprio i cani non vanno a genio, eh? Mi issai in piedi finendo di asciugarmi con la manica della camicia e da sotto la chioma sconvolta che avevo per capelli riconobbi una persona per niente sconosciuta. Conoscevo Shura Delgado solo per gentile concessione di Aiolos. Gentile concessione perché erano così amici che di rado li si poteva disturbare, quando si chiudevano in camera a farsi gli affari loro. Ma da quando mio fratello era passato a miglior vita, quel damerino spagnolo non si era più presentato a casa Iracà. Non a caso appena riconobbi lui nel mio salvatore, lo guardai come si guardarebbe un fantasma uscito dalla tintoria: - Delgado? - chiesi. Mi sentii stupido quando lui, che aveva braccato il labrador per il collare, scoppiò a ridere. - La regina Elisabetta. Chi altrimenti, scusa? - Che ci fai qui? - Lui - rispose Shura, e premette una mano sulla nuca del cane ottenendo in risposta uno zuccheroso mugolio. - Una settimana fa è arrivato qui Mudaliar, vero? - . - Sì, e con questo? Continuavo a non capire. La mia mattinata era stata stravolta dalla lingua umidiccia del cane e i miei sensi ancora si rifiutavano di riprendersi. Che sacrosanto schifo. - Diego è un cane guida - mi illuminò il moro. - Diego, saluta! -, e il labrador abbaiò un solo, profondo colpo di gola. Il mio istinto mi suggerì di ficcarmi del cotone nelle orecchie o di scoppiare in una crisi isterica e buttar fuori di casa il damerino e quel suo brutto cagnaccio. Scesi completamente dall'ultimo gradino senza lasciare il corrimano: - Come scusa? - Iracà, ma sei sempre così duro di comprendonio la mattina? Tuo padre ha telefonato ieri al campo di addestramento per cani gestito dalla mia famiglia e ha chiesto un cane guida. Non pensavo tu fossi così scemo. Stentavo a crederci. Io, condividere l'esistenza terrena non solo con un cieco dalla perpetua immobilità, ma anche con un labrador obeso? I miei occhi scapparono sulla lingua penzolante di Diego e l'animale, colta la mia espressione inebetita, ricorse a quello che mi parve un sorrisone da amico. Che incubo. Oh Queen Elizabeth, che incubo. Lasciai da parte le uova strapazzate e il mio animo ancora sconvolto mi permise di mangiare solo una fetta di pane appena sporcata con della marmellata. Per la prima volta in vita mia maledii la celeberrima English Breakfast chiedendomi come avessi fatto, per tutti quegli anni, a mangiarmi il pranzo del Ringraziamento ogni mattina. L'unica cosa che non risparmiai fu il thè, con l'aggiunta di un goccio di latte come piaceva a me. Quei primi minuti di giornata erano bastati ad assassinare nel mio vocabolario il verbo "mangiare". Rimpinzarmi di uova e bacon e fagioli al sugo e solo Dio sa quant'altro non rientrava certo nei miei desideri, non nel momento che stavo passando. O meglio, che avevo passato: un'affettuosa ed appiccicosa linguata in faccia e un tremendo colpo alla schiena, che ancora mi doleva nella zona lombare. Nemmeno un allenamento di quattro ore di cricket avrebbe saputo indolenzirmi a tal punto. Diego si piazzò ai miei piedi e rimase a guardarmi fisso reclamando un po' di attenzione dal basso. Quando facevo per incrociare distrattamente il suo sguardo, si passava l'enorme lingua sul muso e rimaneva altri secondi a fiatare prima di abbaiare sommessamente, con il finale risultato che gli regalai l'intera portata di uova strapazzate non appena mio padre lasciò il tavolo. Quel cane mi sarebbe stato necessario come spazzatura comune. Almeno una sua utile finalità poteva averla. Nel momento in cui fui io ad alzarmi, però, Shura Delgado mi lanciò un guinzaglio rosso: - Fa' come se fosse il libretto di circolazione dell'auto nuova - mi disse con un sorrisone da bravo ragazzo. E poi, facendo un cenno verso la cucina: - Io vado a parlare con tuo padre. Si allontanò mentre io fissavo intontito il guinzaglio che avevo agguantato prima che mi finisse in faccia. Diego si animò tutto d'un tratto e cominciò a frustare l'aria con la coda, srotolando quel tappeto d'ingresso trionfale che aveva per lingua, e Shaka Mudaliar, ancora seduto con la tazza di thé fra le mani, mi illuminò: - Intende, andare a fare una passeggiata. - Sì ma il cane dovrebbe essere tuo, Mudaliar, non mio. - Comincia a legarlo al guinzaglio. Scossi il capo e tenni per me un mugolio irritato, poi mi chinai e feci come mi era stato detto. Il labrador si era dedicato a una super produzione di bava causa "eccitamento da prestazione", e le sue zampe muscolose cercarono più volte di saltarmi addosso nel goffo tentativo di un abbraccio, gesto che io mi impegnai assiduamente a respingere. Quando riuscii nell'impresa, porsi il guinzaglio al biondino. - Dammi il tempo di cambiarmi e sono da te. Shaka abbozzò un sorriso e accettò di buon grado l'affidamente del cane. Così io fui libero di chiudermi in camera per una mezz'ora abbondante ed uscirne solo quand'ebbi indosso una camicia bianca e dei jeans sottratti ai selvaggi meandri del guardaroba. L'unico guaio era che il parco più vicino a casa distava un quarto d'ora di macchina; e che poiché non osavo toccare un volante dai tempi dell'incidente di mio fratello, eravamo costretti ad andare a piedi. A voi i conti. Certo mi è sempre piaciuto camminare, ma l'idea di doverlo fare in compagnia di un cieco e di un cane obeso - perché obeso, credetemi, lo era sul serio - non mi andava molto a genio. Chiesi soccorso alla provvista di pazienza che immagazzinavo da anni, presi un profondo respiro e oplà!, eccomi sulle strade di Bristol con il mio coinquilino di origini indiane e un bulldozer color panna al guinzaglio. Destinazione, city park. Tempo stimato per l'andata, mezz'ora se non peggio. Tempo stimato per il ritorno, lo stesso. Tempo stimato prima del primo sbuffo? Incancolabile. Appena fuori dalla porta, mentre passavo il guinzaglio a Shaka Mudaliar, le mie labbra si erano già arricciate in un sospiro sconsolato. - Non ti piace passeggiare, Iracà? Guardai il biondino con la coda dell'occhio, camminando al suo fianco sul marciapiede miracolosamente sgombro del quartiere. - Mi innervosisce la presenza del cane, tutto qui. - Allora non ti piacciono i cani? - Sempre odiati. - E perché? - Puzzano. E leccano. - Non se li si educa - fu la serafica risposta (e intanto Diego incalzava a velocizzare il passo trottandomi ogni tanto tra le gambe). - Questo labrador è un'ottima guida, è questo quello che conta. - E un ottimo scarica-uova-strapazzate - finii io per lui, e mi parve d'indovinare un tiepido sorriso sulle labbra. Quasi mi fece piacere. Timidamente stavo forando la barriera fra di noi per sbirciare quello sconosciuto che stava dall'altra parte. Shaka Mudaliar si rassettò un ciuffo dietro l'orecchio e fece silenzio. Se ne stette muto per altre due streets fino a che non ci ritrovammo sulla Christmas Steps. Ad intermittenza, tra il vociare e lo sfilare e lo snodarsi di gruppi di turisti, si intravedevano le botteghe e gli antiquari della stradicciola, la quale altro non era se non una rustica scalinata che si snodava tra basse palazzine. Più che un passaggio obbligato, quella via era per noi una scorciatoia che ci avrebbe fatto guadagnare qualche minuto. Diego scodinzolava eccitato e avanzava fiero nel goffo ballonzolare delle mascelle, tirando prima di qua e poi di là a caccia di nuovi odori. Dal canto mio, pregai perché Shaka Mudaliar non aprisse bocca, perché già solo il comportamento esaltato del cane mi dava sui nervi. E invece, squillo di trombe, aprì bocca. - Iracà - mi chiamò tutto d'un tratto, strappandomi dalle mie mere speranze. - Uhm? - Delgado è uno di famiglia? - Se per "uno di famiglia" intendi "amico della casa", allora sì. - Era molto legato a tuo fratello, vero? (Ti prego di startene zitto, brutto ind...) - Sì - mi limitai a rispondere, apparentemente tranquillo, ma un fremito tradì la mia maschera. - Sì - aggiunsi per non perdere le redini della ragione, - erano molto amici. Delgado era in macchina con lui quando... quando accadde, sì. - Ma lui non si fece nulla. - E' così. - Eppure si è ripreso dall'incidente, mi pare. - Che intendi? Shaka Mudaliar si annodò il guinzaglio al polso per limitare le avanscoperte di Diego, poi mi dedicò un sorriso pescato al momento che pur ebbe il terrificante potere di addolcirmi. - Lui sorride - disse solamente. - Sì, spesso Mudaliar. Non capivo cosa intendesse; come non mi rendevo conto di camminare senza guardare dove andavo, perché fissavo il mio compagno di scampagnata con la bocca appena schiusa in un'espressione intraducibile. - Spesso - ripetei. - Mi pareva. - Ma, scusami la domanda... come fai a vedere se sorride o meno se sei...? - ...cieco? - finì per me forse cogliendo il brivido che mi passò per le corde vocali. - Semplice, lo avverto. E non parlo dell'udito, parlo di questo -, e si toccò la punta del naso facendo mostra di un bel sorriso di sole. - Si respira serenità, quando lo sento parlare. - Sì, vero anche questo. Silenzio. E poi Shaka: - Dovresti seguire il suo esempio. - Co...come? - mi scappò in un gorgoglio meccanico, ma quella che voleva essere una "e" finale venne strozzata da un gridolino involontario quando incespicai nel guinzaglio capitombolando all'indietro. E due. Seconda caduta della giornata. Aiolia il Biondo Iracà, hai vinto la medaglia d'oro! Mi sembrò incredibile sentire la risata di Shaka Mudaliar. Più che di imbarazzo per essere caduto proprio sotto agli occhi di un sacco di persone, la sensazione che mi gonfiò il cuore fu di divertimento e di serenità. Mentre mi rimettevo in piedi, con Diego a vorticarmi buffamente attorno alle gambe, non potei trattenere un sorrisetto. - Sì, forse - risposi dandomi una scrollata alla camicia, e ripresi a camminare ponendo in secondo piano il fatto d'essere inciampato, proprio come un cieco cronico, nella mia stessa testardaggine. Non fu troppo complicato trovare un angolo isolato di verde. Davanti a noi, o meglio, sotto di noi, dal momento che ci trovavamo sul dorso di una morbida collina, si snodavano i bianchi viali del parco, fiancheggiati da panchine maniacalmente verniciate di smeraldo. I pochi ma formosi alberi sfioravano il cielo e le loro braccia, che dondolavano alla brezza estiva, parevano spolverare l'etere dagli insistenti indizi di nubi. Si respirava un'atmosfera fresca, appagante, vitale. Le bricconerie del vento ci soffiavano addosso i soffici profumi dell'estate inglese. Solo sulla linea dell'orizzonte, là dove le fronde erano più folte, si affacciavano i tetti spioventi di quell'angolo verde di Bristol. Shaka Mudaliar lasciò a Diego la libertà di procedere con le proprie avanscoperte e il labrador, salvo quegli sprazzi di momento in cui ci trottava attorno, si dilettava a rincorrere farfalle immaginarie e ad annusare gli altri cagnolini. Io e il mio compagno di scampagnata invece preferimmo sederci su quell'abbozzato dorso di collina a guardare il cielo. Ascoltare il paesaggio imperlato da fischi di merli non fu mai più così gradevole. - Shaka, mi dispiace proprio che tu non possa vedere quel che abbiamo attorno. Veramente un bel posto. - Non deve dispiacerti, non è colpa tua. E poi... - ...e poi? - ...e poi io vedo. Il pensiero di consegnargli il primo premio per la gara di Frasi-Senza-Senso fu immediato, ma lo tenni per me e mi limitai a rivolgergli uno sguardo appena spaesato: - Vedi con gli altri sensi, immagino. - Cominciamo a capirci. L'aria, questa mattina, è così limpida... eppure sento odore di pioggia, chissà perché. - Con un retrogusto di città, anche. Pochi minuti al parco mi erano bastati per scovare, in quella visione di Paradiso, un indizio della vita frenetica che si svolgeva dietro gli alberi. Sentivo sulla pelle i clacson delle macchine e la morsa soffocante del centro di Bristol, persino in quell'idilliaco quadro macchiato di verde. Shaka Mudaliar mi sorrise appena e si sdraiò, intrecciandosi le dita dietro la nuca. - Solo una tua sensazione, Iracà - disse. - Le tue narici sono state plagiate dalla tua capacità di vedere. Avevo perso interesse per il cielo. Ora la mia attenzione era totalmente dedicata a quello pseudo Messia che avevo di fianco. - Sì... può darsi - mi limitai a rispondere, arricciando appena le labbra in un'espressione di disagio. - Può darsi - ripetei subito dopo. - Prima goccia. - Scusa? - Lassù -, e alzò il braccio ad indicare un punto imprecisato della volta celeste. - Guarda bene. - Guardare cosa? - Seconda goccia. Terza, e quarta... - Piove solo sopra di te, mio caro Mudaliar. Mi venne da ridere; e con il riso mi piovve addosso anche un catino di pioggia. Così, tutto d'un tratto. (Gli improvvisi diluvi a Bristol... Oh quanto li adoravo) Branchi di turisti, famiglie a passeggio, in uno scrosciare di vocio allarmato, tutti insomma filarono via con l'atteggiamento di Partigiani in fuga. Solo io e Shaka, immobili nel fradicio del cielo, rimanemmo sulla collina come statue. Diego trottò da noi grondante d'acqua e piantò le zampe lorde sul petto del mio compagno di scampagnata, sdraiandosi gaiamente come in vista di un invitante massaggio giapponese. E io, con gli occhi intenti ad annaspare sotto i capelli spiaccicatimisi in testa: - Sei un veggente? - No, solo capisco l'umore della natura. - In anticipo, pure. E dimmi, Pseudo Messia, come si torna a casa, adesso? Non mi sono portato dietro un ombrello. Lui sorrise; proprio lui, fermo sotto il diluvio, gli abiti inzuppati e incollati al corpo, ancora comodamente sdraiato sul prato, sorrise. In quel momento capii che forse mai avrei compreso fino in fondo quei suoi sintomi di pazzia. - A piedi, Iracà - fu la semplice risposta. Mi sdraiai a mia volta. La mattina si era improvvisamente annebbiata e la brezza, prima fresca, si era fatta più tagliente, così come le schegge di pioggia. Buttai un'occhiata a Diego, che fiatava rumorosamente e tirava sbuffi fradici dalle grosse narici. - L'odore dei cani bagnati è osceno - dissi senza guardarlo. Però Shaka, rispondendomi, guardò me: - E' quello che direbbe Diego sugli uomini se potesse parlare. Fortunatamente quando rientrammo mio padre era fuori per lavoro. Lasciai il labrador in giardino e una volta dentro mi cambiai da capo a piedi. Gocciolavo ovunque e il mio odore era quello asprigno della pioggia. Fu quando mi ero già fiondato in doccia che sentii il pianoforte suonare. Quello strumento era di mia madre e mai avrei voluto che Shaka Mudaliar ci mettesse mano. Ma lo lasciai fare quando avvertii, oltre lo sciacquio dall'acqua con cui mi lavavo, che fuori aveva smesso di piovere quasi come se la Turkish March di Mozart avesse ordinato al cielo di smettere. Mi misi addosso i primi abiti che mi capitarono a tiro, strofinai un poco i capelli e piroettai giù al piano terra affacciandomi all'uscio del salotto. Non era la prima volta che vedevo Shaka Mudaliar suonare il pianoforte, ma chissà perché in quel momento la sua musica ebbe un senso alle mie orecchie. Forse perché lo conoscevo meglio, forse perché incominciavo a capire, dopo quei suoi tanti discorsi da Messia, che cosa significasse essere ciechi e poter sbrogliare "l'umore della natura" con gli altri sensi. Non volli disturbarlo. Sulle note della Sonata di Beethoven squillò il telefono. Mi esibii nel mastodontico sforzo di allungare il braccio ed agguantare la cornetta, mentre mi tiravo meglio a sedere sulla poltroncina in cui ero sprofondato. - Casa Iracà, qui Aiolia. Come posso esserle utile? Dall'altra parte, una risata. - Figliolo, adesso rispondi sempre così al telefono? Mi scappò un sorriso: - Così come mi hai insegnato tu, papà. Dimmi. - Ti ho lasciato un promemoria giallo nel portalettere di fianco all'ingresso. - Non ci ho fatto caso. - Leggilo. Tornerò a casa per cena. Riattaccò. Il tempo di adagiare la cornetta e nell'aria già si rincorrevano le note di Kiss the Rain di Yiruma. Qualcosa di meno datato, finalmente. Mi trascinai fino all'ingresso e braccai il bigliettino colorato. Ricordo che quando lessi e capii, decisi che Shaka Mudaliar avrebbe potuto suonare quel pianoforte quanto avrebbe voluto. Nemmeno mentalmente l'avrei più ammonito come avevo fatto prima sotto la doccia. Ancora qualche mese. Due o tre. Stracciai il promemoria e alzai gli occhi alla finestra. Avvertivo lo sgradevole bruciore delle lacrime. Fuori la rugiada della pioggia cominciava a distendersi alla carezzevole melodia del pianoforte. Nel salotto di casa Iracà...
Dopo aver spedito fuori casa Diego - lo ammetto, i cani mi piacciono, ma i cani obesi non tanto U_U -, eccomi qui per ringraziare i recensori del capitolo precedente ^^ Risponderò sempre in forma privata ^^ Spero che la storia continui a piacervi e che vi abbia incuriosito, l'importante è che io non abbia scritto strafalcioni o chissà che -lol- Non ho intenzione di dirvi cosa c'è scritto sul promemoria di Mr. Iracà, anche perché si svelerà nel capitolo successivo. Ho deciso di optare per capitoli abbastanza lunghi, dato che saranno cinque o sei in tutto, e tra l'altro il nome "parte" mi fa pensare a un qualcosa di più esteso. Spero di non avervi annoiato. E per chi non studiasse latino - rettifico, per chi si è salvato la pelle da un suicidio XD-, il titolo "de naribus" può essere liberamente tradotto con "l'olfatto". Alla prossima, ci vediamo settimana prossima ^^ Dew_ |
Capitolo 3
*** Parte terza - De Auribus ***
|
Parte terza - De auribus
Dopo
altre settimane avvertii dentro di me un incomodo pensiero: che forse
stessi inconsciamente cercando di non affezionarmi a Shaka Mudaliar?
Rettifico, affezionarmi troppo,
perché il primo sentimento d'affetto per quel ragazzo lo avevo
avuto la prima volta in cui lo vidi lì, fermo sulla soglia del
salotto. Certo il mio orgoglio di leone dominante aveva soppresso
questa realizzazione senza tanti ripensamenti, ma più passavano
i giorni e più mi rendevo conto che sotto la mia criniera
s'intravedevano le piccole ed aggraziate orecchie di un gattino.
Per spiegarmi meglio, mi stavo addolcendo. La mia asprezza nei modi di fare si ridusse alle occhiatacce che gli lanciavo ogni tanto, e mi sorpresi non poco quando mi resi conto che non ero nemmeno più in grado di sculacciare Diego come si deve. Aveva sbranato la crostata di fragole preparata con tanto impegno dalle mie mani e il massimo che avevo fatto era stato sbatterlo fuori di casa. Ma non urlaii, né inveii come facevo una volta. Sentivo la strana necessità di non otturarmi i timpani con inutili imprecazioni d'ammonimento. D'altro canto l'atmosfera casalinga era sempre allietata dalle note che Shaka Mudaliar faceva magicamente sbocciare dal pianoforte. Forse era anche per questo che non avevo quasi mai voglia di urlare. Di recente però inciampava in qualche tasto di troppo, in improvvisi guizzi incondizionati, anche se poi riprendeva a suonare come se nulla fosse successo. Come se non se ne accorgesse nemmeno. No che non te ne volevi accorgere, vero? Non volevo che spostasse l'attenzione su ciò che pensavo, proprio perché mentre passavo in salotto e lui sbagliava una nota, avevo sempre paura che lui incrociasse il mio sguardo carico d'incuriosito disagio. Qualche tempo dopo che ebbi letto sul bigliettino giallo, alle ore quattro del pomeriggio mi infilavo le mie scarpe da tennis, arraffavo una giacca qualunque, mi legavo il foulard al collo e scendevo al trotto le scale. L'intenzione di eludere l'interesse di Shaka fallì miseramente. - Aiolia? Mi chiamò dal salotto. Fui costretto a lasciare la maniglia maledendo con un sospiro il mio passo da rinoceronte (come un elefante in gioielleria, sai?) e mi affacciai alla stanza adiacente: - Uhm? - Dove vai? - Porto a spasso Diego. Ma preferisco che tu stia a casa, hai ancora un po' di febbre o sbaglio? Che aveva la febbre era vero: non troppo alta ma nemmeno così bassa da passare per un semplice capriccio della temperatura. Quello che era falso era ciò che riguardava il cane e, novità delle novità, Shaka non tardò a capirlo. - Aiolia, ti faccio notare che il guinzaglio è ancora sul mobile.... - Devo ancora prenderlo, infatti. - ...e tu stavi già per uscire. Mi venne voglia di strozzarlo. D'affetto, s'intende. Mi scappò un sorriso al solo pensiero che lui si preoccupasse così tanto di me da non permettermi nemmeno di mentire. - Vado a fare un giro - mi corressi in tono trasparente. - Tranquillo che non scappo di casa, Sha. Finalmente si degnò di alzare il capo dalla tazza di thé con cui si stava scaldando le mani e mi lanciò un sorrisetto. - Non stare in giro fino a tardi - mi disse facendo ricorso a quella sua voce candida. - No, promesso. - Promesso promesso? Un brivido mi solleticò le corde vocali quando feci per rispondere: "sì", e infatti quello che ne conseguì fu una sorta di singulto di sorpresa. Solo Aiolos usava ripetermi la domanda in quel modo. Fu come la luce di un lampo. Seduto alla poltrona di fronte alla finestra, al suo posto, con la luce bianca del sole a sciogliersi attorno ai suoi lineamenti, vidi mio fratello. La mia mano, complice una reazione istintiva, si strinse ancor più allo stipite. Credo che Shaka abbia udito lo scricchiolio del legno, o qualcosa del genere, perché con un cenno della mano mi invitò ad avvicinarmi. Come un automa scivolai a sedermi sul bracciolo, in attesa di una sua parola. E infatti: - Lo hai? - Chi...? Cosa? Shaka mise da parte la tazza e si voltò verso di me. Un fremito, uno solo, seguito da una bollente cascata di scariche elettriche, mi scosse la pelle quando sentii le sue mani sul mio petto. Avvertivo il candore e la purezza di quelle dita raffinate che cominciavano a tastarmi meticolosamente prima il braccio, poi la spalla, infine fermarsi al collo, dove incontrarono il tessuto del foulard. Scorsi un sorriso sulle sue labbra. - Sì, lo hai - concluse soddisfatto. - Lo porto sempre con me, Sha, di cosa ti preoccupi? - E' stato tanto tempo in quell'angolo della mia valigia, non vorrei ci tornasse. Non così presto. - Non lo metterò via. - Mi prometti anche questo? Mi sfuggì una risata. Le sue mani, ancora ferme all'altezza del pomo d'Adamo, fremettero con la mia serenità. - Sha, non posso prometterti che tornerò presto, una volta uscito. - Allora non vuoi dirmi dove vai? - Non è che non voglio. Non posso. - Va bene - finì lui, e ritirò le braccia. Non so cosa mi passò per la testa, ma mi dispiacette. In quel momento avrei solo voluto abbracciarlo, sentire ancora le sue dita ad ascoltare il mio respiro. Mi sentii uno stupido e mi sembrò persino di arrossire, così mi alzai dal bracciolo con l'intenzione di uscire di scena, via da quel siparietto troppo inconsuento per me. Ma invece mi chinai appena e gli posai un bacio sulla guancia, tirandomi indietro quasi subito per non rischiare (rischiare) di farmi incatenare dallo splendido profumo della sua pelle. Lui mi sorrise di nuovo e mi sembrò il sorriso di un angelo. Controllai un'ultima volta lo strappo di giornale che avevo sottratto senza pietà ad una delle tante riviste di casa. Hartfiel Avenue, 12. L'indirizzo era quello giusto. Mi ficcai il biglietto in tasca e alzai gli occhi sull'edificio che avevo di fronte. Chiamarlo edificio era forse un po' troppo, dato che i quattro muri lì davanti erano lo scheletro di una piccola villetta immersa nel verde poco lontana dal centrocittà. Le pareti erano candide e su di esse si intervallavano assi di legno dal gusto deliziosamente rustico. Davanti all'ingresso posto sotto un porticato, un aggraziato vialetto si snodava tra le aiuole fino al cancello in ferro battuto, che dava direttamente sulla strada da cui io me ne stavo fermo ad osservare. Con sorpresa appurai che il cancelletto non era chiuso e così zompai senza intralci di fronte alla porta. Lanciai un'occhiata alla finestra mentre premevo l'indice sul campanello. Aspettai poco, forse trenta secondi, prima che qualcuno venisse ad aprirmi. Mi trovai faccia a faccia con un ragazzo della mia stessa età. Dovetti restarmene per un bel po' ad osservarlo, preso alla sprovvista da quel suo fascino magnetico, perché ebbi la sgradevole sensazione di una vampata di fuoco sulle guance. Non era da me arrossire, per di più davanti agli uomini, e allora perché da quando Mudaliar viveva con me lo facevo così spesso? - Cerca qualcuno? - mi domandò lo sconosciuto in tono distante ma cordiale. - S...sì - mi scossi io, e dovetti sbirciare sullo strappo di giornale per ricordarmi il nome di chi cercavo: - Cerco un certo... Monsieur Giraud, insegnante di musica. La mia pronuncia francese non era delle migliori, plagiato com'ero dall'accento inglese, ma il ragazzo di fronte capì lo stesso: - Lo ha davanti. Camus Giraud, plaisir moi [1] -, e mi tese la mano. Accettai la stretta e pescai uno dei sorrisi migliori del repertorio. - Mi scusi, ma non sono abituato ad usare il "lei" con i miei coetanei... pe-perché lei è un mio coetaneo, no? Il sopracciglio di Camus Giraud vibrò deliziosamente. - Non penso sia venuto a casa mia per domandare circa la mia età, vero signor...? - Iracà - mi affrettai, come punto da un pizzico d'imbarazzo. - Aiolia Iracà. - Figlio di Georgos Iracà? Quell'Iracà? - Se intende l'avvocato, sì, quello. Mi piaceva essere riconosciuto ovunque andassi. Quello che spesso seguiva a questa mia fiera risposta era un "oooh" di sorpresa, e invece il francese non fece nulla di tutto ciò; anzi: - Ho sentito dire che ora ospitate Mudaliar, il pianista dell'Hippodrome [2]. - Vero. - Vuole imparare a suonare anche lei, signor Iracà? - ...più o meno. Camus Giraud si concesse una pausa di riflessione, poi, contro ogni mia aspettativa (adesso ti dirà che non gli sembri adatto, già dalla risposta ci crede ben poco) si scostò dall'usciò scoccandomi un sorriso di benvenuto. - Si accomodi pure. Ne parleremo con tranquillità davanti ad una tazza di thè. L'interno della villetta era ancor più incantevole. Il padrone di casa mi fece accomodare in salotto prima di allontanarsi in cucina, così io potei dedicarmi all'analisi di quell'angolo di Paradiso terrestre. Gli unici colori che dominavano erano il bianco ed il blu, che si davano il cambio tra tappeti, cuscini, divani e quant'altro in uno squisito gioco di ricercatezza. L'aria che si respirava era fresca, frizzante, trasparente come il cristallino mar di Francia, e le tende, che scivolavano in morbidi drappeggi sulle mensole in legno, schermavano con delicatezza la bianca luce estiva. Aspettai poco e in breve Camus Giraud fu di nuovo di fronte a me, seduto alla poltrona, tazza fra le mani, pronto a sostenere una discussione fra gentiluomini. Ora che me lo trovavo ancora davanti e mi ero ripreso dallo shock iniziale, mi venne più facile studiare anche lui. Era incredibile quanto la sua fragile e beneducata presenza si armonizzasse con ciò che era attorno, e allora capii che l'ordine dell'atmosfera non era altro che lo specchio della sua personalità. Il suo abbigliamento era pulito, semplice, i pantaloni di flanella bianca così perfetti sui suoi lineamenti. Aveva i lunghi capelli rossi legati in una coda di cavallo lasciata volutamente morbida, e il fiocco con cui teneva unite tutte le ciocche era un intricato inno floreale. Dall'orecchio destro pendeva un sottile orecchino di diamanti. I miei occhi stavano studiando il picchiettare delle sue dita affusolate sulla tazza quando il francese attaccò bottone: - E così, signor Iracà, vuole ammorbidire l'udito con la calda melodia del pianoforte? - Sì - risposi. E per tradurre quanto da lui domandato: - Mi piacerebbe imparare a suonarlo. - Suona già altri strumenti? - La chitarra, Monsieur Giraud. - Allora avrà le dita già abituate ad una certa coordinazione, immagino... - Proprio così. Ho letto il suo annuncio sul giornale e ho pensato che potesse essere una buona idea. - Je regrette [3], non so suonare il pianoforte. Le sue parole mi lasciarono basito e per poco non mi scivolò la tazza di mano: - Ma sul giornale c'era...! - E' il pianoforte a suonare le note che ho dentro. - ...prego? Camus Giraud prese un sorso, rimase a guardarmi per qualche attimo con la vitalità di un bradipo in corsa. Poi disse semplicemente: - Non si deve imparare a suonare il pianoforte, bisogna imparare a comporre in note quanto si ha da dire, non solo a schiacciare i tasti giusti -, e mi sbirciò con un sorriso da sopra la tazza. - Per quale motivo vorrebbe darsi a questo tipo d'espressione, signor Iracà? Sa, si deve avvertire una necessità molto motivata... Fui quasi tentato di raccontargli una frottola. Un'esibizione all'Hippodrome. Vorrei suonare a casa per il prossimo Natale. Tanti auguri, tanti auguri! Ma il mio animo corrotto da quel puro Shaka Mudaliar che mai avrebbe apprezzato una mia bugia mi convinse di dire solo la semplice verità. - Vorrei imparare non per me stesso, ma per gli altri. - Per un altro. - Per un altro. Credo che gli farà piacere. Ma lei come ha fatto ad indovinare? Vidi che si stringeva nelle spalle, che abbozzava un sorrisetto teneramente ironico. - Continui - si limitò a dirmi, senza dar peso alla mia domanda. - Il suo difetto, quello della vista, a volte mi impedisce di essere spontaneo con lui. Ho paura che non mi capisca ed anzi che non riusciremo a capirci a vicenda a causa del suo problema. Ma in fondo, come dicono tutti, la musica può arrivare ovunque. Io credo... credo che una melodia traduca meglio il sorriso di quanto lo facciano delle labbra che lui non può vedere. Mi tremava la voce e avevo irrigidito le dita attorno alla tazza. Non alzai gli occhi, solo sentii che Camus Giraud appoggiava sul mobiletto la tazza di thé e si alzava. - Andiamo Aiolia - annunciò in tono conclusivo. - Andiamo... dove? - Non si impara a comporre musica stando seduto a una poltrona. Il suo sorriso mi strappò un velo di tranquillità. Finii il thè e passai tutto il dì sui tasti del pianoforte suonando ciò che la visione di Shaka mi suggeriva. Camus Giraud mi disse che avevo del talento. Quando
tornai a casa erano già calate le prime ombre. I lampioni della
via gettavano chiazze di luce sulle strade sfidando il tepore della
sera bristoliana, e si scioglievano soffici sullle siepi del mio
quartiere. Sul vialetto mi venne incontro Diego, che eccitato dal mio
ritorno mi trottò attorno cacciando calde alitate di gioia. Gli
sfregai per bene il muso ottenendo in risposta un mugolio deliziato e
finalmente entrai.
Mio padre era già in casa, vidi il suo soprabito sull'appendiabiti di fianco all'ingresso. Zitto zitto filai in camera e mi spogliai completamente per imbucarmi nella doccia. Era tremendamente magnifico quanto l'acqua mi depurasse da tutti i pensieri che mi crepitavano a fior di pelle. Shaka. Camus Giraud. Sulla via del ritorno avevo incrociato Shura Delgado, ma mi ero limitato ad alzare la mano in segno di saluto prima di fiondarmi in metropolitana. Non avevo avuto voglia di fermarmi a parlare con lui, non in presenza di suo padre che, motivo sconosciuto, mi detestava. Sottrattomi al getto materno della doccia, mi asciugai alla bell'e meglio, mi inflilai un paio di pantaloni e una canottiera e mi buttai sul letto a braccia spalancate. Stop. Ero così stravolto che nemmeno la sconvolta rete di pensieri riuscì a strapparmi alle grinfie di Morfeo. Caddi addormentato quasi subito, all'alba delle sette e trenta di quel pomeriggio, senza neppure curarmi di recuperare una coperta da gettarmi addosso. Passarono altre settimane. Forse quello che vi racconterò ora fu uno dei risvegli più imbarazzanti di tutta la mia vita. Quella di uscire dalla doccia e buttarmi subito a dormire divenne ben presto un'abitudine, ammansito com'ero dall'incontro del fresco delle lenzuola e del mio corpo depurato dai pensieri quotidiani. E fu così, steso sgraziatamente sul letto con indosso solamente un paio di pantaloncini di velluto, che mi trovò Camus Giraud. Perché il Signore avesse concesso proprio a lui la visione di un Me così volgarmente buttato sul materasso non l'ho ancora capito, sta il fatto che accadde. E quando capii, attraverso le nebbie del dormiveglia, che gli occhi fissi su di me erano i suoi, scattai come una molla coprendomi con la coperta neanche fossi una donzella dall'invidiabile decoltè in bella vista. - Camus?? - Bonjour. Era seduto sulla sponda e mi guardava con la testa di poco inclinata e i capelli sciolti sulla schiena. Il suo tono immobile e serafico mi regalò un'esimia sensazione di tranquillità, così tirai un sospiro e mi calmai. Gettai uno sguardo all'orologio: le otto passate. - Che ci fai qui? E di prima mattina, per di più! Non mi pare d'averti invitato, mon chèr. Lui mi sorrise e si alzò. - Ho detto d'essere un tuo amico e tuo padre mi ha fatto entrare. - E tutto questo per ottenere cosa? - Una tua esibizione in salotto. Sbattei le ciglia tre volte più del necessario fissandolo attonito. - Come? - Hai capito benissimo. - Ma adesso non me la sento, mi sono appena svegliato! - Niente storie Aiolia - mi ammonì lui ammiccando in mia direzione con un occhiolino, e uscì dichiarando un focoso: - Ti aspetto dabbasso. Più volte avevo desiderato strozzare Camus Giraud, ma mai come quella volta. Piombava in casa mia e mi ordinava di piazzarmi al pianoforte. Eravano diventati ottimi amici, così perfetti nella nostra diversità, eppure ottimi; come ottima mi parve l'idea di buttarlo fuori dalla porta senza tante cerimonie. Shaka non sapeva che avevo incominciato a studiare musica e avrei voluto mantenere il segreto ancora per un po', perché non mi sembrava d'esser degno della sua attenzione in materia di suono. Mi convinsi però a non pensarci troppo, ben conscio del fatto che mai Camus mi avrebbe concesso ritardi, e mi vestii in fretta e furia cercando in qualche modo di pettinarmi. Quando però feci il mio ingresso in salotto, sulla mia testa troneggiava un Big Ben composto da ciuffi che non volevano proprio starsene al loro posto. Il francese mi vide, sorrise divertito, mi raggiunse e mi passò una carezza sulla criniera riuscendo con quel solo gesto a demolire la torre del Grande Orologio di Westmindster [4]. Mi scoccò un'occhiata d'intesa e si appostò sullo stipite della soglia, a braccia conserte. Non ebbi voglia di aspettare il suo segnale di partenza e mi mossi prima, scivolando a sedere al fianco di Shaka sulla panca del pianoforte. - Buongiorno - mi salutò lui, con quel suo tono candido che tanto amavo. - Il tuo amico Giraud mi ha detto che hai una sorpresa per me. Incrociai il suo sorriso. In quel momento non mi importava che Camus ci stesse fissando da dietro, perché mi sentivo un tutt'uno con chi avevo di fianco. Era come essere in un ritaglio a parte, estraneo alla luce del mattino che filtrava attraverso i tendaggi. Era estate e sedevo al pianoforte con Shaka Mudaliar. Mi importava solo questo. - Ti ha detto bene - gli risposi ricambiando il sorriso. Feci scivolare le dita sui tasti. Il ragazzo indiano dovette accorgersene, complice il suo inspiegabile intuito, perché scorsi un velo di sorpresa sul suo volto. - Non sapevo suonassi il pianoforte. Mi dissi che non ti piaceva. Feci vibrare due o tre corde e aspettai che le note si disperdessero nell'aria prima di ribattere: - E non mi piace, in effetti. Ma qualcuno mi ha fatto capire che l'importante non è ciò che si suona, ma cosa si vuole esprimere. - Giraud? - ...Giraud non è solo un amico. Sbirciai Camus con la coda dell'occhio e gli feci intendere che preferivo rimanere da solo con Shaka. Nei miei occhi vi era anche un briciolo d'innocente riconoscenza, e il rosso la colse senza ritardi, motivo per cui, dedicatomi un ultimo sorriso, scivolò via dallo stipite e svanì nell'atrio. Tornai a guardare il mio coinquilino. - Mi ha insegnato lui a metter giù qualche nota. - "Qualche"? Era una sensazione incantevole. Il buongiorno si vede dal mattino, si dice; e quel giorno, residenti in una stessa pozza di solitudine a noi consacrata, eravamo un noi. - Qualche - confermai in un bisbiglio. - Tu sai sempre tante cose, Sha. Shaka rimase perplesso a quel mio cambio di tono. - Sì, perché le vedo. - ...sai tante cose ma non vuoi ammettere d'essere malato Le sue dita si adagiarono sui tasti. Per come li accarezzava e riempiva d'affetto, avrei voluto che sotto le sue attenzioni ci fosse la mia pelle. Restai a guardarlo finché non si decise a parlare: - E' l'unica cosa che evito di vedere. La malattia. - Glioblastoma. Un mese e mezzo? Cinque settimane...? - Suona - mi fermò, e cogliendomi di sorpresa appoggiò il capo sulla mia spalla e lì trasse un sospiro, con l'atteggiamento di chi chiude gli occhi e nega ogni scomoda realtà. - Suona e vedrai che il tempo non avrà più importanza. E così suonai. Suonai quello che mi venne in mente in quel momento ignorando tutti gli spartiti cui Camus mi aveva sottoposto durante le lezioni. Era una melodia placida, in cui buttavo alla rinfusa tutto quello che avevo da dire. Fu senz'altro una delle mie migliori esibizioni perché il biondo si addormentò sulla mia spalla. Solo quando mi accorsi che il sonno l'aveva vinto smisi di suonare e feci ciò che giorni prima non avevo avuto il coraggio di fare: passai le braccia attorno alla sua vita e strinsi a me Shaka Mudaliar, colui che da quel momento divenne mio fratello nell'anima. Nel salotto di casa Iracà.... *Butta fuori i due piccioncini, il padre, Diego e Camus* Via tuttiiiii che adesso tocca a me U_U Allora, spero che un Camus musicista sia di vostro gradimento ** Personalmente ritengo che sia una professione che gli si addice molto, con tanto di orecchino e capelli legati con dei fiori ----> mia visione di un Camus celestiale xD Il glioblastoma, a onor di cronaca, è un tumore maligno che presenta vari sintomi, dai più comuni, come nausea, vomito, febbre, a quelli più gravi, come difficoltà nel controllo dei movimenti e attacchi epilettici *mode dottoressa on* lol Il titolo di questo capitolo significa "l'udito", pertanto ho fatto in modo, spero bene, di collegare tutto a questa sfera sensoriale, tentando di seguire con una certa logica la crescita formativa del nostro Aiolia attraverso i sensi. Vi lascio in attesa del prossimo capitolo - e nella depressione causa "miei istinti di trame dolci/depresse" xD - che s'intitolerà "de tactu" = potete giusto immaginare cosa potrebbe accadere U_U Alla prossima, perdonatemi per eventuali errori/orrori di battitura, e gracias ** Fe' NOTE Plaisir moi[1] - "Piacere mio" Hippodrome [2] - Teatro di Bristol Je regrette [3] - "Mi dispiace" |
Capitolo 4
*** Parte quarta - De Tactu ***
|
Parte quarta - De tactu
Era una bella mattina d'estate. La classica apertura di una favola a lieto fine, direte voi; ebbene, la stessa sensazione di tranquillità l'ebbi anch'io quando scostai le tende e la luce del dì bristoliano mi trafisse gli occhi ancora intorpiditi dal sonno. Ma cambiai decisamente umore quando, una volta seduto in cucina a sorseggiare del latte fresco, un qualcuno che non subito riuscii ad identificare mi piazzò davanti agli occhi il volantino di una mostra d'arte. La scritta "Arnolfini, Monet's Art Exhibition [1]" troneggiava su un tripudio di colori. A momenti mi scappò la tazza di mano. I musei non mi piacevano (e intanto il latte mi si rovesciò nello stomaco con la violenza del Diluvio Universale) e mai avevo avvertito la necessità di cambiare regola. - Una bella mostra di Monet all'Arnolfini, signor Iracà - mi punzecchiò una voce che ben conoscevo. Sbatte teatralmente le ciglia con l'espressione più inebetita possibile e le labbra mi si schiusero appena: - Camus Giraud. - A rapporto. - Si può sapere che ci fai a casa mia alle sette del mattino? Non mi pare d'averti concesso il trasferimento. - Non mi sono trasferito, appunto. Mi sono invitato. Gli scoccai un'occhiataccia e lui lasciò il volantino sul tavolo scivolando a sedere sulla sedia di fronte alla mia. - Allora non ti va? - Cosa? Camus mi fece un cenno: - La mostra d'arte. Quella su Monet. - Sai benissimo che i musei mi stanno sullo stomaco - risposi secco, e ritornai a dedicare tutta la mia attenzione al latte fresco che mi aspettava nella tazza. Ma evidentemente il francese non aveva intenzione di battere in ritirata, perché accavallò le gambe, appoggiò il mento sul pugno chiuso, inclinò la testa di lato e mi sorrise con squisita ipocrisia. Modalità Maestrino attivata. - Aiolia, verrò anche io... - Rimango molto interessato. - ...forse anche Delgado. - Cento punti in più, certo. - Ah, dimenticavo -, e qui sfoderò un sorrisetto angelico che mi fece accapponare la pelle, - vuole venire anche Sha. La mia fu una reazione alquanto assurda perché fui costretto ad allontanarmi la tazza di bocca per evitare di sbrodolarmi il mento. Mi concessi un colpo di tosse, mi asciugai le labbra con la manica della camicia e tornai negli occhi di Giraud, che aspettavano pazientemente una mia parola; e quella fu: - ...prego? - Shaka Mudaliar, il tuo coinquilino - mi spiegò lui con il tono più rilassato del mondo. - Appena gli ho detto della mostra, ieri, si è subito interessato. Vorrebbe andarci. - Ma... non credo proprio che un museo sia il posto adatto per uno come lui. Mi sentii in imbarazzo, ma il mio Ego si giustificò con la benevola convinzione d'essere statao sincero. Portare un cieco ad una mostra di Monet era per me una sorta di colmo, dopotutto. Camus dovette leggermi nella mente perché gli sfuggì una risata e si alzò: - Tranquillo che gli piacerebbe in ogni caso, ne sono sicuro. Allora? Guardai prima lui e poi il volantino. - Quando? - domandai senza spostare gli occhi dalla scritta. - Anche questo pomeriggio - lo sentii rispondere. - Allora va bene. - Ma non hai una partita di baseball, oggi? - Sul serio? Il mio tono era quasi ironico. Alzai gli occhi nei suoi e gli mostrai che stavo sorridendo. - Non ha importanza. Vada per il museo - conclusi. Dovetti
immergermi nel guardaroba di mio padre per trovare qualcosa di
convincente da indossare. La mia mente non si era mai posta domande sul
"come" attinente ad un certo ambiente,
(ti ricordi quando sei andato in chiesa col costume addosso, Aiolia Iracà?) eppure in quel momento sentivo l'impellente bisogno di armonizzarmi con quanto mi sarei trovato attorno. E così come non si poteva andare in un pub in giacca e cravatta, così non si poteva entrare in un museo in bermuda. A onor di cronaca, forse quella fu la prima volta in cui cominciai a capire l'importanza dell'abbigliamento. Probabilmente la colpa era in gran parte di Camus Giraud, che in ogni occasione riusciva a sposarsi con l'habitat in cui si trovava ad essere protagonista: la sua fede nuziale vincente? I vestiti. Mai una volta che sbagliava un accento su ciò che indossava. Quel francese, ecco, era lo sposo perfetto per ogni tipo di ambiente. Un poco lo invidiavo. Probabilmente fu proprio la gelosia a buttarmi nel guardaroba di mio padre in vista della mostra di Monet. Ne pescai un bel completo bianco, una camicia azzurra e un bel paio di mocassini da figlio di papà. Non che mi piacesse passare per tale, ma il problema era che nella mia stanza avrei trovato solo qualche scarpa da tennis divorata dal tempo. - I capelli - mi ammonì Camus una volta che fui davanti allo specchio a parete. Gli lanciai uno sguardo da cane bastonato e gli soffiai letteralmente addosso: - Hanno qualcosa che non va? - Non si sposano con quanto indossi. - Per me è già tanto essermi infilato questa roba. - Pettinali all'indietro. Una foresta tropicale che domina su una prateria ordinata ed impeccabile non è certo un bell'abbinamento. Feci come mi era stato detto. Non avevo voglia di bisticciare e in poco meno di mezz'ora, piazzato com'ero davanti allo specchio, vidi un altro me. Mi sentivo scomodo nelle fattezze del bravo ragazzo figlio di un avvocato, ma il sorrisetto appagato di Camus Giraud mi confermò che ero perfetto. La mostra d'arte che mi aspettava non stuzzicava i miei sensi da nessun punto di vista. Eppure, il tempo di sedermi sui sedeli posteriori della macchina del francese e già l'idea non mi dispiaceva. Avrei potuto vincere l'oro alla gara di Cambio Idea Troppo Velocemente. L'Arnolfini distava un poco da casa mia, forse una ventina di minuti di viaggio. Ci ero già stato parecchie volte per visite scolastiche, ma mai per conto mio. Speravo tanto che nessuno dei miei conoscenti mi vedesse ridotto così, un biondino infilato in un completo da cerimonia, con i capelli diligentemente pettinati all'indietro e un francese dalle ambigue preferenze sessuali alla guida della macchina su cui viaggiavo. Per non parlare del cane, Diego: Shaka aveva voluto portarselo dietro e io ovviamente non seppi dirgli di no; soprattutto non quando, per tutto il tragitto verso il museo, proprio lui si era concesso un angelico pisolino sulla mia spalla ed io avevo finito col passargli un braccio attorno alle spalle per farlo stare più comodo. Ogni tanto Camus Giraud sbirciava dallo specchietto retrovisore e quando me ne accorsi optai per un bel medio alzato. Ironico ed affettuoso, s'intende, perché il rosso cominciò a ridere e riprese da bravo a guidare. Quella fu anche la prima ed unica volta in cui Diego, su mia gentile concessione, poté spaparanzarsi sul sedile e sonnecchiare contro lo sportello. Stavo diventando veramente troppo buono, eppure la cosa non mi dispiaceva. Scesi dalla Mercedes e mi fermai con il braccio steso sulla portiera. L'Arnolfini non era cambiato di una virgola dall'ultima mia visita (Forse quella volta avevo scorto uno Pterodattilo appollaiato sul cornicione?) e la facciata era della zuccherosa eleganza tipica di ogni museo che si rispetti. Nell'atmosfera invasa dal chiacchericcio dei turisti pescavo i gridi dei gabbiani e l'asprigno profumo del mare, accompagnati dal cozzare degli alberi maestri nel porto poco distante. Diego rotolò buffamente dallo sportello aperto e cominciò a ronzarmi tra le gambe con atteggiamento impaziente. La luce del pomeriggio era così invadente che dovetti schermarmi gli occhi con la mano nel rivolgermi a Camus, smontato in quell'istante dal posto di guida: - Giraud! - Ouais mon cher [2]? - Non possiamo certo portarci dietro il cane, nel museo. Lui rise mentre si infilava la giacca. - La domanda ti ronza in testa da un bel po', eh? - Come? - Starò fuori io con lui - mi rispose rifilandomi un sorriso, e fece cenno al museo con un movimento del capo. - Tu e Sha andate pure, io porterò Diego a passeggio nel parco qui vicino. Mi venne voglia di strozzarlo. Richiusi lo sportello con un botto e Diego fece appena in tempo a ritirare la coda con un mugolio di disapprovazione. - Mica la mostra ti interessava, Cam? - Qualcuno deve pur badare al cagnone - disse facendo girare la chiave. E poi aggiunse immediatamente un: - Ici Merveille... [3]! -, pescando il cane per il guinzaglio e allontanandosi con lui al trotto. A me dedicò solo una scarna sventolata di mano. Seguii con gli occhi il Labrador con l'estatica attenzione del padre che sbircia la figlia ed il nuovo fidanzatino, finché cane e francese non scomparvero nel vialetto del parco dall'altra parte della strada. Merveille. Preferivo non sapere cosa significasse. Lasciai che Shaka mi prendesse a braccetto, com'era solito fare, e insieme ci tuffammo nel trafficato fiume di visitatori che scorreva borbottante fino all'ingresso. E' assurdo come, in un'esperienza che a primo tatto ci pare subito scomoda ed insignificante, si riesca inaspettatamente a trovare uno spunto interessante. Anche oggi mi ritrovo a pensare che quella visita al museo fu proprio un'esperienza del genere. Ebbene, quel giorno l'unico accento degno di attenzione lo posi su un aspetto che mai mi sarei aspettato di prendere in considerazione; un aspetto che non c'entra nulla con Monet ma che mi interessò più della mostra. L'atteggiamento di Shaka Mudaliar. Fu spaventoso realizzare che lui vedeva meglio di me i quadri davanti cui ci soffermavano. Lui vedeva e io mi limitavo a guardare. Leggevo sul suo volto l'espressione di chi veramente si trova in un campo di grano, o su un ponte immerso nel verde, mentre io, pur possedendo certo il senso della vista, riuscivo a malapena ad apprezzare i colori di quel che avevo di fronte. Tra i due quella volta il cieco fui io. Non capivo come fosse possibile partorire un pensiero del genere, (Lui non vede, non vede, Aiolia!, non può vedere!) eppure questa scomoda consapevolezza mi si arrampicava sulla schiena e mi stritolava lo stomaco. Quando lo vedevo sorridere capivo che non era perché io ero al suo fianco, ma perché Monet, senza parlare e senza essere fisicamente presente, riusciva a fargli vedere nonostante quelle palpebre eternamente abbassate. Eravamo seduti su una cassapanca imbottita, faccia a faccia con "La Promenade sur la Falaise [4]", quando lui, con la braccia abbandonate sulle ginocchia e un candido sorriso a fior di labbra, mormorò: - Mi sembra di non conoscere questo quadro, Aiolia. - No? - mi agganciai io in un bisbiglio, sotto l'ordine delle luci abbassate e del religioso silenzio che dominava in quell'angolo di mondo. - Ne sei sicuro? - Sicurissimo. Ora che osservavo meglio, colsi sul suo volto un'espressione quasi perplessa. Il quadro allora non lo conosceva proprio. - "La Promenade sur la Falaise" - gli dissi, facendo ricorso alla mia scarsa abilità con il francese. Shaka negò appena con il capo: - Zero assoluto. - Se vuoi provo a descrivertelo. Abbracciai il suo silenzioso assenso e mi umettai le labbra. Sapevo cosa dovevo fare: se lui riusciva a vedere ad occhi chiusi, io avrei fatto la stessa cosa. - E' caldo. C'è un poco di brezza, ma giusto un poco, Sha, e profuma d'estate. Ma non di quella di Bristol, è un'estate più frizzante, che si trascina verso l'autunno portando con sé il profumo delle campagne. Siamo su uno spuntone chiazzato di fiori di campo, davanti al mare. Ti dirò -, e mi sfuggì una lieve risata, mentre i miei occhi guizzavano a cogliere il sorriso soddisfatto di Shaka, - non so che mare sia, ma ci sono tante schegge di schiuma bianca. Un paio di onde. Non siamo in alto, il loro accavallarsi ci tuona nelle orecchie. Sotto di noi prende il volo la salsedine. - Ho paura di cadere. - Il cielo è limpido, chiazzato da nuvole. Sembra troppo vicino, non ci permetterà di cadere. - Che mi dici dei fiori? - Rossi, viola... ma adesso che mi chino e tocco bene, gran parte dell'erba è fulva. - E' quasi autunno, allora avevi ragione. - Già, e si è alzato il vento. Lo vedi, l'orizzonte? - Da qui sembra vicinissimo. - Allora restiamo un po' qui a guardarlo? - Aspetta Aiolia. La brezza si è fatta più birichina. Lo vidi ridere. Mi sentii benissimo. Gli passai un braccio attorno alle spalle e gli permisi di accoccolarsi a me. Fui meravigliato di cogliere, al contatto con la sua pelle, i brividi di freddo che gli rotolavano sulla carne. Trassi un respiro e rimasi con lui sullo spuntone erboso. I fiori di campo. Il mare. Il cielo e le soffici nuvole. Alla fine un po' di freddo venne anche a me, ma non smisi di sentirmi in Paradiso. Uscimmo dall'Arnolfini solo verso sera. Una volta fuori mi stupii nel vedere Shura Delgado intento a stropicciare il musone di Diego, che a sua volta uggiolava mielosamente e sferzava l'aria con la coda. Il tramonto di Bristol si scioglieva allora in deliziose sfumature rosso-arancioni nel porto e dietro le fronde delle querce. - Buonasera Aiolia - mi salutò Shura lanciandomi un sorrisetto da bravo ragazzo al di sotto dal basco a scacchi. - Giretto al museo? - A quanto pare. Tu che ci fai qui? - Ho incrociato Giraud al parco, tutto qui -, e poi si drizzò in piedi e si stiracchiò la schiena. - Interessante, il Monet? - Non male - fu la mia schiva risposta. Shaka, che aveva pescato dal mio tono una nota di apprezzamento, mi sorrise di striscio e scivolò a sedere nell'abitacolo. Io mi occupai di sbrigliare il guinzaglio di Diego e di trascinarlo in macchina contro la sua volontà, dal momento che sembrava più intenzionato a festeggiare l'incontro con il suo padrone originario che a fare il bravo cagnone. Quando riuscii nell'impresa, richiusi lo sportello e me ne stetti fuori, appoggiato sul cofano, a fumarmi una Philip Morris prontamente offertami da Delgado. Parlammo un po', io e lui, con il fumo a fiorirci sinuoso dalle labbra. A dire il vero saltammo su tutte le giostre rinunciando a quella di nome "Aiolos Iracà", perché ben sapevo che lo spagnolo mal avrebbe sostenuto un discorso del genere, ed io non potevo certo biasimarlo. Giraud fu gentile nel concederci una completa pausa sigaretta e mi fece saltare in macchina solo dopo ch'ebbi schiacciato per terra l'ormai consumato spuntino. Così salutammo Shura e ritornammo vittoriosamente a casa, giusto in tempo per una bella cena a base di spaghetti all'italiana. Immancabilmente, Camus si trattenne con noi fino a tardi, quando finalmente levò baracca e burattini e rimontò sulla Mercedes. Quando mi infilai in doccia, quella stessa sera verso le dieci, la mia mente era già scappata al mondo dei sogni. Mi pareva di aver pensato troppo e i miei neuroni, ubriachi di stanchezza, si aggrappavano alla massa cerebrale per non cascare nel regno di Morfeo. Mi stavo asciugando i capelli con un asciugamano quando sentii la porta della mia camera aprirsi. Arricciai le labbra, sfidando l'espressione incuriosita del me stesso riflesso allo specchio, e mi infilai una canottiera e dei pantaloni acciuffati a casaccio prima di lanciare un'occhiata fuori dal bagno. - Uhm? Sha? Shaka si era appena seduto sul mio letto ed aveva alzato il capo al sentire la mia voce. - Scusami Aiolia - mi rispose allungando un sorriso chissà perché imbarazzato, - volevo solo farti vedere una cosa. Non ti ho disturbato, vero? - Tranquillo - lo benedìì io, e mi richiusi in bagno giusto il tempo di buttare l'asciugamano sul mobile prima di fare capolino in camera e sedermi di fronte a lui a le gambe incrociate: - Dimmi tutto. Eravamo accomodati faccia a faccia come dei bambini che giocano ai pirati, io con le mani artigliate alle caviglie e lui immobile, a guardare il vuoto, anzi no, a guardare me, senza rinunciare a quel suo serafico sorriso. Allungò verso di me quella che sembrava una superficie solida velata dal foulard verde. - Dove lo hai preso? - gli domandai a bruciapelo. - Chi? Cosa, Aiolia? - Il foulard. - Era nel taschino interno del completo che hai indossato oggi. Deve aver sentito anche lui tante cose interessanti, all'Arnolfini. - Sì... forse. Certo che era come essere bambini. Parlavamo piano, consapevoli dell'ora tarda, (orecchie rizzate al benché minimo suono di passi sulle scale, attenti a mamma e papà!) con la luce del lampadario che ci pioveva addosso e teneva ben lontana l'oscurità della notte estiva in cui fischiavano le cicale e qualche clacson lontano. - Ha tante cose da dirci - riprese Shaka sempre tendendomi l'oggetto velato. - Il foulard? - Sì, lui. - Secondo me ha origliato parecchio. Lui rise. In quel momento la sua pelle mi parve improvvisamente più pallida. Fu una sensazione orribile, ma non volli darle peso. Così sorrisi e aggiunsi: - Cosa volevi farmi vedere? - La vista, Aiolia - attaccò lui affilando appena il tono di voce, che pur rimase soffice e carezzevole, - non è altro che la somma di tutti gli altri sensi. Ciò che vediamo è esattamente ciò che sentiamo, tocchiamo, odoriamo e gustiamo allo stesso momento. E tutte queste sensazioni formano la capacità elaborativa del nostro cervello. - Sha, che stai...? - Ecco perché io vedo. Purtroppo gli esseri umani abusano troppo della vista e tendono ad emarginare gli altri sensi. Qusto mondo è costruito sulle fondamenta dell'esteriorità, te ne sei reso conto? - Sha, ma...? Sì. La risposta mi uscì spontanea. Mi sentii a disagio e non seppi il perché. - Ti insegnerò a vedere - mormorò Shaka, e mi prese per mano. Era un tocco delicato e freddo. Morto. Il primo istinto fu quello di allontanarlo, ma qualcosa dentro di me ammansì questa mia reazione sconsiderata. Lasciai che guidasse le mie dita sulla superficie velata e stendesse il palmo sul dorso della mia mano. Allora avvertii del calore. Mi sentii subito meglio. - Cosa vedi, adesso? - mi domandò in un bisbiglio, inclinando il capo e sorridendo mite. Sostenni per un istante il suo sguardo. Le mie iridi tremavano appena. Stupido me. Poi abbassai gli occhi sul foulard, o meglio, su ciò che il foulard copriva. Premetti le labbra in un gesto di intensa perplessità prima di rispondere: - Sento il mare. Avverto i fili d'erba sotto le mie dita. Il profumo della salsedine nelle narici. Il gusto rustico dell'autunno sul palato. Vedo -, e in quel momento mi percorse un brivido, un fremito incondizionato mi solleticò le corde vocali: - ...vedo che l'orizzonte è troppo vicino. Allora Shaka chiuse la mano sulla mia e mi sorrise. Era un sorriso meraviglioso. - Se ci teniamo per mano non cadremo - mi disse. Quelle parole le ricordo ancora. Ricordo tutto di quel momento. Indimenticabile il formicolio che mi velò lo sguardo. Indimenticabile proprio come le sue labbra di pesca sulle mie, come la melodia del nostro silenzio, le carezze delle nostre lingue, il profumo della sua pelle, il gusto della sua saliva. Il foulard scivolò via delle nostre mani quando mi lasciai avvolgere da quel momento e mi coricai con lui. Sotto al verde del fazzoletto, a sbirciarci taciturno, c'era l'orizzonte della Promenade sur la Falaise. Nel salotto di casa Iracà... Signore care, eccovi il regalo di Pasqua! Era anche ora, contando che sono estremamente in ritardo. Ho avuto un problema all'occhio, un sacco di studio, un nuovo anime da seguire... insomma un sacco di distrazioni XD Alors, cominciamo con il dire che il capitolo mi è scivolato via dalle dita come petali al vento, nel senso che avevo già tutto in mente e quindi non è stato particolarmente impegnativo. Spero sia di vostro gradimento, e come al solito chiedo venia per eventuali errori/orrori di battitura ** Il prossimo sarà l'ultimo capitolo, credo più corto degli altri, e avrà titolo "de visu", ergo la tanto sospirata vista! °v° Ecco a voi le note, cui aggiungo anche il quadro di Monet, "La Promenade sur la Falaise", uno dei miei preferiti ** Auguri di buona Pasqua! Fe' NOTE Arnolfini, Monet's Art Exhibition [1] - Arnolfini (museo d'arte di Bristol), mostra d'arte di Monet. "Ouais mon cher?" [2] - "Sì mio caro?" "Ici Merveille...!" [3] - "Qui Meraviglia...!", riferito al cane. La Promenade sur la Falaise [4] - quadro di Monet  |
Capitolo 5
*** Parte quinta - De Visu ***
|
Parte quinta - De visu C’è a volte un velo particolare,
nell’espressione delle persone, un misto fra ansia e serenità. È questo il
classico atteggiamento di chi mente senza volerlo, o per meglio spiegarmi, di
chi mente ma vuole a tutti i costi accendere nell’interlocutore il dubbio dell’inganno;
di chi dice una bugia con l’obiettivo sì di parere sincero, ma con la singolare
– e brutale – finalità di far intendere dell’altro.Ci sono vari modi per mentire in
questo modo, senza alcuna pietà. C’è chi se ne sta serio, chi è spontaneo, chi
ancora ficca le mani in tasca e stringendosi nelle spalle lo annuncia.
Solo quando Camus Giraud rientrò senza Shaka mi ricordai che quella frase, quella maledetta frase, mi era stata detta anche da Aiolos. Con il piccolo difetto che poi non era tornato a casa. (E tu non vuoi perdere Shaka, vero? Non vuoi, non dopo che l’hai abbracciato, l’hai baciato, l’hai accettato come fratello, vero?) - Giraud...? - Lascia che ti spieghi. La classica frase di chi invece non ha intenzione di spiegarti un bel niente. Il copione che contiene questa battuta prevede anche che la situazione degeneri; ebbene la situazione andò come doveva andare, con la mia mano corsa ad artigliare il colletto di Camus Giraud e il tipico strattone con cui si sbatte qualcuno al muro. - Dov’è? - Aiolia, toglimi le mani di dosso. Io ho solo fatto quello che voleva lui. - E cosa voleva? Cosa accidenti voleva...? - Anche tuo padre era d’accordo. - Oh bene! – grugnii lasciando di colpo la presa per evitare di strozzarlo a mani nude. – Qui si prendono decisioni senza che nessuno mi dica niente! Il pianista m’inquadrò con sguardo sofferente. Si sistemò il colletto, si schiarì la voce, non perse di lucidità: - In Italia. Tutta la rabbia che avevo in corpo si sciolse d’improvviso per lasciare spazio ad un sentimento intraducibile. Stupore, preoccupazione, incredulità. - ...Italia? - Al Teatro alla Scala di Milano. Mi ha chiesto di portarlo all’aeroporto ed io ho esaudito la sua richiesta. Poi il furore tornò con l’imminenza con cui era svanito. Lo scaricai tutto contro il muro, a un filo dalla tempia di Camus Giraud. Quasi avvertii la parete tremare. - Mi spieghi cos’è andato a fare in Italia? E nemmeno senza dirmelo! Il francese non si mosse di un millimetro. Sebbene il mio pugno gli avesse fatto fischiare l’orecchio, rimase impassibile ed anzi socchiuse appena gli occhi. – Non voleva che tu lo sapessi. Tu non gliel’avresti permesso, non negarlo – rispose all’immobilità del silenzio. - Camus. Ho bisogno di sapere perché. Qualcosa nelle mia voce doveva essere cambiato perché sentii la mano di Camus Giraud adagiarsi sulla mia spalla. Tremavo. Prima la rabbia, poi lo stupore, poi di nuovo l’ira, e adesso? Contenni il brivido salato delle lacrime. - Perché suonare alla Scala è il suo sogno più grande. E perché sarà la sua ultima esibizione, Aiolia – fu quello che mi disse. - E perché non vuole che io lo veda... Che io lo veda e basta, sì, è giusto. Avevo fatto bene a frenare la lingua: almeno con le parole non dovevo dar retta alla realtà. Tanto che male c’era? Io ero rimasto in Inghilterra, lui stava volando verso l’Italia. Sapevo che era fiero di me perché gli aveva implicitamente concesso di partire, e questa era una consolazione. Solo dopo aver annaspato si impara a nuotare. Io sapevo nuotare, ma le lacrime, quella sera, mi dimostrarono il contrario. L’aria di Bristol era indolente.
Fischiava sulla cima degli alberi, vibrava sotto alla luce fioca dei lampioni,
strisciava fra i cespugli. Ero uscito per prendere una boccata d’aria e già il mio
orologio segnava le undici di sera. Una boccata d’aria un po’ lunga, Mr. Iracà.
Mi sedetti sul bordo di un marciapiede e rimasi ad ascoltare il silenzio. La
trasparenza ha tanto da dire, soprattutto quando sei tu a voler star zitto.
Stavo ancora prestando orecchio al serpeggiare del tempo quando il telefonino
mi annunciò l’arrivo di un nuovo messaggio. Non che avessi molta voglia di
leggere, ma con la lentezza di un automa estrassi l’apparecchio dalla tasca dei
jeans e me lo portai davanti agli occhi.
"Ha appena chiamato a casa. Ti cercava. E tu non gli hai dato il tuo
numero, vero?”
- Vero – mi risposi da solo.
presente Mi sono lasciato alle spalle mio
padre, il suo sguardo stanco, come mi sono lasciato alle spalle tutti gli altri
pensieri. Varcare la soglia mi sveste inspiegabilmente di ogni preoccupazione.
Futuro, trent’anni dopo Sono tornato in Italia. Come da promessa. Nel salotto di casa Iracà... Sono
proprio fiera di aver terminato questa FF. Mi sono affezionata ai
personaggi e spero che anche per voi sia lo stesso °v° Fe' |